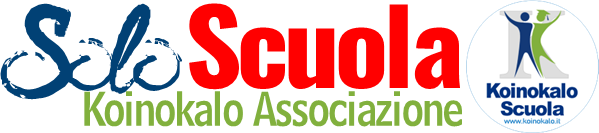Era il 1974 quando il professor Frank Sherwood Rowland, docente di chimica all’Università della California, e il suo assegnista di ricerca Mario Molina pubblicarono su Nature uno studio allarmante: alcuni gas artificiali, i clorofluorocarburi (CFC) rischiavano di distruggere lo strato di ozono in alta quota. L’allora amministratore delegato della DuPont – la società che aveva brevettato quei gas col nome di “freon” nel 1930 – obiettò che quella teoria era «un racconto di fantascienza, un carico di spazzatura, un’assurdità totale». La lotta contro il buco nell’ozono dunque, iniziava in salita, contrastata da forti interessi economici. Come si era arrivati fin lì? E cosa è successo poi?
Ieri, il numero di Focus del 1992 raccontava la mobilitazione degli scienziati da quando nel 1976 fu scoperto il buco ciclico dell’ozono al Polo Sud dal team del British Antarctic Survey
Quando, alla fine del 1992, Focus scrisse un articolo su questo argomento, la lotta al buco nell’ozono era già iniziata. Il Protocollo di Montreal, che vietava i CFC, era entrato in vigore da 3 anni, prevedendo un’adesione a due velocità: immediata per i Paesi sviluppati, dilazionata per gli altri. A quell’epoca c’erano ancora 40 aziende – compresa una in Italia, l’Ausimont, del gruppo Ferruzzi-Montedison – che producevano queste pericolose sostanze. Avrebbero potuto andare avanti fino al 1995; dal 2010 il bando avrebbe avuto un’adesione planetaria.
Che cos’è il buco dell’ozono. La scienza aveva scoperto che una molecola di CFC impiega sei anni per passare dal livello del suolo all’alta atmosfera, dove poi rimane per circa 100 anni distruggendo fino a 100mila molecole di ozono: il cloro si lega a una molecola di ozono, spezzandone i legami, per poi legarsi a un’altra molecola, in un ciclo senza fine. «È come un assassino che, dopo un delitto, torna libero di colpire di nuovo», spiega Ugo Cortesi, dell’Istituto di fisica applicata Nello Carrara del Cnr a Sesto Fiorentino. Un vero guaio: senza l’ozono, che filtra i raggi ultravioletti, si moltiplicano i rischi di sviluppare melanomi e cataratta. Anche se è uno scudo sottilissimo: se si concentrasse l’intera atmosfera alla temperatura di 0 °C e alla pressione di 1 atmosfera, l’ozono formerebbe uno strato di 3 mm su un totale di 8 km.
La scoperta di questa minaccia planetaria era avvenuta quasi per caso. Il professor Rowland si era messo a studiare i CFC – usati come gas refrigeranti in frigoriferi e condizionatori perché non infiammabili, stabili e poco tossici – grazie a un’invenzione di James Lovelock, medico dell’Università di Reading: il rivelatore a cattura di elettroni. Con questo strumento aveva trovato tracce di CFC in atmosfera.
Chi ha scoperto il buco dell’ozono? Pochi anni prima il chimico Paul Crutzen dell’Università di Oxford aveva scoperto che il protossido di azoto, prodotto dai batteri del suolo e dagli aerei, assottigliava lo strato di ozono: Rowland voleva verificare se i CFC avessero un effetto simile. Gli studi lo confermarono. Nel 1976 la National Academy of Sciences degli Stati Uniti confermò la credibilità delle ipotesi di Rowland e Molina, e nel 1978 – nonostante le forti pressioni dell’industria – gli Usa vietarono l’uso di CFC. Fu un atto di fiducia verso la scienza: le osservazioni che confermarono l’ipotesi dei due scienziati arrivarono solo negli anni successivi.
La posta in gioco, del resto, ovvero la salute dell’umanità, era alta: gli attivisti di GreenPeace organizzarono manifestazioni a tappeto per tener desta l’attenzione del mondo sulla minaccia. E fecero bene: nel 1985, a 11 anni dalla ricerca di Rowland, gli scienziati del British Antarctic Survey Joseph Farman, Brian Gardiner e Jonathan Shanklin scoprono un buco nell’ozono ricorrente in primavera sul Polo Sud. Un evento mai osservato: tanto che, all’inizio, pensarono che i loro strumenti fossero difettosi. Anche le misurazioni fatte dai satelliti erano state scartate dagli algoritmi automatici perché considerate troppo basse per essere attendibili. Lo strato “normale” di ozono misura 300 unità Dobson (DU), pari ai 3 mm di cui sopra. Prima del 1979, i ricercatori non avevano mai osservato concentrazioni inferiori a 220 DU.
Come viene distrutto l’ozono. Ora, durante la stagione fredda, lo strato diventava molto sottile. Troppo: nel 1991 sarebbe sceso per la prima volta sotto i 100 DU; nel 1994 si è registrato il record negativo (per fortuna mai più eguagliato) con 73 DU. In più, la ricercatrice Susan Solomon, del Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), scoprì un meccanismo aggiuntivo di distruzione dell’ozono nelle nubi polari: si formano a temperature molto basse (-80 °C) e contengono composti inattivi del cloro; quando a primavera i raggi solari le colpiscono, attivano reazioni chimiche che formano molecole di cloro attive (monossido di cloro) che distruggono l’ozono. E scoprì pure che le eruzioni vulcaniche assottigliano l’ozono perché producono acido cloridrico e cloro: l’eruzione del Pinatubo nel 1991 ha contribuito a ridurre lo strato di ozono per anni.
Mario Molina (1943-2020) è lo scienziato che ricevette il Premio Nobel per la Chimica 1995 insieme ai colleghi Frank Sherwood Rowland e Paul Crutzen “per il loro lavoro nella chimica atmosferica, legata in particolare alla formazione e alla decomposizione dell’ozono”.
© Wikimedia
Tutte le ricerche, insomma, convergevano su un punto comune: ampie aree della Terra rischiavano di restare prive dello schermo protettivo dell’ozono. Nel 1987 le prime 90 nazioni firmarono il Protocollo di Montreal (oggi sono 197, ossia tutti i Paesi rappresentati all’Onu) che sanciva il bando dei CFC. Proprio in quell’anno, infatti, era stata trovata la “pistola fumante”: gli aerei Nasa decollati dal Cile avevano prelevato campioni d’aria in alta atmosfera al Polo Sud, trovando le tracce del cloro emesso dall’industria. Restava però da trovare un’alternativa ecologica ai CFC per i sistemi di refrigerazione. Nel 1992, come riferiva l’articolo di Focus, il mondo puntava sugli idrofluorocarburi (HFC): negli anni successivi, però, la ricerca ha scoperto che sono potenti gas serra. Nel 2016 sono stati inseriti nella “lista nera” in un emendamento al Protocollo di Montreal.
Il freezer di greenpeace. Per fortuna, però, era emersa una soluzione più ecologica. All’Istituto di Igiene di Dortmund, in Germania, alcuni ricercatori studiavano i refrigeranti a base di idrocarburi naturali usati negli anni ’30, prima dell’avvento dei CFC. Scoprirono che l’isobutano era sicuro per l’ozono e per l’effetto serra. La molecola, chiamata GreenFreeze, vinse il premio ambientale indetto dall’Istituto. Un attivista di GreenPeace, Wolfgang Lohbeck, appresa la notizia cercò una fabbrica di frigo disposta a utilizzarla, ma trovò solo porte chiuse: gli idrocarburi infatti erano percepiti come infiammabili, anche se la tecnologia aveva eliminato questo rischio. L’unica azienda disposta a produrre i nuovi frigoriferi fu la DKK Scharfenstein, una vecchia fabbrica della Germania Est.
I produttori di frigo con HFC fecero una campagna di delegittimazione, dicendo che i GreenFreeze erano «divoratori di elettricità» e «potenziali bombe» nelle cucine. Ma GreenFreeze ottenne l’appoggio del governo e degli scienziati. E nel 1993, pochi mesi dopo l’uscita di Focus, i primi 70mila GreenFreeze uscirono dagli stabilimenti tedeschi. Per conquistare il mondo: la tecnologia GreenFreeze non fu brevettata per favorire la sua diffusione industriale planetaria. «Fu la dimostrazione», ricorda Giuseppe Onufrio, direttore di GreenPeace, «che le lotte per l’ambiente servono a tenere desta l’attenzione sui problemi; ma si vincono solo se sono supportate da accordi commerciali e di cooperazione tecnologica. All’epoca del Protocollo di Montreal, i brevetti per la produzione di CFC erano scaduti: Cina e India avrebbero potuto fabbricarli senza ostacoli. Con GreenFreeze hanno avuto un’alternativa conveniente».
Le sostanze nemiche. Così la battaglia contro il buco nell’ozono ha imboccato una strada virtuosa: nel 1995, gli scopritori delle sostanze che distruggono l’ozono, Crutzen, Molina e Rowland, ricevettero il Nobel per la chimica. Sull’attestato di Molina c’è il disegno di un ombrello: il simbolo della protezione dello strato di ozono. Ma la lotta per tenere integro quell’ombrello non è ancora finita.
Oggi la scienza prevede che il buco dell’ozono tornerà integro per il 2060. Ma bisogna sempre vigilare perché si scoprono sempre nuove fonti di sostanze che minacciano l’ozono
L’ultimo allarme è del 2018. Un ricercatore del Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), Stephen Montzka, denuncia dalle colonne di Nature un aumento di emissioni di CFC-11: il triclorofluorometano, un gas della famiglia dei clorofluorocarburi vietati dal Protocollo di Montreal. La ricerca si mobilita, e si scopre la pistola fumante: quelle emissioni, registrate fra il 2014 e il 2017, arrivavano dalla Cina. Più in dettaglio, dai dati rilevati da stazioni di monitoraggio dell’aria in Corea del Sud e in Giappone, si scopre che 7mila tonnellate di quel gas arrivavano da stabilimenti nella provincia dello Shandong, in Cina Orientale.
Che cosa dice il Protocollo di Montreal. Lo studio, uscito su Nature e firmato da ricercatori dell’Università di Pechino, ha destato grandi preoccupazioni: quelle emissioni abusive rischiavano di allungare di 6 anni il pieno recupero del buco dell’ozono, stimava in uno studio una ricercatrice del Mit, Megan Lickley. Ma la reazione delle autorità cinesi è stata immediata: alle riunioni periodiche sull’attuazione del Protocollo di Montreal i rappresentanti dello Stato asiatico hanno riferito di aver demolito le “fabbriche canaglia”, sequestrato i materiali e arrestato i responsabili.
Dal dossier Come sta l’ozono, di Vito Tartamella, con i seguenti articoli: La scoperta del “buco”; L’ozono sta guarendo ma…; … rimane un vigilato speciale, pubblicati su Focus 353 (marzo 2022).
© Focus
In effetti, già nel 2019 le emissioni di CFC11 erano sparite, annullando il rischio di ritardo nella tabella di marcia verso il pieno recupero dello strato di ozono. «Dobbiamo tener presente che qualsiasi emissione non dichiarata di sostanze dannose avrà un impatto ambientale duraturo», precisa Matt Rigby, scienziato dell’atmosfera dell’Università di Bristol. «Purtroppo, è probabile che solo una parte dei gas prodotti sia stata rilasciata in atmosfera: il resto potrebbe essere ancora imprigionato nella schiuma degli edifici (il CFC-11 è usato anche come isolante, ndr) e diffondersi nell’aria nei prossimi decenni». La lotta al buco dell’ozono, insomma, è tutt’altro che terminata. Anche perché negli ultimi 30 anni la ricerca ha fatto molte scoperte al riguardo: che il “buco” può formarsi in modo stagionale anche sopra l’Artico. Che altre sostanze finora trascurate contribuiscono a intaccare il sottile strato di ozono. E che anche i cambiamenti climatici possono avere effetti negativi sull’ozono.
Lo strato d’ozono sta guarendo? Ma prima di raccontare tutto questo, a 33 anni dall’entrata in vigore del Protocollo di Montreal una domanda si impone: lo strato d’ozono sta guarendo? Entro quando tornerà integro? A guardare i grafici dal 1979 non si direbbe che si stia riprendendo: i “buchi” che si sono formati nel 2020 e 2021, tra l’altro, sono stati fra i più duraturi misurati fino a oggi. «L’ultima valutazione scientifica dell’Organizzazione Meteorologica mondiale indica che il pieno recupero in Antartide dovrebbe avvenire entro il 2060», risponde Vincent-Henri Peuch, direttore del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, il programma europeo di monitoraggio dell’atmosfera. «Per la fine dell’anno è previsto un aggiornamento di questa previsione: le recenti proiezioni potrebbero cambiare leggermente questa data, ma non in modo sostanziale».
Già nel 2016 uno studio su Science condotto da Susan Solomon, chimica dell’atmosfera al Mit di Boston, aveva dimostrato che negli ultimi 15 anni la dimensione del buco dell’ozono sopra l’Antartide si è ridotta di circa 4 milioni di km quadrati, come la superficie dell’Unione Europea. «Lo strato di ozono è in ripresa e i livelli di sostanze dannose per l’ozono stanno diminuendo», conferma Ugo Cortesi del Cnr. «La messa al bando dei CFC è stata fondamentale per arrestare un fenomeno che avrebbe potuto raggiungere dimensioni drammatiche. I segni di contenimento sono innegabili, ma l’assottigliamento dell’ozono non è sparito: bisogna ricordare, del resto, che le molecole di CFC rimangono in stratosfera fino a 100 anni, durante i quali continuano a esercitare la loro azione distruttiva».
Un’azione resa possibile e potenziata dalle temperature molto rigide che raggiungendo i -80 °C consentono la formazione delle nubi stratosferiche polari. Quando a primavera arriva il Sole, la luce scompone i composti del cloro rendendole molecole attive che vanno a distruggere l’ozono. Per questo motivo, il buco si forma per lo più sopra l’Antartide, dove le correnti favoriscono il raggiungimento di temperature più rigide.
La situazione al Polo Nord. Ma, occasionalmente, un buco si forma anche sopra l’Artico, quando le correnti d’aria fredda permangono più a lungo intorno al Polo durante l’inverno boreale: si è formato nel 1997, nel 2004, nel 2011. L’ultimo risale al 2020, ed è stato il più grande mai registrato: 23 milioni di km quadrati. «Il buco sopra l’Artico è più raro, meno duraturo e meno profondo, ma desta più preoccupazioni rispetto a quello sull’Antartide», commenta Cortesi. Perché? «Perché arriva a lambire terre più densamente abitate rispetto a quanto accade nell’emisfero opposto. Il buco sopra l’Antartide, nella sua massima estensione, tocca la punta del Sud America e dell’Australia; ma quello sull’Artico si spinge fino alla Scandinavia, alla Russia, all’Alaska e al Canada. Le persone potenzialmente a rischio di ricevere più raggi ultravioletti sono molte di più nell’emisfero Nord».
Uno scenario, questo, reso ancora più complesso dal cambiamento climatico: mentre le temperature sulla superficie del Pianeta aumentano per l’azione dei gas serra, quelle nella stratosfera, dove si concentra l’ozono, stanno calando sempre più. Favorendo la formazione di nubi stratosferiche ai Poli, dove si concentrano le sostanze dannose per l’ozono. Insomma, un circolo vizioso che dà una ragione in più per non abbassare la guardia nel monitoraggio dell’ozono.
Le dimensioni e la concentrazione del buco dell’ozono sull’Antartide variano di anno in anno. In questi grafici, l’andamento medio dal 1979 al 2021: sono evidenziati i tre anni con gli scenari peggiori, in termini di estensione e di spessore dell’ozono.
© Focus
E, come se non bastasse, si scoprono sempre nuove fonti di sostanze che minacciano l’ozono: in una ricerca uscita all’inizio del 2022 su Nature Communications, ricercatori dell’Università della California hanno scoperto che bromuro e cloruro di metile, due composti noti per distruggere l’ozono, hanno molte fonti di cui finora non si era tenuto conto: i composti a base di rame rilasciati nell’ambiente da fungicidi, pastiglie dei freni, vernici, pesticidi.
«Circa un terzo del bromuro e del cloruro di metile in atmosfera proviene da fonti sconosciute», ha detto Robert Rhew, docente di scienze ambientali. «Si prevede che l’uso di rame nell’ambiente aumenterà rapidamente nei prossimi anni e se ne dovrà tenere conto ai fini del recupero dello strato di ozono». «Non si può escludere il rischio di altre emissioni di sostanze dannose per l’ozono», conclude Peuch. «Perciò è importante mantenere alti gli sforzi di monitoraggio dell’atmosfera».
Domani controlleremo la guarigione dello strato di ozono con stazioni a terra più capillari e satelliti più sensibili
Osservazioni sempre più precise e capillari. E nuove ricerche sulla chimica dell’atmosfera. Sono queste le armi con cui salveremo l’ozono nei prossimi decenni. Partendo dagli strumenti che per primi hanno confermato la riduzione dell’ozono: i satelliti. Oggi quelli che ne osservano la concentrazione sono molti: ne deducono la quantità andando, ad esempio, a misurare quanti raggi ultravioletti sono assorbiti dall’atmosfera. Più luce UV passa, meno ozono è presente. In questo modo i satelliti possono misurare la quantità totale di ozono e la sua distribuzione verticale. Nei prossimi anni, nuove missioni spaziali forniranno dati di ozono «in quantità e qualità senza precedenti», annuncia l’Agenzia Spaziale Europea (Esa).
Come potremo esaminare l’atmosfera. Dal 2024 sarà operativo Sentinel-5 di Copernicus, il più ampio programma di osservazione della Terra mai realizzato. E nel 2025, l’Esa lancerà Altius, una missione per la misura dell’ozono finanziata dal Belgio con contributi da Canada, Lussemburgo e Romania. «Volerà in orbita bassa», spiega Ugo Cortesi, membro del gruppo consultivo delle missioni Sentinel-4/-5. «La sua geometria di osservazione gli consentirà di guardare in direzioni tangenti a diversi strati dell’atmosfera. Così sarà possibile stabilire le concentrazioni di ozono alle varie quote. Farà una sorta di Tac all’atmosfera».
Il satellite Altius che l’Esa manderà in orbita nel 2025 per monitare l’andamento del buco dell’ozono.
© Focus
Ai satelliti si affiancherà il monitoraggio fatto dalle stazioni a terra: la Global Atmosphere Watch dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo). La rete è composta da 30 centri di controllo sparsi in tutto il Pianeta: grazie a loro è stato possibile scoprire le “fabbriche canaglia” che, in Cina, emettevano sostanze dannose per l’ozono. «Nei prossimi anni sarà importante espandere la rete esistente per rendere più capillari e tempestivi i controlli», aggiunge Vincent-Henri Peuch, direttore del Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Anche perché, come dimostrano le ultime ricerche sulle emissioni di bromuro e cloruro di metile, c’è ancora molto da imparare sulle sostanze che danneggiano l’ozono.
le osservazioni dei satelliti. Una ricerca recente dell’Ucar (University Corporation for Atmospheric Research) ha stabilito che se scoppiasse una guerra nucleare globale cancellerebbe ¾ dell’ozono in tutto il mondo in 15 anni; una guerra nucleare regionale ne farebbe perdere ¼ a livello globale. Tanto per ribadire quanto è fragile quello strato.
A distanza di 35 anni dalla firma del Protocollo di Montreal, quali lezioni abbiamo imparato dal buco dell’ozono? Il mondo è riuscito a sventare una minaccia ambientale planetaria trovando e rispettando un accordo globale. La storia del buco dell’ozono ha dimostrato che la fiducia nella scienza è ben riposta: quando gli scienziati Frank Sherwood Rowland e Mario Molina ipotizzarono l’azione distruttiva delle molecole di CFC sull’ozono, il mondo scientifico diede loro credito anche se ancora mancavano le prove sul campo, arrivate negli anni successivi. E le osservazioni satellitari sono state determinanti per monitorare in tempo reale questo complesso fenomeno atmosferico.
Le manifestazioni di GreenPeace hanno acceso i fari sull’emergenza grazie a una metafora imprecisa ma che ha fatto breccia nell’immaginario collettivo: il “buco” nell’ozono. Sopra l’Antartide e l’Artide, infatti, non si è mai aperta una vera fessura: lo strato di ozono si è in realtà assottigliato. Tutti questi fattori, insomma, hanno lavorato in modo sinergico per arrivare al Protocollo di Montreal, «il singolo accordo internazionale di maggior successo», come lo definì l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan.
Si potrà applicare questa formula anche alla lotta contro i gas serra e contro il cambiamento climatico? «Il punto di partenza è lo stesso dell’ozono: sappiamo quali molecole ne sono responsabili (CO₂, metano ecc.) e sappiamo che sono emesse dall’uomo», risponde Peuch. «Ma ridurre le emissioni di CO₂ è molto più difficile rispetto alle sostanze che assottigliano l’ozono. Abbassare le emissioni di CO₂ comporta ridurre alcune attività umane (da allevamento e agricoltura intensivi all’uso di carbone, ndr), sviluppare fonti di energia rinnovabile, ridurre il fabbisogno energetico di case e mezzi di trasporto, e trovare soluzioni per immagazzinare l’eccesso di carbonio in atmosfera.
Le sostanze che minacciano l’ozono sono state facilmente sostituite con altre innocue: è un problema globale ma influenzato da un numero limitato di settori. Per ridurre i gas serra, invece, sono necessari cambiamenti molto più profondi che avranno un impatto su tutte le persone. Dunque, le discussioni, gli accordi, le soluzioni tecnologiche richiedono più tempo. Ma il Protocollo di Montreal ci ha dimostrato che la scienza può aiutare a risolvere i problemi ambientali che minacciano il Pianeta».