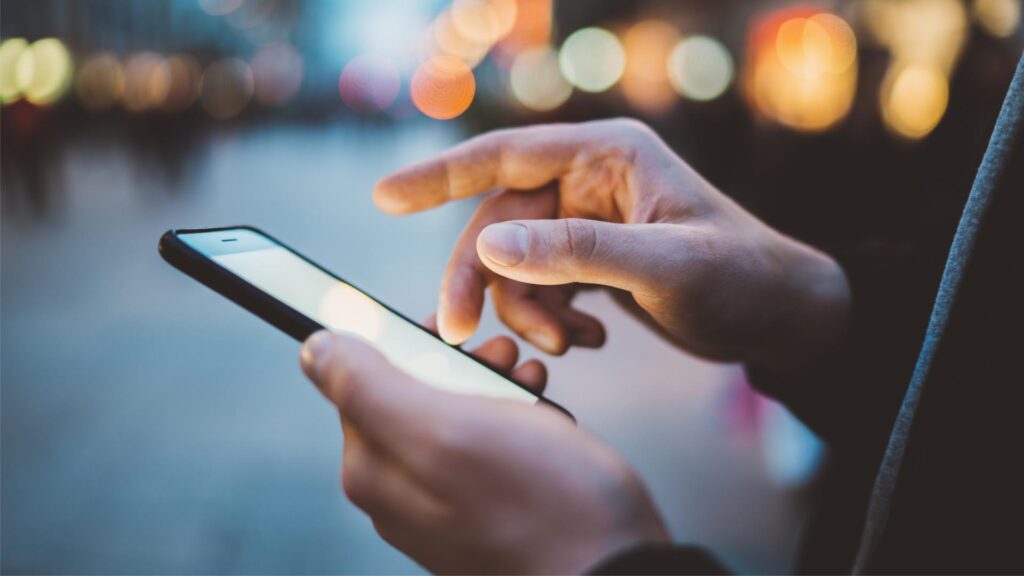Torna l’idea di vietare gli smartphone a scuola: era appena arrivata la notizia della Gran Bretagna, pronta a limitarne l’uso, quando anche il ministro Valditara ha deciso di annunciare una stretta risolutiva, che si rivelerà attiva solo con l’uscita delle nuove Linee guida per l’educazione civica.Si tratta di un atteggiamento miope, che rischia di peggiorare il livello già insufficiente delle competenze digitali dei ragazzi.Perché non impegnarsi nel mitigare gli effetti negativi dei media digitali, sfruttandoli invece per trarre vantaggi personali e collettivi?Indice degli argomenti
Il divieto di smartphone a scuola, dagli Usa all’EuropaIl divieto d’accesso ai social media prima dei 16 anni di età è stato registrato da poco in Florida, ma era già attivo il divieto assoluto di smartphone nelle scuole di ogni ordine e grado. All’inizio dello scorso anno lo Utah aveva vietato l’utilizzo dei social sotto i 18 anni senza l’esplicito consenso dei genitori, e proibizioni simili erano entrate in vigore in Arkansas, Louisiana, Ohio e Texas (ma in alcuni di questi Stati qui c’è ancora in vigore anche la pena di morte).L’ Europa sembra essere particolarmente attratta da decisioni simili: la Francia nel 2018 ha disposto il divieto dello smartphone nelle scuole elementari e medie, seguita poi da Inghilterra, Olanda e parzialmente anche dalla Finlandia.Competenze digitali: il quadro europeoIn Europa le competenze digitali della popolazione in età lavorativa (dai 16 ai 74 anni) sono misurate in base al Digital Competence Framework 2.2, un quadro comune europeo di riferimento, che le suddivide in cinque domini: alfabetizzazione all’informazione e ai dati, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e risoluzione dei problemi. In Italia, tra la popolazione compresa tra 16 e 74 anni, nella rilevazione 2021 solo il 45,7% aveva competenze digitali almeno di base in tutti i domini, rispetto alla media europea del 54%, o al 56,3% dell’area euro. In base a questo indicatore, il nostro Paese si collocava al 25° posto su 27 Paesi dell’UE, mostrando un forte ritardo.il legame tra competenze digitali e lavoroL’Unione europea però ha come obiettivo che l’80% della popolazione abbia competenze digitali di base entro il 2030, rispetto al 54% della popolazione nel 2021, come riportato dal Digital Economy and Society Index. L’UE riconosce che le competenze digitali insufficienti costituiscono un ostacolo prima alla partecipazione alla società digitale e poi anche all’economia digitale.Le persone che non hanno competenze digitali di base hanno meno probabilità di essere in grado di utilizzare in modo critico strumenti digitali, come i social media e internet, e avranno anche difficoltà a trovare un lavoro, rispetto a coloro che hanno competenze migliori. Le aziende non sono in grado di crescere e di competere perché non riescono a trovare lavoratrici e lavoratori con le competenze necessarie, per utilizzare efficacemente gli strumenti digitali sul posto di lavoro.Unesco: i vantaggi dell’uso delle tecnologie digitali a scuola Anche nel Global Education Monitoring Report del 2023 dell’Unesco, oltre naturalmente ad evidenziarne i rischi, si sostiene che i vantaggi dell’uso delle tecnologie digitali a scuola sono molteplici: ad esempio gli insegnanti possono sviluppare lezioni che consentano a studentesse e studenti di apprendere al proprio ritmo, grazie a software personalizzati e adattivi, e si libera così del tempo per proporre attività individuali scalabili o lavorare con piccoli gruppi (Bulman & Fairlie, 2016; Reich, 2020). Il fatto che la tecnologia abbia il potenziale per supportare i sistemi educativi non significa necessariamente che i processi e le pratiche di insegnamento siano stati sostanzialmente trasformati (Reich, 2020).Quella del no-smartphone-a-scuola è una richiesta ciclica, quasi un mantra (Di Donato, 2018, 2019, 2020, 2022), solo che si sta manifestando con un pressing progressivo e sempre più forte.La vita digitale oggi passa dallo smartphoneIl male da estirpare sembra celarsi tutto in quei 175 grammi di ferro, silicio e cromo e altri minerali minori, che ci infiliamo nelle tasche e nelle borse e che però, come ci ricorda il rapporto Censis-Auditel del 2023 tutti abbiamo in tasca per tutto il giorno e spesso non spegniamo mai. Oggi abbiamo in Italia più di 50 milioni di smartphone e rimangono i device più utilizzati dalla popolazione. Il 91,7% del totale delle famiglie italiane accede a Internet da casa, ma il 22,4% (5,5 milioni di famiglie in valore assoluto) lo fa solo attraverso lo smartphone. Portabilità, semplicità di utilizzo, vocazione, multitasking sono le caratteristiche premiate dagli italiani.Sebbene i tablet, che sono 7 milioni e 600.000 e che sembravano destinati essere soppiantati da pc portatili e smartphone, nell’anno della pandemia abbiano avuto una rinascita (proprio perché sono stati utilizzati da molti studenti come strumento per la didattica a distanza), in futuro non è ipotizzabile un andamento in crescita per questi dispositivi, anzi.Insomma, la vita digitale oggi passa dallo smartphone: è infatti aumentato il bisogno di dispositivi che consentano di assolvere al meglio le proprie esigenze quotidiane di studio, lavoro, tempo libero e relazionalità. Lo smartphone questo lo fa. Ecco, appunto: esigenze di studio.L’uso improprio degli smartphone: effetti sulla concentrazione Lo smartphone può introdurre oneri importanti sulle risorse cognitive di uno studente, questo lo sappiamo. A casa il suono delle notifiche di un messaggio in arrivo è dannoso per la concentrazione (Aharony & Zion, 2019; May & Elder, 2018), la vibrazione di una telefonata (attività comunque più rara tra gli adolescenti) o l’accensione della luce dello schermo sono altrettanto distraenti.Anche la competizione tra i diversi dispositivi tecnologici, che si contendono la sua attenzione mentre magari cerca di rimanere concentrato su un compito a casa (Chen & Koufaris, 2020) è fonte di stress per studentesse e studenti. La loro attenzione focalizzata viene interrotta e i progressi nel compito iniziale ne risentiranno (Chen & Yan, 2016; Terry, Mishra e Roseth, 2016). La notifica è lo spunto per l’utente per prendere una decisione ma, indipendentemente dalla decisione che si prenderà, la distrazione ormai si è verificata (Chen & Koufaris, 2020). Sappiamo anche questo.Il rapporto tra i minori e lo smartphoneNella XIV edizione dell’Atlante dell’infanzia (a rischio) di Save The Children intitolato Tempi digitali si forniscono alcuni dati che integrano quelli presentati: nel biennio 2021-2022 il 73% dei minori tra i 6 e i 17 anni si è collegato quotidianamente a Internet; solo due bambini su cinque, nella fascia tra gli 11 e i 15 mesi, non vengono mai messi davanti uno schermo. Usano Internet per scaricare giochi o videogiocare l’82,4% degli 11-17enni tra i ragazzi e il 68,7% delle ragazze nella stessa fascia d’età. In alcuni casi il gaming diventa strumento di sensibilizzazione e lo stesso vale per i social, che però sono stati molto importanti per fenomeni come la Primavera Araba o movimenti come Occupy Wall Street, Fridays for Future e Black Lives Matter: hanno contribuito a diffondere pratiche di conoscenza di questi movimenti, fino a diventare mezzo per esprimere vicinanza o anche adesione a fenomeni locali e globali.Il processo di organizzazione sistematica dei propri pensieri, sentimenti e azioni per raggiungere i propri obiettivi viene ora comunemente definito autoregolazione. Il mondo nel quale ci troviamo è straordinariamente ricco di informazioni e parecchio frenetico: molti possibili percorsi di pensiero e comportamento, che ci vengono presentati a volte possono sembrare travolgenti. Secondo le rilevazioni di We are social del 2023, il 97,5% della popolazione tra i 16 e i 64 anni possiede uno smartphone. Il cellulare però non basta: serve un accesso ad una connessione wifi veloce e molte competenze digitali. La stessa indagine rileva che nella popolazione in Italia tra i 16 e i 64 anni, a gennaio 2023, il 67,2% possedeva un pc, il 51% un tablet, il 22,6% una smart tv, il 4,5% un dispositivo per la realtà virtuale e 1 su 5 (20,5%) un dispositivo per la smart home (domotica o smartspeaker).Nelle quasi sei ore giornaliere trascorse mediamente su internet, la metà del tempo ci si connette da cellulare e l’altra metà da pc e tablet. La neurobiologia negli ultimi anni ha dimostrato come le connessioni del sistema nervoso possano essere modificate dall’esperienza e dall’ambiente, sia per quanto riguarda le funzioni sia per quanto riguarda la struttura del cervello.Gli effetti diun’esposizione elevata ai media digitali sui minorenniLa neuroplasticità è massima durante lo sviluppo del bambino per diminuire nell’età adulta. Per questo è particolarmente importante capire gli effetti che un’esposizione elevata ai media digitali può avere sui minorenni: in primo luogo un deficit dell’attenzione. I continui suggerimenti digitali creano un flusso illimitato di informazioni che ci costringono a interagire con più input contemporaneamente, ma rimanendo sempre a un livello superficiale: è quello che si chiama media multitasking, che è stato misurato su un campione di adulti durante il solo utilizzo del computer. I passaggi tra i diversi contenuti avvenivano ogni 19 secondi e il 75% di essi veniva visualizzato per meno di un minuto. Inoltre, l’eccitazione provata dall’utente era massima nel momento del passaggio da un contenuto all’altro per decrescere subito dopo.Giovani e social: i dati IstatSecondo le rilevazioni ISTAT del 2022, il 62,3% di ragazze ragazzi tra gli 11 e 17 anni è risultato attivo sui social, nei tre mesi precedenti la rilevazione, con una presenza maggiore delle ragazze (67,9%) rispetto ai ragazzi (56,8%).È soprattutto nella fascia di età 14-17 anni che si fa più intensa la presenza sui network (79%) soprattutto delle ragazze (84%) rispetto ai ragazzi (74,2%). Rilevante anche l’uso dei social media tra gli 11 e i 13 anni (40,7%), di nuovo con una netta prevalenza femminile (47,1%) rispetto a quella maschile (34,5%).La statistica ci dice implicitamente anche altro: sebbene la legge preveda che un utente possa stare sui social solo dopo aver compiuto 13 anni, la realtà mostra una presenza massiccia di preadolescenti fuorilegge, che hanno aperto un profilo indicando un’età maggiore o hanno usato il profilo anagrafico di un adulto, spesso un genitore più o meno connivente.Quanto alla messaggeria istantanea, soprattutto WhatsApp, essa è ormai parte della quotidianità di quasi tutti i giovanissimi della fascia di età considerata da ISTAT (11-17 anni): la usa l’89,2% di loro. Si parla in pratica di tutti quelli che hanno uno smartphone, spesso anche l’unico, attraverso cui si dipana il loro mondo virtuale fatto di app e social network.Educare all’uso della tecnologia: il patto digitalePerché non prendiamo spunto dalla società civile? A Torino è partito il patto digitale, linee guida create da comunità di genitori per educare all’uso della tecnologia. In particolare, alla consegna e l’uso dello smartphone per i più giovani. Per evitare problemi di salute o attacchi online, educatori e famiglie di studenti di scuole primarie e secondarie si mettono in rete: è uno dei modi possibili per confrontarsi su regole il più possibile unitarie e coese nello sviluppo digitale dei figli. Il patto digitale di Torino ha già riscosso una cinquantina di firmatari, tra cui alcune scuole. E si inserisce nella nascita di altri patti che stanno nascendo in altre città italiane come Milano, Udine e Bergamo. Sono 35 quelli avviati nel corso degli anni in 12 regioni italiane.I dispositivi mobili e quindi anche gli smartphone hanno diversi vantaggi, che anche la letteratura specialistica ribadiva già più di dieci anni fa: una estrema portabilità, la facilità con cui si possono creare contenuti, la facilità nella comunicazione e nella collaborazione; il fatto che li possiedano quasi tutte le studentesse e gli studenti (Ranieri, 2014; Briz-Ponce et al., 2017).Sarebbe colpevole e ingenuo poi trascurare l’uso compensativo degli smartphone per i Bisogni educativi speciali: funzioni di traduzione istantanea, registrazione audio e video, cattura di testo da immagini, invio di materiale e tante altre funzioni sono quelle che permettono l’accesso primario alle attività didattica per persone con Dsa o con disabilità sensoriali.Pensate anche alle numerose app che permettono di utilizzare la Comunicazione Aumentativa Alternativa e di farlo in modo personalizzato: lo smartphone svolge in quel caso il ruolo di un vero e proprio ausilio, che permette e aumenta le possibilità di comunicazione e interazione con l’ambiente da parte di persone con diverse tipologie di disabilità.Nelle mani di insegnanti competenti, e direi anche creativi, l’integrazione di più dispositivi a scuola non è una maledizione, ma un vantaggio (AlTameemy, 2017): possibile che una istituzione educativa non si fidi dell’uso che docenti preparati faranno dello smartphone nelle loro attività didattica e addirittura si affermi di usare questo divieto per proteggerli?Credo che non sia di questo tipo di protezionismo che abbiamo bisogno, ma di nuove alleanze educative, che si basino su ricerca, metodologie e pratiche condivise. Gli studiosi del tema parlavano ben prima della pandemia di costruire una nuova sequenza didattica e delle attività educative in grado di collegare contesti di apprendimento formale e informale proprio attraverso le tecnologie personali (Mirald & Spikol, 2007; Riva & Villani, 2005; Shroeder, 2013).Le sfide da affrontareQuali sono allora le sfide che sarebbe necessario affrontare? Ne intercetto almeno tre:Da un punto di vista pedagogico, la sfida principale si concentra sull’identificazione chiara di ciò che è meglio apprendere in classe, di ciò che dovrebbe essere appreso al di fuori della classe e dei modi in cui questi due possono coesistere. I ricercatori hanno scoperto che è possibile indurre una mentalità di crescita con i bambini piccoli attraverso semplici aggiustamenti al feedback sui compiti, integrando gli studenti nel duro lavoro piuttosto che lodando l’intelligenza (Dweck, 2008). Gli smartphone si prestano a raccogliere anche questo tipo di personalizzazione dell’apprendimento.Promuovere l’apprendimento autodiretto e non sempre eteroregolato dagli insegnanti: le tecnologie mobili permettono questo tipo di esperienze, che incoraggiano gli studenti a partecipare più attivamente al loro processo di apprendimento.Incoraggiare negli insegnanti lo sviluppo di competenze specifiche sull’integrazione di diverse tipologie di tecnologie, per progettare percorsi di apprendimento inclusivi e personalizzati.ConclusioniLe competenze digitali non sono più solo competenze tecniche o tecnologiche: sono necessarie competenze informative, comunicative, competenze nella produzione di contenuti, competenze strategiche e oggi più che mai competenze di benessere digitale (Beetham, 2019; Gui, Fasoli & Carradore, 2017), che supportino capacità di regolare l’iperconsumo, superare le difficoltà di gestione della comunicazione digitale, diminuire il multitasking, che rischia di produrre comportamenti di forte calo delle nostre prestazioni cognitive.Anche nel citato Atlante di Save the Children si riportano i numerosi studi internazionali per i quali una risposta solo repressiva, securitaria, non è efficace, anzi tende a creare più problemi.Forse, dunque, è proprio a scuola, che si potrebbe educare lo sviluppo di condizioni in cui studentesse e studenti sono in grado di incanalare l’uso dei media digitali verso un senso di comfort, sicurezza, soddisfazione e appagamento.Perché non lavorare per affrontare gli effetti collaterali dei media digitali, pur utilizzandoli per ottenere una estesa varietà di benefici personali e sociali?Nella mappa europea sulle competenze digitali delle persone tra i 16 e i 19 anni, quindi di ragazze e ragazzi che (nel migliore dei casi, salvo fenomeni di dispersione comunque presenti nel nostro Paese) frequentano gli ultimi anni della scuola secondaria di II grado, l’Italia si posiziona quart’ultima per la quota di giovanissimi con scarse o nessuna competenza (sono il 42% rispetto ad una media europea del 31%). La scuola può frenare questo disastro e magari senza autoboicottarci?BibliografiaAlTameemy, F. (2017). Mobile phones for teaching and learning: Implementation and students’ and teachers’ attitudes. Journal of educational technology systems, 45(3), 436-451.Aharony, N., & Zion, A. (2019). Effects of WhatsApp’s use on working memory performance among youth. Journal of Educational Computing Research, 57(1), 226-245.Beetham, H., & Sharpe, R. (Eds.). (2019). Rethinking pedagogy for a digital age: Principles and practices of design. Routledge.Briz-Ponce, L., Pereira, A., Carvalho, L., Juanes-Méndez, J.A. & García-Peñalvo, F.J. Learning with mobile technologies—Students’ behavior. Comput. Hum. Behav. 2017, 72, 612–620Bulger, M. (2016). Personalized learning: The conversations we’re not having (Working paper). Data and Society Research Institute. https://datasociety.net/pubs/ecl/PersonalizedLearning_primer_2016.pdfBulman, G. & Fairlie, R. W. (2016). Technology and education: Computers, software and the internet. In E. A. Hanushek, S. Machin and L. Woessmann (Eds)Handbook of the Economics of Education (Vol. 5, pp. 239–280).Chen, Q., & Yan, Z. (2016). Does multitasking with mobile phones affect learning? A review. Computers in Human Behavior, 54, 34–42Chen, C. W., & Koufaris, M. (2020). Multi-device use: understanding the motivations behind switching between multiple devices during a task. International Journal of Human–Computer Interaction, 36(12), 1178-1193.Di Donato, D. (2018). Cellulari a scuola, perché i docenti stanno (solo) facendo il proprio dovere. In Agenda Digitale https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/cellulari-a-scuola-i-docenti-stanno-solo-facendo-il-proprio-dovere-ecco-perche/Di Donato, D (2019). Bambini troppo soli davanti agli smartphone: ecco che cosa può fare la scuola. In Agenda Digitale https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/bambini-troppo-soli-davanti-agli-smartphone-ecco-cosa-puo-fare-la-scuola/Di Donato, D. (2020). Bambini e display, non è apocalisse: cosa dicono gli studi scientifici. In Agenda Digitale https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/bambini-e-display-non-e-apocalisse-cosa-dicono-gli-studi-scientifici/Di Donato, D. (2022). Smartphone a scuola, le contraddizioni del Ministero. In Agenda Digitale https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/smartphone-a-scuola-le-contraddizioni-del-ministero/Elsevier Fisher, M. & Baird, D. (2007) Making m-learning work: Utilizing mobile technology for active exploration, collaboration, assessment, and reflection in higher education. Journal of Educational Technology Systems 35(1): 3–30.Gui, M., Fasoli, M. & Carradore, R. (2017). Il “benessere digitale”. Sviluppare un nuovo strumento teorico per la ricerca sulla Media Literacy. Italian Journal of Sociology of Education, 9(1), 155-173. doi: 10.14658/pupj-ijse-2017-1-8May, K. E., & Elder, A. D. (2018). Efficient, helpful, or distracting? A literature review of media multitasking in relation to academic performance. International journal of educational technology in higher education, 15(1), 1-17.Milrad M., Spikol D. (2007) Anytime, anywhere learning supported by smart phones: Experiences and results from the MUSIS project. Educational Technology & Society 10(4): 62–70.Ranieri, M & Pieri, M. (2014). Mobile Learning. Dimensioni teoriche, modelli didattici, scenari applicativi. Edizioni Unicopli.Riva, G. & Villani, D. (2005). What are the benefits and the disadvantages of mobile devices for education? Cyber Psychology & Behavior 8(5): 510–511.Schroeder, B. (2013) Mobile and digital: Perspectives on teaching and learning in a networked world. In: Tsinakos A., Ally M. (eds) Global mobile learning implementations and trends, Beijing, China: China Central Radio & TV University Press, pp. 105–118.Terry, C. A., Mishra, P., & Roseth, C. J. (2016). Preference for multitasking, technological dependency, student metacognition, & pervasive technology use: an experimental intervention. Computers in Human Behavior, 65, 241–251.UNESCO (2023). Global education monitoring report summary. Technology in education: a tool on whose terms? https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723