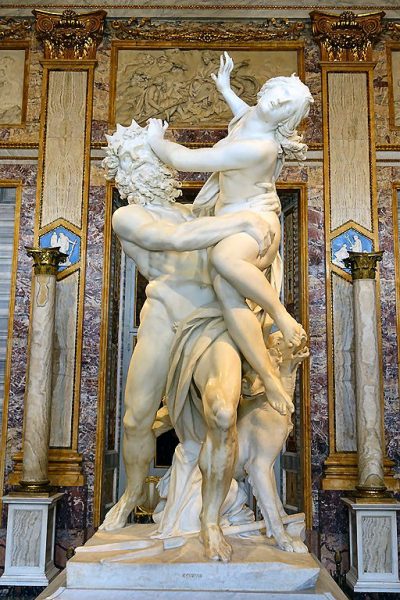La favola della Sirenetta

Le dotte Sirene e la favola della Sirenetta di Hans Christian Andersen, specialista in fiabe per bambini.
Secondo la tradizione, le Sirene [Dal latino tardo “sirenae”, che è dal greco Σειρῆνες] erano tre o quattro fanciulle dalla voce soave, nate dal dio fluviale Achelòo, figlio di Ocèano e Tèti, e dalla musa della tragedia Melpòmene.
Come narra Ovidio (Sulmona 43 a.C. – Tomi 17 d.C.) nel Libro V, vv 552-63, delle “Metamòrfosi”, quando Prosèrpina raccoglieva fiori primaverili, le dotte Sirene (<
Le Sirene avevano quindi aspetto di donne giovani e belle nella parte superiore del corpo e di uccelli nella parte inferiore. Situate, secondo la tradizione, in una rocciosa isola del Mediterraneo (a nord della Sicilia), esse ammaliavano col loro canto i naviganti e li facevano naufragare contro gli scogli. Ulisse le ascoltò dopo aver riempito di cera le orecchie dei compagni ed essersi fatto legare all’albero della nave per resistere alle loro lusinghe (le Sirene gli promettevano il sapere) [Omèro, “Odissèa”, Libro XII, vv. 52-73 e 206-265]. Questo episodio è raffigurato in un mosaico romano proveniente da Dougga, che si trova a Tunisi, Museo del Bardo.
Tre Sirene avevano rispettivamente nome: Aglaope (“colei che ha la voce splendida”), Pisinoe (“colei che seduce”), Telsinoe (“colei che incanta”). Partenope era una quarta Sirena innamorata di Ulisse e quando percepì il suo rifiuto, si gettò in mare, lasciandosi andare in balia delle onde. Il suo corpo arrivò sulle coste della Campania, dove gli abitanti del posto le diedero onorata sepoltura. Su quella tomba costruirono la città di Partenope. In tempi successivi la città fu distrutta e dalle sue ceneri nacque la città nuova, “Neapolis” ovvero Napoli, ancor oggi detta “città partenopea”.
La raffigurazione delle Sirene come donne con la parte inferiore del corpo a forma di pesce appare solo in età medievale ed è la loro figura più nota.
A volte viene detta “sirena” una bellezza femminile che diletta col fascino e con la seduzione.
Ed ora una favola, che ha per protagonista una Sirenetta con la parte inferiore del corpo a forma di pesce.
Ne è autore lo scrittore danese Hans Christian Andersen (Odense 1825 – Copenaghen 1875), specialista in “Fiabe per bambini”, fra le quali spiccano: “Il brutto anatroccolo”, “Scarpette rosse”, “La principessa sul pisello”, “Gli abiti nuovi dell’imperatore”, “I cigni selvatici”, “La piccola fiammiferaia”.
La Sirenetta
“Nelle profondità marine, ove sbocciano fiori vivi dai magnifici colori e piante flessibili dal fogliame diàfano, sorgeva il castello del re del Mare, con muri di corallo rosato, finestre d’ambra gialla, tetto di conchiglie perlacee. Il re del Mare, vedovo da tempo, aveva sei figliole, bellissime fanciulle, sirene dai lunghi capelli e dalle bianche braccia, il cui corpo terminava in una squamosa coda di pesce. La loro vecchia nonna diceva:
- Quando compirete quindici anni, potrete salire a fior d’acqua, stendervi sulle rocce e veder passare le navi nell’albore lunare…
E le fanciulle attendevano con ansia il tempo loro fissato per salire alla superficie del mare. Della terra e dei suoi abitatori nulla sapevano. Solo nel giardino subacqueo v’era una statua marmorea, calata a picco dopo un naufragio: essa rappresentava un bellissimo giovinetto e la Sirenetta più piccina aveva piantato vicino a lui un roseo salice piangente, e rimaneva spesso estatica a guardare la statua, con l’anima perduta nel sogno… A una a una alle sue sorelle fu concesso salire a fior d’acqua, e tutte tornarono, narrando le meraviglie che avevano venduto sulla terra… Allorché giunse la volta della Sirenetta minore ella si apprestò col cuore in tumulto alla gran prova: mise il capo fuor dalle onde non appena il sole fu tramontato, e sullo sfondo del cielo di porpora e d’oro vide un bastimento a tre alberi, fermo sul mare in bonaccia. Quando scese la notte, ella si accostò a una finestretta, che dava sulla sala, e vide una gran festa con molti invitati. E fra tutti spiccava un giovane principe dagli occhi neri: si festeggiava il suo compleanno e più tardi si lanciarono nel cielo razzi, bengala, fuochi artificiali dai colori abbaglianti.
Dopo mezzanotte tutti si coricarono e dai profondi gorghi del mare s’annunciò con sordo mugghio la tempesta. Poco dopo essa si scatenò terribile: alla Sirenetta pareva un gioco, ma ai marinai no davvero! La nave era sballottata dalle onde, fra scrosci, fulmini, lampi: l’albero maestro si spezzò, i fianchi si sfasciarono, e la nave s’inabissò…
La Sirenetta si slanciò verso il giovane principe e lo raggiunse fra i rottami sparsi e i marosi furibondi: le forze lo abbandonarono ed ella lo sostenne fra le braccia, svenuto, e si lasciò trasportare con lui dalle onde alla deriva. Sorgeva l’alba e la tempesta si placava: la Sirenetta depose delicatamente il giovane privo di sensi su una spiaggia arenosa, in fondo ad una piccola baia tranquilla.
Poco lontano sorgeva un monastero. E una giovinetta non tardò a uscirne, vide il principe, chiamò le compagne, lo soccorse. Il principe riaperse gli occhi e le sorrise: non sapeva che la Sirenetta vedeva tutto, nascosta dietro una roccia; non sapeva che era stata lei a salvarlo. Ed ella si rituffò nel mare, profondamente triste.
Da quel giorno non ebbe più pace: narrò le sue pene alle sorelle ed esse la condussero a fior d’acqua in un luogo donde si vedeva il magnifico palazzo del principe. Da allora, ogni notte la Sirenetta nuotò fin presso la riva per vederlo. Di giorno poi chiedeva alla nonna tante notizie intorno agli uomini e apprese da lei che la loro vita era più breve di quella degli abitanti del mare, i quali possono vivere fino a trecento anni; ma gli uomini hanno un’anima immortale, che, quando il corpo perisce, sale al cielo fra le stelle.
- E io non potrei avere un’anima immortale? – domandava la Sirenetta.
- Sì, – rispondeva la nonna – ma solo se un uomo ti amasse più di tutto e più di tutti, e ti facesse sua sposa… Ma gli uomini non amano le sirene con la coda di pesce…
Da quel momento la Sirenetta non ebbe che un pensiero: liberarsi dalla coda squamosa, divenir simile alle donne terrestri e conquistare, con l’amore del principe, l’anima che mai non muore. Le dissero che una vecchia maga, la quale abitava in una grotta marina piena di polipi dai paurosi tentacoli e di orrendi serpentacci, era capace di qualsiasi sortilegio; ed ella si recò da lei. La strega, per compiere il prodigio, le chiese in cambio il dono della sua voce.
- Ma se mi togli la voce – chiese la Sirenetta – che cosa mi resterà?
- La tua bellezza – rispose la maga.
E la sirenetta si lasciò tagliare la lingua ed ebbe in cambio un filtro. Andò a berlo presso la scalèa marmorea del palazzo principesco e sentì un dolore così atroce che svenne. Quando riprese i sensi, il principe era dinnanzi a lei e la guardava coi grandi occhi neri: ella abbassò i suoi e si avvide che la sua coda di pesce era sparita. Il principe la prese per mano e la condusse al castello: a ogni passo che faceva (la maga glielo aveva predetto) alla Sirenetta sembrava di camminare su aghi pungenti e su pugnali accuminati. Ma non le importava. Fu accolta a Corte e il principe le voleva bene e la chiamava la sua piccola trovatella; ella danzava per lui con incantevole grazia, nonostante gli spasimi atroci; ma non poteva né parlare né cantare né dirgli il suo amore. La notte usciva sulla scalèa marmorea e immergeva nell’acqua marina, fresca, i piedini doloranti.
Una notte vennero a fior d’acqua le sue sorelle, e le dissero il loro dolore, perché ella le aveva lasciate. Un’altra notte le apparve la nonna, e un’altra notte il re del Mare, ed entrambi stesero invano le braccia verso lei. I giorni passavano, e la Sirenetta sentì dire a Corte che il principe presto doveva sposarsi. Era la fine: se egli avesse sposato un’altra donna, la mattina delle nozze la Sirenetta si sarebbe disciolta in spuma marina. Il giorno fatale giunse. Ed ella vide che la sposa era la fanciulla del monastero: il principe la credeva la sua salvatrice… Le campane suonavano a festa e la cerimonia ebbe luogo nel tempio: poi gli sposi salirono a bordo di una nave magnificamente addobbata, dove si dava un gran ballo. A notte alta tutti andarono a riposare e la Sirenetta rimase sola sulla spiaggia, donde era rimasta a guardare il bastimento, tutta la notte. Poco prima dell’alba le sue sorelle salirono a fior d’acqua e nuotarono fino a lei ed ella vide che i loro lunghi capelli erano tutti recisi.
- Li abbiamo dati alla strega, perché tu non muoia all’alba. Ed ella ci ha dato questo coltello: devi immergerlo nel cuore del principe e allora riavrai la coda di pesce e rimarrai per trecento anni con noi!
Ma la Sirenetta non poteva uccidere colui che amava tanto: gettò lungi da sè il coltello e al primo raggio del sole si sentì dissolvere in candida spuma. Mille splendenti eteree forme fluttuavano nell’aria, fra melodie spirituali: ed ella era simile ad esse, una figlia dell’aria. Le sue sorelle le dissero che con le opere buone, recando frescura e ristori di pura aura ai malati nei caldi climi pestilenziali, visitando i bimbi sofferenti nelle case misere, in capo a trecento anni avrebbe potuto, come loro, acquistare un’anima immortale ed essere partecipe della eterna felicità. La Sirenetta levò gli occhi al cielo e per la prima volta li sentì riempirsi di lacrime. Alitò lieve sul volto del principe e della sua sposa, che invano la cercavano dappertutto. Poi salì con le altre figlie dell’aria sulle rosee nubi, fluttuanti per l’etere. E le voci melodiose cantavano:
- Da qui a trecento anni saliremo con te al Paradiso!”.
Per finire, ricordo che a Copenaghen si trova la statua raffigurante la «Sirenetta» di cui sopra, sulle onde del Baltico.