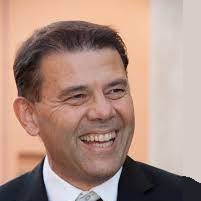Ho incontrato per la prima volta questo curioso strumento da pittura descrivendo un dipinto di Matisse in uno dei capitoli de Il mondo alla finestra. In particolare si trattava di una delle sue opere più astratte e cioè La finestra blu del 1913.
La scena raffigura la camera da letto di Henri e della moglie Amélie al secondo piano della loro abitazione a Issy-les-Moulineux, alla periferia di Parigi. Il tetto sullo sfondo, tra alberi tondeggianti, è quello del suo studio, una costruzione voluta dallo stesso pittore. Tutto il resto è un insieme di elementi stilizzati che emergono dal fondo attraverso il vibrante contrasto tra colori quasi complementari: i toni d’azzurro e turchese e il giallo ocra.
La distinzione tra interno ed esterno è totalmente annullata, così come la verosimiglianza di ogni oggetto. Eppure ce n’è uno molto caratteristico, che Matisse inserisce forse per spiegare il modo con cui crea immagini così essenziali: è il cosiddetto “specchio Claude” o specchio nero, quel quadrato scuro con cornice rossa sul lato destro della tela.
Si tratta di un piccolo specchio brunito e leggermente convesso, generalmente grande come una scatola di cipria, che i pittori usavano per ritrarre la natura volgendosi di spalle e osservandola sulla superficie riflettente. L’effetto ottenuto era simile ai dipinti di Claude Lorrain, il paesaggista del Seicento da cui prende il nome.
Lo specchio nero, oltre a includere in un piccolo spazio un vasto paesaggio per via della sua convessità e a fornire un’immagine già bidimensionale e facile da copiare, aveva la capacità di confondere i dettagli e limitare la gamma cromatica, due aspetti utili a Matisse nella creazione di immagini sempre più semplificate come La finestra blu.
Ma quando è nato quest’oggetto? L’ha inventato proprio Lorrain? In realtà le origini di questo dispositivo non sono chiare né si può affermare che il buon Claude lo utilizzasse. Ma quel che è certo è che nel Settecento era straordinariamente diffuso non solo tra i pittori ma anche tra i nobili e i turisti che lo usavano per guardare i paesaggi in una versione più suggestiva, come testimonia questo ventaglio del Settecento.
In pratica era come guardare il mondo con gli occhiali da sole, capaci di rendere ogni tinta più intensa e di far vedere tramonti spettacolari senza abbagliamento. Grazie allo specchio Claude ogni paesaggio si trasformava magicamente in un dipinto di Lorrain.
Seguace di Claude Lorrain, Il pastore, XVII-XVIII secolo
Tra i più entusiasti utilizzatori di questo strumento ci fu l’inglese William Gilpin (1724-1804). Secondo lui lo specchio nero conferiva «all’oggetto della natura una sfumatura morbida come la colorazione di quel Maestro».
Thomas Gaisborough, Studio di uomo che tiene uno specchio Claude, 1750-1755
Gilpin era talmente innamorato di questo “filtro” che ne fece montare uno sul fianco della sua carrozza, da cui poter ammirare «una successione di immagini dai colori intensi che scivolavano continuamente davanti all’occhio».
Le incisioni derivate dai suoi schizzi sembrano proprio paesaggi visti con lo specchio Claude. Alcuni ne conservano persino la forma ovale!
Non è un caso che Gilpin sia anche l’ideatore del concetto di pittoresco, da lui definito nel suo Essay on Prints del 1768 come «quel tipo di bellezza che è gradevole in un dipinto». Un po’ quello che ci scappa da dire quando, davanti a un luogo incantevole, esclamiamo «sembra un quadro!».
Si tratta di un’idea nuova, sintomo di un cambiamento culturale in positivo nei confronti del paesaggio. Non dobbiamo pensare, infatti, che la natura sia sempre stata considerata bella e buona. Al contrario! Per secoli boschi e montagne erano percepiti come luoghi spaventosi e simbolo del male (la selva oscura…). La diffusione della pittura di paesaggio coincide dunque con questa rivalutazione dei luoghi naturali.
Jules Coignet, Veduta di Bolzano con un pittore, 1837
Un’altra testimonianza dell’uso dello specchio Claude si trova nel diario del viaggio nel Distretto dei laghi, nel nord ovest dell’Inghilterra, scritto dal poeta Thomas Gray e pubblicato nel 1775. Così scrive Gray: «Da qui sono arrivato alla canonica poco prima del tramonto e ho visto nel mio specchio un quadro che, se potessi trasmettervi e fissarlo in tutta la dolcezza dei suoi colori vivaci, si venderebbe tranquillamente per mille sterline. Questa è la scena più dolce che io possa ancora scoprire in fatto di bellezza pastorale, il resto in uno stile sublime».
George Barret, Vista del Lago Windermere, mattina presto, 1781
La diffusione del suo diario rese lo specchio talmente popolare che per un breve periodo fu chiamato addirittura “specchio Gray“… Pare che il poeta fosse così preso dalla visione attraverso il suo specchietto che durante una gita cadde all’indietro in «una stradina sporca» e si ruppe le nocche.
Thomas Rowlandson, Il dottor Syntax cade in acqua, da Il viaggio del dottr Syntax in cerca del pittoresco, 1813
Ma non avrebbe mai rinunciato a tenerlo aperto in mano e a vedere «il tramonto del sole in tutto il suo splendore».
Anton Zwengauer, Paesaggio con cervi al tramonto, 1847
Una descrizione meno poetica è fornita invece in un catalogo statunitense del 1857, nel quale il costruttore di strumenti ottici Benjamin Pike Junior spiega che «gli specchi di vetro nero di Claude per il disegno prospettico sono molto utili per il giovane artista, poiché condensano o diminuiscono la vista nella dimensione desiderata per il quadro previsto, e tutti gli oggetti mantengono le loro proporzioni relative».
Certo, è piuttosto curioso pensare che viaggiatori e artisti, invece di guardare uno spazio naturale gli volgessero le spalle preferendogli una miniatura alterata nella forma e nei colori. Ma la concezione estetizzante del paesaggio pittoresco rendeva molto più attraente quella piccola scena simile a un dipinto.
Edward Alcock (attr.), Sophia Anne Delaval tiene uno specchio Claude verso il paesaggio, 1775-1778
D’altra parte non è molto diverso da quello che fanno oggi in tanti quando danno le spalle a una veduta per farsi un selfie. Non c’è più neanche l’idea di rendere il paesaggio pittoresco, ma solo quella di farne una quinta per un’autorappresentazione.
Nonostante si tratti di un dispositivo legato a una concezione sorpassata della visione del paesaggio, il dipinto di Matisse all’inizio dell’articolo dimostra che lo specchio Claude non fu spazzato via neanche dalla Avanguardie. Incredibilmente sopravvive ancora oggi come installazione di grandi dimensioni per riproporre l’esperienza del paesaggio riflesso. Ne è un esempio quello dell’architetto Sarosh Mulla collocato nel 2017 a Waikereru, in Nuova Zelanda.
Un altro specchio, di forma ovale, è stato installato presso Tintern Abbey, un’antica abbazia cistercense in rovina nel Galles sud orientale.
In alcuni corsi di pittura viene usato per impratichirsi nel disegno dal vero e controllare meglio la gamma dei toni di grigio.
Ma, senza rendercene conto, continuiamo a usarlo pure noi, quando prima di pubblicare la foto di un paesaggio su Instagram, applichiamo filtri, modifichiamo la saturazione dei colori, giochiamo coi contrasti, inseriamo la vignettatura. È una tentazione troppo forte, quella di rendere un paesaggio un po’ più “wow” o forse dovremmo dire “pittoresco”…
Questo significa una sola cosa: che Lorrain con il “suo” specchio è vivo e vegeto e fa le foto insieme a noi!