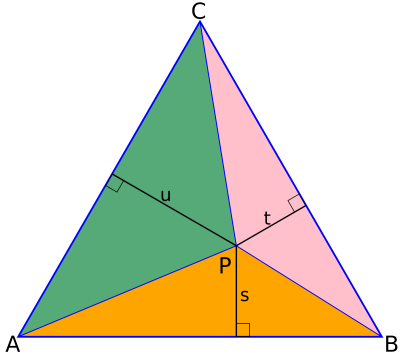Il profilo professionale e le competenze del Dirigente tecnico con funzioni ispettive
di Pietro Boccia
a. Premessa
I Dirigenti tecnici sono professionisti, che, investiti di funzioni e compiti di rilevanza da svolgere individualmente o collegialmente, del sistema nazionale di istruzione, educazione e formazione, si interessano di questioni tecniche e infrastrutturali, relative alle istituzioni scolastiche. Hanno competenza e responsabilità soprattutto nell’assicurare che la logistica e la tecnologia siano armonizzate con gli obiettivi educativi. L’attività del contingente ispettivo (DPR. n. 80/2013) del Ministero dell’istruzione è costituito da dirigenti tecnici ed è un’espressione di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico, prevista dall’articolo 419 del D.lgs. n. 297/1994. Storicamente solo nel 2021, il Decreto-Legge n. 73, convertito in Legge n. 106/2021, ha istituito una sezione destinata ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive e ha introdotto nuove modalità di reclutamento. All’ articolo 423, comma 1, infatti, le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive”.
b. Art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 – Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo
All’articolo 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 – Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo – vengono fissate attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive, sostenendo che devono: provvedere, secondo le direttive del Ministro o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell’Amministrazione, al fine di accertarne sia la regolarità amministrativa e contabile sia il corretto svolgimento dell’azione amministrativa; verificare la razionale organizzazione dei servizi, l’adeguata utilizzazione del personale e l’andamento generale dell’ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgere opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento e il perfezionamento dell’azione amministrativa; riferire sull’esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all’organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati; comunicare all’ufficio organizzazione e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate; riferire direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare. Il disposto di cui all’art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive. I dirigenti con funzioni ispettive, che, nell’esercizio o a causa di tali loro funzioni, accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell’offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2 del Codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere trasmesso per notizia all’organo dal quale i dirigenti con funzioni ispettive dipendono e a quello che eventualmente ha disposto l’ispezione o l’inchiesta. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev’essere comunicata anche al Ministro interessato. Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell’Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati. I dirigenti con funzioni ispettive sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d’ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se i dirigenti con funzioni ispettive abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.
c. Art. 4 del DPR n. 417/1974 – La funzione ispettiva
Nel 1974, poi, con il decreto delegato n. 417 viene definita, all’articolo 4, la funzione del dirigente tecnico (allora ispettore tecnico). Tale articolo sostiene che la funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Essa è esercitata (con due funzioni diversificate anche contrattualmente) da “ispettori” tecnici centrali e periferici. Gli “ispettori” tecnici centrali operano in campo nazionale e gli “ispettori” tecnici periferici in campo regionale o provinciale. I dirigenti tecnici (ispettori), secondo l’art. 4 del DPR n. 417, contribuiscono a promuovere e a coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione, di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dagli organi collegiali a livello provinciale in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche e attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi. I dirigenti tecnici (ispettori) svolgono, altresì, attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, gli ex soprintendenti scolastici e gli ex provveditori agli studi (attualmente Uffici scolastici regionali e ambiti territoriali). Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi. L’articolo 4 del DPR n. 517/1974 è, poi, confluito, nel 1994, nel D.lgs. n. 297 (artt. 419 e 420). Gli “ispettori” tecnici centrali e periferici, tuttavia, superano, dopo una lunga lotta dei secondi, con la Legge 27 dicembre 1989, n. 417, che ha convertito il D.L. n. 357/1989, la diversificazione, in base all’art. 5, comma 7 e diventano un unico ruolo con funzioni diversificate in base alle aree.
d. Art. 21 della Legge n. 59/1997 e l’autonomia delle istituzioni scolastiche
Nel 1997, la Legge n. 59 del 15 marzo ha, per di più, fissato, all’art. 21, l’autonomia didattica e organizzativa per le scuole. Il dirigente tecnico è una figura professionale, che, nella pubblica istruzione, svolge la funzione ispettiva e, in tale compito, nell’autonomia scolastica, diventa un valido tecnico, a livello conoscitivo e valutativo, diretto all’analisi dell’attività, svolta nelle varie realtà scolastiche con la finalità di supportarle nella crescita e nel miglioramento. Il servizio del corpo o contingente ispettivo-tecnico fa, a livello normativo, oggi parte, in maniera integrante, del Sistema nazionale di valutazione (DPR n. 80/2013). La denominazione di corpo ispettivo-tecnico è assunta dall’art. 9 del DPR n. 17 del 2009, che, al comma 1, recita “il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per l’istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro”. Il sistema nazionale di valutazione (DPR n. 80/2013), che attua la Legge n. 10 del 2011, ha rilevanza anche dal punto di vista dell’armonizzazione con le politiche dell’Unione europea, perché, attraverso le attività, che svolge, riesce a fare un’analisi accurata della condizione della scuola italiana, e, di conseguenza, a individuarne punti di forza e criticità. L’assunzione del ruolo di “ispettori” tecnici è, pertanto, diretto ad ampliare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio scolastico, svolgendo compiti ampiamente rilevanti, nel sistema d’istruzione e formazione, sia a livello centrale che sul territorio. L’attività è esercitata nelle istituzioni scolastiche italiane statali e paritarie di ogni ordine e grado, a livello periferico, centrale e all’estero, secondo quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009. “L’ispettore”, oggi dirigente tecnico, per il suo compito e nella sua mansione: predispone ed elabora progetti per perseguire e realizzare gli obiettivi indicati dal MIUR per quanto concerne la politica scolastica; svolge assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche, ai sostegni didattici e alle tecnologie educative; promuove e facilita le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; organizza e svolge attività di assistenza tecnico-didattica, di studio, di ricerca e di consulenza sui progetti di sperimentazione; realizza verifiche e ispezioni, disposte dal Ministro e dagli Uffici dell’amministrazione scolastica; coordina il Sistema nazionale di valutazione e gli esami di Stato; vigila sugli Enti di formazione (Direttiva n. 170/2016); controlla e vigila sul sistema delle scuole paritarie e straniere (Decreti nn. 82 e 83/2009); interviene su ispezioni disposte (D.lgs. n. 297/1994); coordina il Nucleo esterno di valutazione (NEV); coordina il Nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici (Direttiva n. 36/2016); interviene quando un docente, immesso in ruolo, deve affrontare il secondo anno di prova, e su incarichi specifici.
e. La direttiva del 2 luglio 2002 e gli obblighi dell’ispettore tecnico
La Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto riguarda le attività di ispezione, al fine di garantire l’efficienza e l’imparzialità, ha emanato la Direttiva 2 luglio 2002 nella quale si elencano le gli obblighi dell’ispettore, oggi dirigente tecnico, vale a dire: porre le proprie iniziative su imparzialità, su autonomia di giudizio e su una buona conduzione dell’attività esercitata (principi sanciti dalla Costituzione); conoscere e analizzare l’attività e la normativa dell’ente o dell’ufficio sottoposto ad ispezione; condurre l’intera ispezione con rigorosa riservatezza; tenere un comportamento assertivo ma disponibile, esercitando le proprie funzioni nel rispetto dei diritti e delle opinioni di chi è ispezionato; avanzare osservazioni e proposte sulla base dell’obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi; non turbare il regolare funzionamento della struttura ispezionata; fondare i referti e i rilievi su elementi probanti e circostanziati; assicurare la trasparenza della documentazione in modo da rendere l’ispezione dimostrabile in ogni suo atto; comunicare i risultati dell’ispezione al soggetto o alla struttura ispezionata. Le regole proposte nella direttiva presuppongono che, quando l’ispettore incaricato, oggi dirigente tecnico, non si sente in grado di assicurare l’imparzialità e l’estraneità personale, deve rinunciare ad effettuare la verifica. La formazione, la professionalità e la competenza sono, pertanto, un diritto e un dovere dell’ispettore/dirigente tecnico. La sua preparazione deve essere costantemente aggiornata per iniziativa personale ovvero partecipando a corsi specifici. La formazione e la competenza sono i presupposti con cui l’ispettore/dirigente tecnico deve assolvere i propri obblighi di pubblico dipendente. La formazione dell’ispettore/dirigente tecnico è obbligatoria e si deve realizzare con la partecipazione ai corsi proposti dall’amministrazione di appartenenza, vale a dire con l’approfondimento e l’iniziativa personale. Per quanto concerne la formazione, non c’è distinzione tra chi assolve le mansioni di ispettore/dirigente tecnico con continuità e chi l’assolve per periodi di tempo circoscritti, in quanto tutte le esperienze di amministrazione attiva contribuiscono ad accrescere il bagaglio culturale necessario per lo svolgimento di una proficua attività ispettiva.
Secondo la Direttiva 2 luglio 2002, la professionalità, che presuppone sensibilità ed equilibrio, si traduce, fondamentalmente, nella capacità di prestare ascolto, di dialogare e di saper convincere chi lavora nella struttura ispezionata, per evitare il ripetersi degli errori riscontrati e migliorare la qualità delle prestazioni. La conoscenza e l’analisi dell’attività e della normativa dell’ente o dell’ufficio sottoposto a ispezione sono, di conseguenza, presupposti necessari allo svolgimento proficuo delle verifiche. L’attività ispettiva presuppone una preparazione idonea e si effettua in modo adeguato allorquando si conoscono preventivamente: l’attività e l’organizzazione dell’ente o dell’ufficio da ispezionare; i nominativi dei funzionari responsabili e le caratteristiche della gestione e dei servizi erogati; la normativa relativa e i suoi aspetti specifici; le finalità istituzionali e i modi con cui sono perseguite; le eventuali interazioni con altre amministrazioni; i risultati di eventuali precedenti ispezioni. L’intera ispezione deve essere, secondo la Direttiva 2 luglio 2002, coperta da rigorosa riservatezza. Pertanto, sono riservati i dati e le informazioni raccolte durante l’ispezione. Non sono ammissibili dichiarazioni in ambienti privati o pubblici, né ad organi d’informazione. Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di non servirsi delle informazioni d’ufficio per scopi personali. Nell’attività ispettiva, la riservatezza assume importanza determinante, perché il venir meno a quest’obbligo può: produrre un ingiusto danno all’ispezionato; ripercuotersi negativamente sull’immagine dell’amministrazione; ingenerare strumentalizzazioni da parte di altri soggetti. Fino al termine del lavoro, possono, inoltre, essere raccolti elementi nuovi, arrivando ad esiti conclusivi non prevedibili. L’ispettore/dirigente tecnico, quindi, non deve rilasciare dichiarazioni pubbliche, parlando nelle sedi dovute con i superiori o con gli organi competenti ed esprimendosi con verbali, referti, rilievi accessibili soltanto nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Chi effettua ispezioni deve essere assertivo, ma, nello stesso tempo, disponibile. Questo comportamento deve essere sempre orientato alla soluzione dei problemi emersi. I momenti sanzionatori e consultivi devono costituire una contrapposizione fisiologica dell’attività ispettiva. Va, comunque, evitato che emergano conflitti e incomprensioni con chi è sottoposto a ispezione o valutazione e che tende ad assumere atteggiamenti difensivi. È necessario che l’ispettore/dirigente tecnico faccia valere i propri principi ed eserciti i propri poteri senza prevaricazioni, nel rispetto dei diritti e delle opinioni di chi è ispezionato. Allo stesso tempo, la disponibilità, che si manifesta con un atteggiamento di ascolto e d’indirizzo, non deve svuotare i contenuti dell’attività ispettiva o ingenerare l’impressione di benevolenza, poiché essa ha unicamente lo scopo di contribuire alla soluzione dei problemi emersi e di ripristinare un funzionamento regolare nell’amministrazione. L’obiettivo da conseguire è sempre quello di generare nell’interlocutore tutta la collaborazione necessaria per analizzare le ragioni che hanno causato un determinato disservizio. L’obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi considerati sono alla base delle osservazioni e delle eventuali proposte di orientamento avanzate dall’ispettore/dirigente tecnico. Questi può, procedendo con metodo basato su elementi probanti, rendere condivisibili le osservazioni mosse, mostrare l’obiettività dei suoi accertamenti, il valore significativo delle proposte, la rilevanza dei risultati. Solo la validità della metodologia d’indagine porta, nell’ambito dell’ufficio ispezionato, un contributo che si concretizza in una amministrazione più forte nelle decisioni e più efficace nei servizi prestati.
L’ispettore/dirigente tecnico deve turbare il meno possibile il regolare funzionamento della struttura ispezionata, perché, intervenendo su una struttura che svolge servizi per la collettività, può anche provocare delle alterazioni rispetto al normale svolgimento dell’attività istituzionale; perciò, deve essere sua cura limitare al massimo disfunzioni o ostacoli al regolare funzionamento degli uffici onde evitare, anche parzialmente, la paralisi dell’ente o dell’ufficio ispezionato, fatta salva la necessità di evitare danni ulteriori. L’amministrazione ispezionata deve, comunque, mettere l’ispettore/dirigente tecnico nella condizione di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni richieste e i mezzi necessari, senza, per questo, andare incontro ad un innalzamento dei costi. I rilievi e i referti devono fondarsi su elementi probanti e circostanziati. Nei rilievi e nei referti da inviare agli uffici preposti e alle competenti magistrature, le relazioni dell’ispettore/dirigente tecnico devono essere sempre circostanziate, fondate su elementi evidenti e inconfutabili e, se necessario, verificate con i vertici della struttura ispezionata. L’ispezione deve essere dimostrabile in ogni suo atto. Questa condizione deve essere garantita dai verbali, dalle relazioni, dagli estratti della documentazione e di ogni altro elemento utile. L’ispezione, oltre ad essere oggettiva sia per il metodo sia per gli elementi probanti, deve essere dimostrabile e documentabile in ogni sua parte, partendo dalle problematiche incontrate sino ai risultati finali. Con il termine “dimostrabile” si fa riferimento alle raccolte, agli elenchi e ai verbali in cui sono riportati circostanze, documenti, elaborazioni, relazioni, testimonianze, dichiarazioni, come elementi che devono permettere di ricostruire l’intera ispezione senza ricorrere a nuove indagini e verifiche. I risultati dell’ispezione devono essere comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata. Questa condizione è necessaria per garantire interventi di correzione e di tutela da parte dei soggetti titolari degli organi coinvolti nell’ispezione. L’attività ispettiva fine a se stessa non serve a nulla e, perciò, ad essa devono seguire processi correttivi o di autotutela degli organi che sono abilitati ad intervenire. La comunicazione dei risultati dell’ispezione dà valore aggiunto al buon andamento della pubblica amministrazione e rispetta i principi enunciati nel Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il comunicare, per di più, i risultati di un’ispezione, condotta nel rispetto delle regole descritte nella direttiva, contribuisce a diffondere la trasparenza (Legge 241/1990, D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016) delle attività della pubblica amministrazione.
f. L’organizzazione del MIUR
Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’art. 49, stabilisce, al comma 1, che al ((Ministero dell’istruzione e del merito)) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e all’articolo 13, comma 1, del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40. Al comma 2 si sostiene che al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti, di cui all’articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni e agli Enti locali. È fatta, altresì, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Lo stesso decreto, all’art. 50, afferma che il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; promozione del merito e valutazione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle Regioni e degli Enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell’università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito; promozione dell’internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative, finalizzate alla valorizzazione ((del merito e all’incremento)) delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l’istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale, nonché attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea; consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell’istruzione, finanziati dall’Unione europea; istituzioni, di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 300 si sostiene che il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali, di cui all’articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ((ventotto)), ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
Successivamente, nel 2003, il DPR n. 319 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – all’art. 2, recita che il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tre dipartimenti (co. 1). I dipartimenti, al comma 2, assumono rispettivamente la denominazione di: Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione; Dipartimento per l’istruzione; Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Nell’ambito dei già menzionati dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale, di cui agli articoli 5, 6 e 7. Il Ministero è, al comma 3, articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali, di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al comma 4 si afferma che con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti. Negli anni successivi, il DPR del 21 dicembre 2007, n. 260 – Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione – all’art. 5, stabilisce che il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale, nonché attuazione di politiche dell’educazione comuni ai Paesi dell’Unione europea; assetto complessivo dell’intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi, degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie, di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all’associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all’amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni, di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attività di comunicazione istituzionale, di convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del Ministero (co. 1).
Il comma 2 afferma che al dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali e ((n. 36 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva)). Il comma 3 recita che il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica; direzione generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, nonché per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni; direzione generale per il personale scolastico; direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Il comma 4 fissa che la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: ordinamenti, curricula e programmi scolastici; definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonché dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; sistema delle scuole paritarie e non paritarie; ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell’istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; indirizzi in materia di libri di testo; esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado con riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi; certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri; adempimenti ministeriali per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; attività preliminari all’adozione delle direttive, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; vigilanza sull’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sull’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, nonché vigilanza e sorveglianza, di cui all’articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti.
Al comma 5 si afferma che la direzione generale, per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il comma 6 dispone che la direzione generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: sostegno allo sviluppo dell’area dell’istruzione tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti riguardanti l’innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali; ordinamento dell’istruzione degli adulti nell’ambito dell’apprendimento permanente; predisposizione delle linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro o PCTO, di orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia; cura delle attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città metropolitane e autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell’alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali; cura delle attività istruttorie riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il comma 7 sostiene che la direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali ((. . .)), svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione; indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; definizione sia delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sia dei parametri per la ripartizione a livello regionale; definizione delle linee di indirizzo e di coordinamento della formazione e dell’aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, nonché della programmazione delle politiche formative a livello nazionale; indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti, di cui alla Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia; gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Al comma 8 si afferma che la direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola in ((n. 8 uffici dirigenziali non generali)), svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: disciplina e indirizzo in materia di status dello studente; cura dei servizi per l’integrazione degli studenti in situazione di handicap, nonché di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie; cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; elaborazione delle strategie sulle attività e sull’associazionismo degli studenti; cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti; attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; interventi di orientamento e promozione del successo formativo e relativo monitoraggio; supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; cura delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell’Amministrazione; cura delle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità; cura dei rapporti con il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero; coordinamento del sito Web dell’amministrazione; promozione di attività, di convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione; analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l’informazione e la relativa divulgazione; promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonché campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di competenza del Ministero. Il comma 9 tratta la direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione come responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e come soggetto che indirizza l’attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Il Decreto MIUR del 26 settembre 2014, n. 753 – Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – all’art. 2, comma 1, tratta gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero, individuati nell’allegato 1 del presente decreto. Il comma 2 recita che agli uffici dell’Amministrazione centrale possono essere, altresì, assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonché di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al comma 3 si sostiene che i dipartimenti e le direzioni generali dell’Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l’articolazione e con le attribuzioni indicate negli allegati 2, 3 e 4. Il comma 4 recita che ciascun ufficio dirigenziale non generale, ove non prevista la costituzione di appositi uffici, provvede, nelle materie di propria competenza, alla gestione del contenzioso, al monitoraggio e al coordinamento della normativa, al supporto dell’istruttoria di atti normativi e di sindacato ispettivo parlamentare, nonché all’istruttoria e alla redazione di provvedimenti di rilevanza generale. Al comma 5 si sostiene che Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca assicura il supporto agli organismi previsti dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca, di cui all’allegato 5. Il Decreto MIUR n 753/2014, all’art. 3, comma 1, stabilisce, altresì, che i posti di dirigente con funzione ispettiva tecnica, per un totale di 191 unità, sono assegnati all’Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, nel numero di 30, e agli Uffici scolastici regionali, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel numero di 161, ripartiti come da allegato 6. I posti assegnati all’Amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Al comma 2 stabilisce anche che i dirigenti con funzione ispettiva tecnica – ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato – svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnicodidattico-pedagogico; funzione ispettiva anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell’assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici; supporto tecnico-scientifico per le tematiche e i processi definiti dall’Amministrazione. Con l’atto di indirizzo del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.
Nel 2019, con due D.P.C.M. (nn. 47 e 48) del 4 aprile si regolamentano sia l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sia gli Uffici di diretta collaborazione. I provvedimenti disciplinano l’organizzazione del dicastero di viale Trastevere, nella sua articolazione a livello centrale nei tre Dipartimenti: il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, n. 48, ha disposto (con l’art. 14, comma 3, lettere a) e b)) che la tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 (11 febbraio 2014), è modificata come segue: con riferimento alle posizioni dirigenziali di prima fascia, sono soppresse le parole: «compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro»; con riferimento alle posizioni dirigenziali di seconda fascia amministrative, le parole soppresse sono «compresi dieci posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di valutazione» e sostituite dalle seguenti: «compresi otto posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro».
g. Gli atti di indirizzo e le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.
Nel 2010, il DM n. 60 stabilisce il primo atto di indirizzo con il quale vengono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva. Con la Nota del MIUR del 31 agosto 2010, prot. n. 2668, vengono, poi, determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva. Successivamente, il MIUR, nel 2017, ha emanato un altro atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica mediante il D.M. n. 1046 del 28 dicembre, firmato dal Ministro Valeria Fedeli. Tale atto di indirizzo con una nota, datata 11 aprile del 2018, viene, poi, trasmesso con la firma del capo dipartimento del MIUR con le seguenti parole: è un atto che “rafforza il ruolo della funzione dirigenziale tecnica nei processi di attuazione del Sistema nazionale di valutazione e conferma la centralità della funzione ispettiva tecnica nell’azione di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sottolineando, in proposito, la necessaria relazione sinergica che deve intercorrere tra l’esercizio dei compiti affidati al Corpo ispettivo e l’azione amministrativa affidata alle strutture centrali e territoriali dell’Amministrazione”. Infine, il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2022, n. 41, fissa, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.166, in un documento, suddiviso in quattro parti, le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva. La premessa è la prima parte. Nella “Premessa” sono definiti identità, ruolo e importanza del corpo ispettivo, che concorre alla realizzazione dei compiti di istruzione e di formazione delle istituzioni scolastiche; orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva internazionale; realizza l’attività ispettiva di supporto dei processi formativi e di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; svolge attività di studio, ricerca e consulenza tecnica. La dirigenza con funzione tecnico-ispettiva è qualificata come “espressione di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico”, e come risorsa fondamentale per sostenere e sviluppare una scuola attenta, inclusiva e al servizio della persona. Ne viene fuori un ritratto a tutto tondo della figura, impegnata nella valutazione orientata al miglioramento, coinvolta nella formazione del personale scolastico e chiamata a sostenere l’innovazione. Una professione aperta ai migliori talenti coltivati nelle istituzioni scolastiche, capaci di affrontare le sfide del futuro.
Le modalità di esercizio della funzione tecnico ispettiva sono la seconda parte. La sezione dedicata alle “modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva” si compone di un’ampia ricognizione delle diverse attività affidate ai dirigenti tecnici. Non un elenco di compiti, ma piuttosto una panoramica sui principali ambiti di intervento, organizzati e aggregati in cinque macroaree: “sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi”, “supporto al processo di valutazione e autovalutazione”, “supporto tecnico-didatticopedagogico”, “supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall’Amministrazione”, “accertamenti ispettivi”.
Nella terza parte è trattata la formazione dei dirigenti con funzione tecnico ispettiva. Un’importante novità, dedicata alla “Formazione dei dirigenti con funzione tecnico ispettiva”, che segnala la rilevanza del costante aggiornamento di competenze, visioni prospettiche e scenari di riferimento per l’impegno professionale del corpo ispettivo. La formazione continua e qualificata costituisce una condizione essenziale per le prestazioni professionali all’altezza delle attese di un’azione tecnica come un efficace supporto e accompagnamento e alle scelte didattiche innovative. La quarta parte affronta l’organizzazione della funzione tecnico ispettiva: il corpo o contingente ispettivo. L’ultima sezione, dedicata all’organizzazione della funzione, ribadisce la collocazione dei dirigenti tecnici a livello centrale e territoriale, i ruoli e i compiti del Coordinatore nazionale, di quelli regionali e delle Segreterie tecniche. Il decreto costituisce un passo importante nella direzione del potenziamento del corpo o contingente ispettivo, previsto nell’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro. L’indizione del concorso per il reclutamento dei dirigenti tecnici costituisce, pertanto, un’ulteriore tappa per sostenere i molteplici compiti della dirigenza tecnica, al servizio della Scuola italiana.
h. La procedimentalizzazione dell’attività ispettiva
Il dirigente tecnico svolge, tra le altre mansioni, quelle previste nel Decreto Interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009, vale a dire: organizza ed elabora i progetti per attuare gli obiettivi indicati dal ministro in materia di politica scolastica; fa consulenza in merito ai programmi scolastici, ai sussidi didattici e alle tecnologie educative; favorisce e promuove le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado; fa attività di assistenza tecnico-didattica, di studio, di ricerca e di consulenza sui progetti di sperimentazione; esegue verifiche e ispezioni riguardanti alcune specifiche situazioni disposte dal Ministro o dagli uffici dell’Amministrazione scolastica.
L’attività ispettiva è, di regola, un’azione istruttoria che rappresenta un sub-procedimento di un procedimento amministrativo. Essa si compone di alcune fasi, quali l’iniziativa, l’istruttoria e la decisione. Durante la procedimentalizzazione dell’attività ispettiva, bisogna, nel rispetto della trasparenza, imparzialità e obiettività, assicurare che il soggetto ispezionato possa essere consapevole e compartecipe. La Legge n. 241/1990 è, infatti, una normativa che prospetta la necessità che tutte le amministrazioni dello Stato devono diventare serventi e mettersi al servizio dei cittadini. L’ANAC, istituito con la Legge n. 190/2012, ha, perciò, il 9 dicembre del 2014 prodotto un Regolamento in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300. A tal proposito, è stato istituito un Ufficio ispettivo, prevedendo che lo stesso svolgesse attività di verifica ispettiva per iniziare dei procedimenti. Il gruppo dell’attività ispettiva è generalmente formato da due unità (dirigenti tecnici, scelti nel provvedimento presidenziale ispettivo, e personale della Guardia di Finanza allo scopo individuato). Può, tuttavia, farne parte anche il Dirigente dell’Ufficio Ispettivo (UIS). Le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo, approvato dal Consiglio dell’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell’Ufficio piani di vigilanza generali o speciali. Nell’ambito degli accertamenti ispettivi svolti, esse possono essere richieste anche nell’ambito dei procedimenti istruttori, avviati dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi”. L’attività ispettiva può essere avviata “d’iniziativa” dell’ufficio ispettivo o a seguito di una richiesta d’intervento che deve essere quanto più circostanziata possibile al fine di semplificare le successive attività.
Il responsabile del procedimento è, in base all’art. 5 del Regolamento del 9 dicembre 2014, il dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia, il quale deve individuare il funzionario competente per lo svolgimento dell’istruttoria. Il dirigente, dopo aver esaminato gli esposti, conferisce all’incaricato un ordine di priorità tenendo conto dell’urgenza e della rilevanza delle questioni proposte. A parità di urgenza e/o rilevanza della segnalazione deve essere data priorità di trattazione agli esposti presentati con l’apposito modulo. Ogni 30 giorni, il dirigente competente invia al Consiglio l’elenco dei procedimenti avviati dall’Ufficio, con l’indicazione del funzionario come responsabile dell’istruttoria. La preparazione dell’ispezione è, in sostanza, una condizione basilare per la buona riuscita dell’iniziativa, giacché questa è diretta a conoscere preventivamente gli elementi essenziali non solo degli atti da acquisire ma anche del soggetto ispezionato. Nel 2002, la Direttiva del ministro Frattini (2 luglio), infatti, sostiene che ogni forma di “attività ispettiva presuppone una preparazione idonea e si effettua in modo adeguato se si conoscono preventivamente l’attività dell’ente o dell’ufficio da ispezionare, nonché la sua organizzazione; i nominativi dei funzionari responsabili, le caratteristiche della gestione e dei servizi erogati; la normativa relativa e i suoi aspetti specifici; le finalità istituzionali e i modi con cui sono perseguite; le eventuali interazioni con altre amministrazioni; i risultati di precedenti ispezioni”.
Le fasi del procedimento ispettivo
L’accertamento dell’attività ispettiva si articola, praticamente, in una successione di tre momenti distinti, vale a dire: il primo momento, nel quale sono, dopo l’accesso, svolte le attività di ricerca e di acquisizione dei documenti necessari alla successiva analisi; il secondo si identifica con l’esecuzione dell’ispezione nei luoghi indicati nell’incarico per verificare, rilevare e acquisire dati, informazioni e notizie, ritenuti necessari ai fini del perseguimento degli obiettivi dell’accertamento; il terzo momento (fase conclusiva) riassume le risultanze dell’attività svolta con una formale estrinsecazione nel redigere e nel sottoscrivere il verbale, nonché la conseguente redazione della relazione ispettiva da parte dei dirigenti tecnici. L’ispezione, in una logica di servizio e non di esercizio del potere, si deve svolgere secondo i parametri della correttezza, della trasparenza e dell’uniformità. La verbalizzazione dell’attività ispettiva deve non solo essere, perciò, svolta in loco ma anche dare un’immagine di oggettività e di neutralità, fotografando la situazione di indagine e di verifica. Il verbale di ispezione deve essere letto all’ispezionato, il quale ha anche il diritto di averlo in copia.
Il verbale di constatazione deve riportare l’indicazione degli ispettori che procedono all’ispezione con gli estremi delle lettere di incarico e dell’eventuale assistenza del personale della Guardia di Finanza; l’effettuazione della notifica e della consegna del provvedimento ispettivo con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto le notifiche; la data e l’ora dell’inizio e della chiusura delle operazioni; l’identificazione del soggetto ispezionato e della sede presso cui è stata svolta l’ispezione; l’oggetto dell’ispezione; la persona che ha assistito alle operazioni; le eventuali obiezioni e contestazioni; le richieste di informazioni e di chiarimenti, nonché le risposte o l’eventuale termine concesso; il rifiuto di rispondere alle richieste, specificando le eventuali motivazioni addotte; l’elenco dei documenti, di cui si acquisisce copia, e le eventuali contestazioni in ordine all’acquisizione, specificando i motivi addotti.
La relazione ispettiva
La relazione ispettiva, dopo la verifica e gli accertamenti disposti, da svolgere entro i termini fissati nella lettera di incarico per la conclusione dell’attività ispettiva, è redatta dai dirigenti tecnici e trasmessa, debitamente sottoscritta da tutti i partecipanti all’ispezione, al Dirigente dell’Ufficio ispettivo. La relazione ispettiva è, in sostanza, il documento conclusivo dell’attività svolta e deve essere consegnata, in coerenza con quanto stabilito dal vigente “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi”, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza temporale, fissata per la conclusione dell’attività ispettiva, o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. La relazione deve essere compilata con estrema precisione e cura, affinché possa rappresentare il massimo grado di comprensibilità ed esattezza; essa deve contenere gli estremi del mandato, la lettera di incarico, la data di inizio, la durata degli accertamenti ispettivi, la preliminare collocazione della fattispecie esaminata (specificando in termini sintetici l’ambito dell’istruttoria originaria in caso di accertamenti richiesti dagli Uffici Vigilanza), la rappresentazione oggettiva dei fatti rilevati e degli elementi riscontrati, gli eventuali profili di illegittimità, le eventuali criticità rilevate, nonché le eventuali circostanze che potrebbero configurare un’ipotesi di danno erariale o le fattispecie che assumono rilevanza penale e le eventuali proposte di soluzione. Nella stessa relazione si devono richiamare, in ordine progressivo, i documenti dell’ispezione e gli atti acquisiti dai dirigenti tecnici o corpo ispettivo a supporto delle considerazioni espresse; tali documenti e atti devono anche essere oggetto di specifica allegazione e accompagnati da un apposito indice esplicativo. I profili di una certa anomalia, rilevati nella relazione, devono avere, come riferimento, circostanze di rilievo e adeguatamente precisate. Tali rilievi devono, poi, essere riportati in modo oggettivo e circostanziato, nonché supportati da adeguati elementi probatori.
Ogni componente del contingente o corpo ispettivo deve, in ordine ai profili di anomalia da evidenziare, in modo preliminare, verificare se l’Autorità si sia già espressa al riguardo in precedenti pronunciamenti, e aver cura di chiarire nella relazione, nel caso che intenda discostarsi da tali orientamenti, le ragioni fattuali e giuridiche del diverso convincimento, al fine di consentire una compiuta valutazione da parte del Consiglio dell’Autorità. Il comma 11 dell’articolo 14 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi stabilisce che, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta nel corso delle visite, ogni dirigente tecnico o corpo ispettivo deve stilare una relazione finale, contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e l’eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di adozione di provvedimenti da parte del Consiglio. Il comma 12 fissa, poi, che, nei casi di cui al comma 2, la relazione ispettiva deve essere trasmessa, unitamente alla documentazione acquisita, agli Uffici competenti per la prosecuzione delle attività.
La relazione definitiva e conclusiva degli esiti ispettivi, redatta dai dirigenti tecnici o dal corpo ispettivo e controfirmata dal Dirigente dell’UIS, viene, infine, sottoposta al Consiglio dell’Autorità per le valutazioni di competenza. Nel caso emergano dall’attività ispettiva alcuni profili di irregolarità, soggetti a contestazione, la relativa comunicazione degli esiti degli accertamenti ispettivi deve essere fatta dal competente Ufficio di vigilanza in sede di contestazione degli addebiti; essa deve essere presentata e trasmessa nelle forme e con le modalità, di cui al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi, e tenendo conto delle indicazioni, presenti nella relazione ispettiva, e della collaborazione degli stessi ispettori e del dirigente dell’UIS.
La responsabilità e l’obbligo di denuncia
Bisogna anche considerare che l’art. 24 del DPR n. 3 del 1957, ancora vigente, schiarisce che, quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso. Il Decreto legislativo n. 174 del 2016 del Codice contabile all’art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione) afferma al comma 1 che, ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate. All’art. 53 (Contenuto della denuncia di danno) sostiene, inoltre, che la denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.