Una mappa per l’idrogeno: Incertezze e rischi per la sicurezza energetica
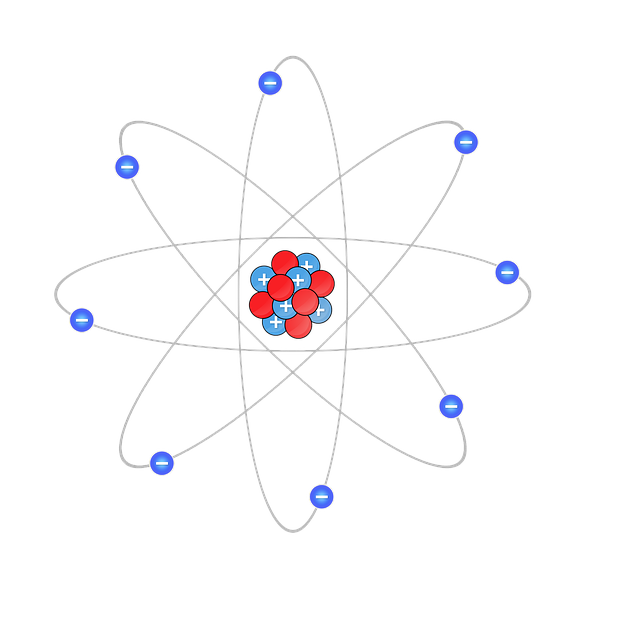
L’energia è considerata la linfa vitale delle società moderne e il motore della crescita economica globale. In un’epoca caratterizzata da instabilità e profonde trasformazioni, la transizione energetica riveste un ruolo cruciale nel ridefinire il nostro futuro. Grazie a investimenti senza precedenti nelle energie rinnovabili e a politiche sempre più orientate alla riduzione delle emissioni di gas serra, si punta su fonti alternative come il solare e l’eolico, oltre a tecnologie innovative come l’idrogeno.
La necessità di nuove strategie energetiche
In questo contesto, i Paesi devono adottare nuove strategie per garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e razionale. Stabilire strategie adeguate per l’importazione di energia è essenziale per rafforzare la competitività economica di una nazione. La crescente domanda di risorse energetiche alternative, dalla produzione di batterie agli impianti per l’idrogeno, ha intensificato la competizione globale per l’accesso a materie prime come litio, cobalto, coltan e gas naturale.
La sfida è duplice: diversificare le fonti energetiche per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e mantenere la stabilità economica e geopolitica. La politica commerciale gioca un ruolo fondamentale nell’assicurare l’accesso a risorse energetiche sufficienti e a costi competitivi.
La crisi energetica europea e il ruolo dell’idrogeno
La recente crisi energetica in Europa, scaturita dal conflitto russo-ucraino e dal sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, ha evidenziato la precarietà delle forniture e le vulnerabilità delle infrastrutture globali. Questo ha accelerato la necessità di diversificare le fonti energetiche. L’idrogeno è emerso come una soluzione potenziale per rafforzare la sicurezza energetica, rendendo le strategie di importazione uno degli aspetti chiave per la sicurezza energetica di una nazione.
Tradizionalmente, la dottrina liberale del libero scambio era vista come la chiave per il successo economico. Tuttavia, i Policymaker stanno ora influenzando attivamente le politiche energetiche attraverso decisioni mirate che coinvolgono importazioni, infrastrutture e investimenti in nuove tecnologie.
L’ascesa delle potenze economiche e l’idrogeno
L’ascesa di nuove potenze economiche come Cina, Russia e India ha avuto un impatto significativo sulle strategie di approvvigionamento energetico globali. La Cina, in particolare, ha consolidato il suo predominio nei settori chiave delle energie rinnovabili e delle risorse energetiche a basso impatto carbonico, come l’idrogeno, il litio e il cobalto.
L’idrogeno è visto come uno strumento energetico promettente, capace di svolgere un ruolo chiave in vari settori, dall’industria ai trasporti, fino alla produzione di energia elettrica. La sua versatilità e la possibilità di essere prodotto tramite fonti rinnovabili, come l’idrogeno verde, lo rendono indispensabile per la decarbonizzazione. Tuttavia, la crescente domanda di idrogeno ha sollevato nuovi dilemmi ambientali e geopolitici.
Iniziative strategiche in Europa
L’Unione Europea si distingue per aver ideato iniziative strategiche come la Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe, che riconosce l’idrogeno come fondamentale per la decarbonizzazione. Progetti come il NextGenerationEU hanno finanziato numerosi progetti nel settore dell’idrogeno, mentre il lancio della European Hydrogen Bank e l’Innovation Fund stimolano l’adozione su larga scala di questa risorsa.
Dopo aver affrontato le difficoltà legate alla dipendenza dal gas russo, l’Europa ha deciso di puntare sull’idrogeno come vettore energetico alternativo. Nel 2023, si è registrato un incrementato interesse per i progetti legati all’idrogeno verde, con investimenti stimati in 570 miliardi di dollari. Tuttavia, il settore affronta sfide legate all’aumento dei costi e a variabili esogene ed endogene.
Ostacoli e opportunità
Uno dei principali ostacoli è il costo: la produzione e il trasporto di idrogeno verde sono ancora troppo costosi. Inoltre, l’industria deve affrontare difficoltà nella costruzione di impianti di elettrolisi e nella conversione delle infrastrutture esistenti per il trasporto di gas naturale. Nonostante le previsioni di crescita, si stima che nel 2025 la produzione di idrogeno calerà del 10% a causa di queste difficoltà.
In Europa, le infrastrutture attuali per il trasporto di gas naturale dovranno essere adattate per gestire l’idrogeno. Paesi come la Germania stanno investendo massicciamente nella creazione di corridoi energetici, come il Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, mentre l’Italia ha avviato la “Strategia Nazionale per l’Idrogeno” e il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Disparità globali nella transizione energetica
La transizione energetica non avviene in modo uniforme nel mondo. Mentre l’Europa e altre economie avanzate spingono per una rapida decarbonizzazione, i Paesi in via di sviluppo affrontano enormi ostacoli. L’Africa, nonostante il suo potenziale, continua a rimanere energivora, con un consumo energetico pro capite tra i più bassi al mondo.
Attori internazionali come Cina, Russia e India stanno intensificando la loro influenza in Africa, offrendo supporto economico e infrastrutturale in cambio di accesso alle risorse naturali. Negli Stati Uniti, sono stati introdotti incentivi fiscali per la produzione di idrogeno, mentre in India la “National Green Hydrogen Mission” mira a far diventare il Paese un leader nel settore.
La strada da percorrere
Nonostante le iniziative positive, la domanda di idrogeno nell’Unione Europea rimane relativamente bassa, rappresentando meno del 2% del consumo energetico nel 2022. La sfida principale rimane quella di ridurre i costi di produzione e costruzione delle infrastrutture necessarie, poiché l’idrogeno è ancora troppo costoso per competere con il gas naturale e altre fonti di energia rinnovabile.
Tuttavia, con gli investimenti giusti, l’idrogeno potrebbe diventare un’alternativa per immagazzinare energia e alimentare veicoli a zero emissioni. La sua affermazione richiede di affrontare sfide economiche, tecnologiche e geopolitiche, ma anche di cogliere le opportunità offerte dalla cooperazione internazionale.
L’idrogeno rappresenta un’opportunità unica per affrancarsi dalle fonti fossili e raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica. Tuttavia, il settore necessita di un supporto politico e finanziario continuo, insieme a investimenti in infrastrutture e tecnologia. La mappa globale dell’idrogeno è ancora in fase di definizione, ma la sua realizzazione richiede azioni rapide e coordinate, unite a una visione comune per il futuro.
Gabriele Cicerchia

