M. Bruckner, Verso destinazione ignota
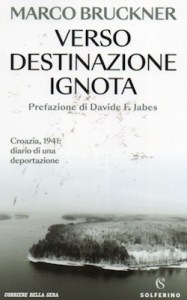
Marco Bruckner, la sua storia
di Antonio Stanca
A Gennaio è uscito, allegato al Corriere della Sera, primo numero delle “Storie Solferino”, Verso destinazione ignota (Croazia 1941: diario di una deportazione) di Marco Bruckner. È un’ampia narrazione dove l’autore ricostruisce quanto successo nel 1941 contro gli Ebrei della vecchia Jugoslavia, la persecuzione, la deportazione subite da parte dei militari tedeschi e italiani che avevano occupato quei territori, e degli Ustascia, milizie fasciste del posto.
Bruckner si è laureato in Filosofia all’Università di Milano e gli studi di storia rientrano tra i suoi interessi insieme alla collaborazione con La Gazzetta dello Sport. In quest’opera dice di un’esperienza vissuta un giorno lontano da lui, ancora ragazzo, e dal nonno Bruno nella casa di questi a Ferrara. Su richiesta del nipote il nonno si era dilungato ad illustrare, ampliare quanto scritto su un vecchio diario, diventato patrimonio famigliare. Qui un’antenata, la bisnonna Medea, aveva riportato la triste vicenda vissuta da lei, dal marito Carlo e dai figli Bruno e Nada quando nel 1941 la Germania aveva occupato la Croazia e a Zagabria, dove la famiglia risiedeva, i tedeschi li avevano arrestati e portati all’interno della Jugoslavia in posti diversi, compresi campi di concentramento. Era l’inizio di una delle prime deportazioni inflitte a persone di origine ebrea. Tra gli antenati di Marco il bisnonno Carlo aveva ascendenze ebree. La sua famiglia, però, il suo lavoro, gli avevano permesso di raggiungere una condizione sociale di livello, una posizione abbastanza distinta e rispettata. Faceva parte, insieme alla moglie, della ricca borghesia del posto. Né lui né lei pensavano che avrebbero corso seri pericoli per sé o per i figli. Fidavano, se ci fosse stato bisogno, nell’aiuto di personaggi, di famiglie molto influenti con le quali erano in contatto. Intanto, però, i maltrattamenti nei loro riguardi da parte dei militari che li avevano arrestati erano uguali a quelli usati per gli altri deportati, non veniva risparmiato loro nessun sacrificio, nessuna fatica, sofferenza, pena. In vagoni sudici, su tradotte lentissime, a piedi, scalzi, svestiti, sotto il sole rovente o al freddo rigido, si videro costretti a viaggiare, camminare, correre per coprire le distanze tra i tanti luoghi dove sarebbero stati portati, ammassati e dove avrebbero dovuto mangiare e dormire. Avrebbero sofferto, invece, la fame, la sete, il sonno, la sporcizia, erano le torture peggiori, erano le condizioni che avrebbero portato all’insorgere, alla diffusione di contagi, di malattie, di morte.
Dopo alcune delle tappe del lungo viaggio, Carlo era stato separato dalla famiglia, Medea aveva proceduto insieme ai figli che stentavano a reggersi causa le continue privazioni alle quali erano sottoposti. Anche lei stava poco bene, non poteva resistere ad uno sforzo simile, la sua famiglia, la sua condizione sociale l’aveva tenuta lontana da certe situazioni. Non solo a patirle in prima persona era chiamata ora insieme ai figli ma anche a vederle sofferte dai compagni di sventura, inflitte ai presunti colpevoli. Una storia di orrori era diventata in poco tempo la loro e quella di tutti gli altri deportati. Spesso sparivano interi gruppi di questi senza che si sapesse come era successo, dove erano finiti. Sconosciuti rimanevano tanti aspetti, tanti episodi di quella marcia che in tanti modi avveniva e della quale “ignota” fino alla fine sarebbe rimasta “la destinazione”. Si riduceva, inoltre, il numero dei prigionieri che la compivano giacché si moriva di stenti, di malattie, per crudeli punizioni. Con Carlo Medea e i figli si ritroveranno durante uno di quei continui traslochi tra piccoli centri, campi di concentramento o di lavoro già presenti nella Croazia, nella Slovenia, nella Bosnia, nella Serbia e in altre regioni della vecchia Jugoslavia. Qui le deportazioni erano cominciate prima del 1941, anche i campi di concentramento c’erano da prima. Una situazione di diffusa tensione ne era derivata e nel 1941 questa si era inasprita al punto da far vivere nella paura, nel terrore molte di quelle popolazioni. In uno dei tanti risvolti della sua particolare vicenda Carlo sarebbe sparito e della sua morte si sarebbe saputo dopo, ai tempi della liberazione. Soltanto allora, quando erano passati molti mesi dall’inizio della grave vicenda, prima i figli e poi Medea erano stati liberati e avevano potuto far ritorno a Trieste, riformare la loro famiglia, tornare a vivere. Nel 1944 Medea penserà di scrivere di quanto accaduto, di quanto vissuto, vorrà creare un diario che sarà quello dal quale erano partiti Marco e il nonno Bruno all’inizio di quest’opera, quello che l’aveva ispirata. Particolare la si può dire giacché a contatto diretto con un evento così grave, così ampio, con un tempo così prolungato, riesce a mettere, da vicino fa vedere com’era cominciata la Shoah. Semplice, chiaro è, inoltre, il linguaggio usato, un racconto sembra di leggere, uno di quelli capaci di far vedere, di far capire meglio quanto è successo.

 Versione per la stampa
Versione per la stampa