Le sillabe in greco antico
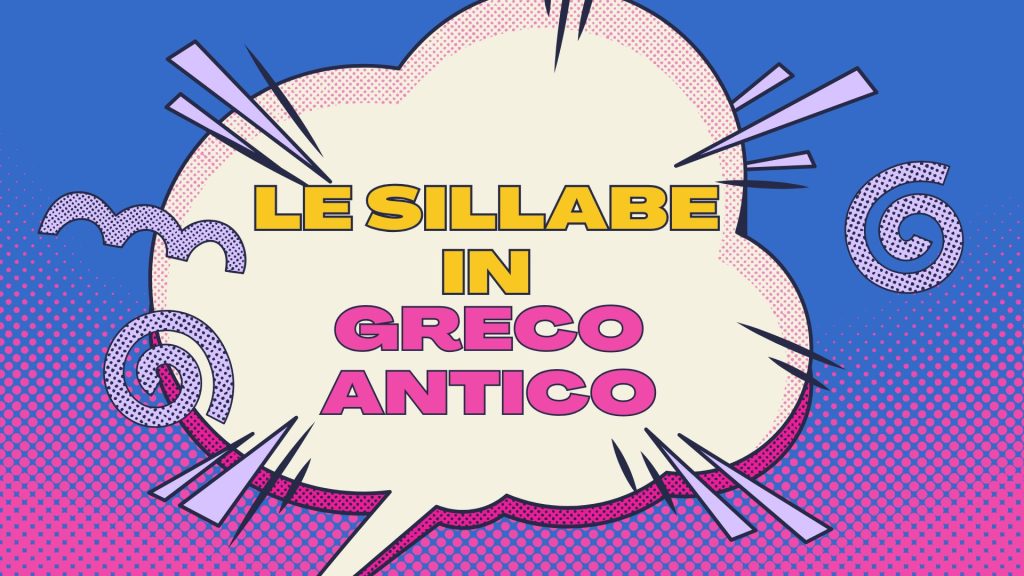
La lingua greca, pur nella sua complessità e diversità, presenta alcune somiglianze con l’italiano, tra cui la struttura sillabica. La sillaba rappresenta infatti uno degli elementi principali per la composizione di parole, poiché essa è data dall’unione di suoni vocalici e consonantici. Qualora tu non conosca la definizione di vocali e consonanti ti consigliamo vivamente di consultare i nostri articoli precedenti. Qualora, invece, hai ben chiaro la definizione di quei concetti e cerchi degli approfondimenti o dei chiarimenti relativi alle sillabe, questo articolo potrebbe far al caso tuo.
Se ritieni che i nostri articoli non siano abbastanza completi o vorresti che venisse analizzato un certo argomento, scrivilo nei commenti: saremo ben lieti di risponderti e magari di accontentarti nelle tue richieste. Se invece sei favorevolmente colpito dal contenuto dei nostri post, ti invitiamo a pubblicare quest’articolo sul tuo social preferito, che sia Facebook, Instagram o WhatsApp, affinché tutti possano venire al corrente di quello che tu hai imparato.
Definizione
La sillaba (in greco συλλαβή, che significa “insieme di suoni”) è costituita dall’unione di un suono vocalico con uno consonantico. In alcuni casi, può essere formata anche da un dittongo, cioè da due vocali unite. Se una sillaba termina con una vocale, viene definita aperta; se invece termina con una consonante, è chiamata chiusa.
La divisione in sillabe
Nel greco antico, la suddivisione in sillabe segue le stesse regole del latino. Possiamo individuare alcune situazioni specifiche:
- Una vocale isolata può costituire una sillaba a sé stante (es. ή-μέρα, “giorno”).
- Una consonante, per formare una sillaba, deve necessariamente unirsi a una vocale (es. ή-μέ-ρα, “giorno”).
- Se ci sono due o più consonanti insieme, queste si aggregano alla vocale successiva per formare una sillaba (es. πέ-πλος, “peplo”; ἔ-στρε-φον, “volgevo”).
- Quando tra due vocali si trovano due o più consonanti, la prima si unisce alla vocale precedente, mentre la seconda si lega a quella successiva (es. ἄν-θρω-πος, “uomo”).
- Se due consonanti uguali si trovano tra vocali, vengono separate: la prima resta con la vocale precedente, la seconda si unisce alla successiva (es. ἀγ-γέλ-λος, “messaggero”).
- Nel caso di parole composte, la suddivisione segue la struttura degli elementi che le compongono.
Fenomeni fonetici
Nel greco antico, esistono diversi fenomeni fonetici che, agendo sulle sillabe, modificano la struttura delle parole. Ecco un elenco dettagliato:
1. Epéntesi (ἔνθεσις, “inserzione”)
L’epentesi è l’inserimento di un suono all’interno di una parola, solitamente per facilitare la pronuncia.
Esempio: Il verbo γέγονα (“sono diventato”) presenta una gamma epentetica tra γε- e -ονα.
2. Monottongazione
La monottongazione è la trasformazione di un dittongo in una vocale semplice (monottongo).
Esempio: In epoca ellenistica, il dittongo αι venne pronunciato come ε (es. παῖς → πες).
3. Metatesi (μετάθεσις, “spostamento”)
La metatesi è lo scambio di posizione tra due suoni all’interno di una parola.
Esempio: ἀμέλγω (“mungere”) deriva dalla forma arcaica ἀμέργω.
4. Sinalefe (συναλοιφή, “fusione”)
Fenomeno per cui due vocali adiacenti, appartenenti a parole diverse, si fondono in una sola nella pronuncia.
Esempio: καὶ ἐγώ può diventare κἀγώ.
5. Sincope (συγκοπή, “taglio”)
La sincope è la caduta di un suono all’interno di una parola.
Esempio: ἀναγινώσκω (“leggo”) diventa ἀν-γινώσκω in alcune forme poetiche.
6. Apocope (ἀποκοπή, “taglio alla fine”)
Si verifica quando una parola perde un suono alla fine.
Esempio: τί εἶ (“che sei?”) diventa τἶ in certi contesti poetici.
7. Aferesi (ἀφαίρεσις, “rimozione iniziale”)
È la perdita di un suono all’inizio di una parola.
Esempio: ἐξ- può perdere la ε davanti a parole che iniziano per consonante (es. ξαίρω invece di ἐξαίρω).
8. Crasi (κρᾶσις, “fusione”)
È la fusione di due vocali appartenenti a parole diverse in una sola vocale lunga o dittongo.
Esempio: ἐγὼ εἰμί può diventare ἐγὠμι.
9. Iato (διάστασις, “separazione”)
Si verifica quando due vocali che normalmente si contraggono rimangono invece separate.
Esempio: In poesia, a volte ποιέω si pronuncia con entrambe le vocali distinte per esigenze metriche.
10. Assimilazione (ἀφομοίωσις, “somiglianza”)
Una consonante cambia per somigliarsi a quella vicina.
Esempio: σύν-φέρω diventa συμ-φέρω per assimilazione di ν a μ.
11. Dissimilazione (ἀνομοίωσις, “diversificazione”)
Il contrario dell’assimilazione: due suoni simili diventano diversi per evitare ripetizioni.
Esempio: ῥοδόδενδρον (“albero di rose”) poteva trasformarsi in ῥοδόδενδρον con la seconda δ cambiata per evitare la ripetizione.
12. Prostesi (πρόθεσις, “aggiunta all’inizio”)
Aggiunta di una vocale o consonante all’inizio della parola.
Esempio: ἐρεῖ (“dirà”) ha la ἐ- prostetica.
13. Paragoge (παραγωγή, “aggiunta alla fine”)
Aggiunta di un suono alla fine della parola.
Esempio: In certi dialetti, εἰμί (“sono”) poteva diventare εἰμίς.

