Troppi dati in rete crea un problema cognitivo nelle persone

Le organizzazioni si ritrovano ogni giorno a navigare in un mare sconfinato di dati, attratte dalla promessa, sempre più reclamizzata, di efficienza, innovazione, competitività senza precedenti.
Tuttavia, in questa presunta era della semplificazione, dell’interconnessione, dell’ottimizzazione, ci scontriamo quotidianamente con un paradosso, che spesso preferiamo dissimulare: se da un lato è vero che mai come oggi la conoscenza è stata così facilmente a disposizione, dall’altro appare sempre più difficile trasformarne il potenziale in decisioni lucide, in visioni strategiche, in intelligenza azionabile. Accumuli di report, database, archivi, sistemi di knowledge management crescono a dismisura, in una rincorsa costante alla raccolta di nuovi dati, ma l’accessibilità cognitiva – quella che potremmo chiamare infodisponibilità – sembra sfuggirci, rendendo evidente la fragilità della promessa tecnologica.
Le informazioni si moltiplicano, si stratificano, si intersecano. Ma la loro crescita non si accompagna a una pari evoluzione nella nostra capacità di comprenderle, filtrarle, convertirle in conoscenza utile.
È il sintomo evidente di una condizione di saturazione cognitiva: l’ambiente informativo si espande a ritmi vertiginosi, mentre restano ferme – o con un processo di crescita troppo lento – le competenze critiche, selettive e collaborative delle persone e dei sistemi che dovrebbero governarlo. Non ci manca più l’accesso ai dati, oramai potenzialmente attivabile in mille modi diversi: ci manca la capacità di dar loro senso, di farli dialogare tra loro, di estrarne valore. E soprattutto ci mancano il coraggio, la lungimiranza e l’onestà intellettuale per riconoscere che non tutta l’informazione ha lo stesso peso, la stessa vitalità o la stessa urgenza. In questo cambio di scenario, oggi, la vera intelligenza organizzativa si dovrebbe misurare così: nella capacità di discernere, scegliere, e creare connessioni significative in mezzo al rumore.
Dispersione strategica e paradossi della conoscenza organizzativa
In questo scenario, in maniera più o meno consapevole si stanno ponendo i presupposti per alimentare un rischio silenzioso e subdolo: la dispersione strategica. Una deriva in cui la sovrabbondanza di segnali informativi genera rumore, anziché intelligenza, indebolendo progressivamente la capacità collettiva di produrre senso, di trovare orientamento, di definire progettualità. Ecco quindi che organizzazioni intere, pur investendo milioni nella digitalizzazione di processi e patrimoni documentali, si trovano ad annaspare in una sorta di magma informativo, incapaci di distinguere ciò che conta da ciò che distrae, ciò che guida da ciò che, involontariamente, rischia di paralizzare.
Non si tratta quindi più semplicemente di gestire “troppe informazioni”, ma abbiamo a che fare con un problema più radicale: la necessità, sempre più evidente, di configurare una nuova relazione tra conoscenza e organizzazione, tra dati e decisioni, tra conoscenza individuale e intelligenza collettiva. È la sfida, urgentissima, di progettare ambienti cognitivi – nelle organizzazioni, nelle comunità, nella società intera – che non siano solo depositi statici di memoria, ma veri ecosistemi di generazione, selezione e amplificazione dell’intelligenza.
Proprio in questo contesto, tra tensioni strategiche e paradossi cognitivi, entra in gioco un altro grande equivoco del nostro tempo, tanto temuto quanto celebrato: la relazione necessaria, imprescindibile, con l’intelligenza artificiale. Troppo spesso concepita come uno strumento di automazione cognitiva passiva – sostanzialmente, una macchina a cui “delegare” il compito di gestire la complessità – l’AI rischia di essere ridotta a una sorta di scorciatoia illusoria, a una finta panacea che permette di dissimulare, senza risolverla, l’anemia cognitiva delle organizzazioni. Tuttavia, chi la conosce davvero lo sa: se progettata, sviluppata e governata con la giusta visione, potrebbe diventare il più potente agente abilitante dell’intelligenza collettiva fino ad oggi implementato.
Non siamo, com’è evidente, solo di fronte a una questione tecnologica. Siamo di fronte a una questione strategica, culturale, epistemologica, politica: chi decide cosa è conoscenza valida? Chi orchestra la condivisione di idee e competenze in un’epoca in cui la conoscenza è sempre più destinata ad essere frammentata, distribuita, accelerata? Quale ruolo vogliamo assegnare alle macchine intelligenti nel nostro futuro? Quale ruolo vogliamo rivendicare, per i decisori umani, in un mondo di sovraccarico cognitivo?
La posta in gioco non è banale: riguarda la capacità delle organizzazioni – pubbliche, private, sociali – di evolvere o di implodere sotto il peso della loro stessa, fondamentale, talvolta ingovernabile abbondanza informativa. Riguarda la possibilità di costruire ecosistemi cognitivi capaci di liberare davvero il potenziale dell’intelligenza tacita, implicita, diffusa nei corpi sociali. Riguarda, infine, la nostra capacità di usare l’AI per progettare il futuro della conoscenza come bene comune, come spazio condiviso di creazione di valore.
In questo articolo esploreremo il paradosso dell’infodisponibilità, i rischi della dispersione strategica e le potenzialità, ancora largamente inespresse, dell’AI come motore di intelligenza collettiva. Un viaggio che ci porterà, tra suggestioni e provocazioni, dalle arti della memoria medievali alle sfide delle piattaforme cognitive contemporanee, dalle botteghe rinascimentali ai nuovi modelli di design partecipativo, per interrogare criticamente il nostro rapporto con l’informazione, con la conoscenza e con la stessa possibilità di immaginare, abilitare e creare futuro.
Il paradosso dell’abbondanza: tra sovraccarico informativo e dispersione strategica
Nel cuore sempre più frenetico delle organizzazioni digitalizzate, dunque, si fa strada un paradosso ormai difficile da ignorare: la proporzionalità inversa tra i dati a disposizione e la capacità reale di capitalizzarne il valore potenziale. Secondo le stime di IDC, nel 2025 il mondo dovrebbe arrivare a produrre 175 zettabyte di dati (oltre 5 milioni di Gigabyte al secondo), generando un flusso informativo incessante, strabordante, difficilmente arginabile o indirizzabile in maniera costruttiva. Il concetto di information overload, introdotto da Alvin Toffler negli anni ’70, appare oggi più attuale che mai. Tuttavia, come ha efficacemente osservato il teorico dei media Clay Shirky, nel suo speech al Web 2.0 Expo di New York del 2008, il vero problema non è l’abbondanza di dati, ma il crollo, o l’inadeguatezza, dei filtri a disposizione: “It’s not information overload. It’s filter failure.” In un contesto in cui ogni secondo vede produrre più dati di quanti se ne possano analizzare in una vita, la sfida esige un radicale cambio di paradigma, che permetta di privilegiare la rilevanza rispetto alla quantità, la connessione rispetto all’accumulo, la comprensione profonda rispetto alla mera disponibilità.
Questa incapacità di filtrare e attribuire significato alle informazioni porta a quella che abbiamo definito “dispersione strategica”: una condizione in cui l’attenzione, le risorse disponibili e le decisioni organizzative si disperdono in una miriade di dati non correlati, riducendo l’accuratezza interpretativa, l’efficacia strategica e l’efficienza operativa. Inoltre, l’assenza di una governance efficace dei dati, che spesso viene concepita semplicemente come rigidità organizzativa, può portare a silos informativi, in cui le informazioni sono isolate all’interno di specifici dipartimenti o sistemi, impedendo una visione olistica e integrata dell’organizzazione. Questo, inevitabilmente, frammenta la conoscenza, limita la collaborazione interfunzionale, ostacola l’innovazione, l’adattabilità e la competitività.
Per affrontare questi problemi, è dunque fondamentale sviluppare sistemi di gestione della conoscenza che non si limitino a raccogliere e archiviare dati, ma che facilitino l’accesso, la comprensione e l’attivazione del potenziale cognitivo – necessariamente relazionale – delle informazioni. Ciò implica da una parte l’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, per supportare la selezione e l’analisi dei dati, ma esige, dall’altra, la promozione di una cultura organizzativa orientata alla condivisione, all’evoluzione costante e all’apprendimento continuo.
In sintesi, l’era dell’informazione richiede un cambiamento di paradigma: da una focalizzazione sulla quantità di dati disponibili a un’enfasi – critica e consapevole – sulla qualità, l’accessibilità e l’utilizzabilità delle informazioni. Solo così le organizzazioni potranno trasformare l’abbondanza di dati in un reale vantaggio strategico.
L’illusione dell’informazione: verso il concetto di “infodisponibilità”
Come abbiamo visto, l’accumulo di informazioni non corrisponde alla crescita del capitale cognitivo. Questa apparente disponibilità tecnica si rivela, troppo spesso, una disponibilità vuota. Non tutta l’informazione archiviata è effettivamente assimilabile, utilizzabile, strategicamente attivabile, o semplicemente interrogabile in modo corretto. È a partire da questa dissonanza che parliamo quindi di infodisponibilità: la misura reale di quella porzione di informazione rilevante (in base a parametri ed esigenze variabili) che non solo esiste, ma è cognitivamente accessibile, comprensibile, realmente trasformabile in valore operativo.
L’eventuale crisi di infodisponibilità non dipende dalla maggiore o minore quantità di dati, ma dall’eccesso di dati non curati, non filtrati, non sufficientemente contestualizzati. Soprattutto, dipende dalla qualità dell’ecosistema cognitivo, dai suoi processi di trasferimento, dalle sue dinamiche di relazione, dalle sue metodologie di interpretazione ed evoluzione interattiva. L’infodisponibilità si assottiglia ogni volta che il sovraccarico informativo, per quanto percepito come patrimonio imprescindibile, supera la capacità selettiva degli individui e delle organizzazioni, trasformando l’abbondanza in rumore, l’accesso in paralisi.
Le cause sono profonde e stratificate. Herbert Simon, in uno speech alla John Hopkins University nel 1971, Designing Organizations for an Information-Rich World, osservava con una lucidità davvero lungimirante che “a wealth of information creates a poverty of attention”: la ricchezza informativa rischia, inevitabilmente, di creare povertà attentiva. Oggi, com’è evidente, quella previsione si è avverata, nelle organizzazioni e nell’intera società, su scala globale. Occorre inoltre notare come la crescita incontrollata dei sistemi informativi proceda spesso in assenza di un vero pensiero curatoriale: le informazioni si sedimentano come strati geologici, senza una logica di senso che ne faciliti l’emersione o la disponibilità strategica. Infine, la sottovalutazione della gestione della conoscenza come pratica culturale e relazionale – anziché puramente tecnica – ha amplificato rapidamente la distanza tra informazione disponibile e informazione usabile.
Il risultato è dunque un paradosso sistemico: più informazioni accumuliamo, meno sappiamo come usarle. Più piattaforme adottiamo, meno intelligenza collettiva riusciamo a generare. Non è, evidentemente, solo l’individuo a essere sopraffatto, ma l’intero organismo organizzativo, che progressivamente rischia di frammentarsi, di perdere coerenza ed efficacia, alimentando, in maniera più o meno implicita, un progressivo deficit di orientamento strategico.
Affrontare la sfida dell’infodisponibilità significa dunque avere il coraggio di andare oltre la mera automazione dei flussi informativi. Significa ripensare radicalmente le architetture cognitive, progettando ambienti in cui le informazioni siano curate, filtrate, rese effettivamente navigabili e attivabili. Significa riconoscere che l’informazione, senza processi di contestualizzazione e valorizzazione, non solo rischia di perde efficacia, ma può diventare un fattore di entropia organizzativa.
Modelli storici e archetipi cognitivi per il futuro
La crisi odierna dell’infodisponibilità non è tuttavia un fenomeno isolato nella storia umana. Da sempre,infatti, l’umanità si confronta con la sfida di organizzare, preservare e rendere accessibile il sapere. Già nel Medioevo, prima ancora dell’invenzione della stampa, i maestri delle arti della memoria — come ricordato magistralmente da Frances Yates nella sua opera The Art of Memory (1966) — svilupparono tecniche sofisticate per creare vere e proprie “memorie artificiali”: sistemi visivi e spaziali destinati a facilitare il richiamo di conoscenze complesse. Non si trattava soltanto di ricordare un numero maggiore di informazioni, ma di strutturare il pensiero attraverso spazi cognitivi organizzati, rispettosi della natura relazionale e dinamica della conoscenza, capaci di renderla accessibile, navigabile, operativa.
Un altro esempio, concettualmente utile alla riflessione odierna può essere individuato nelle botteghe, nelle accademie tecnico-artistiche e nei cantieri architettonici del Rinascimento italiano e fiammingo. Qui, l’interazione costante tra esperienza pratica, conoscenza teorica e generatività cognitiva era non solo evidente, ma necessaria, strutturale, sistematicamente integrata. I grandi cantieri, come quelli delle cattedrali o delle grandi macchine teatrali, erano ambienti ad alta densità epistemica, dove architetti, ingegneri, artigiani e filosofi collaboravano alla risoluzione di problemi complessi.
In contesti come questi, la conoscenza non era trasmessa in modo lineare, né rigidamente suddivisa in silos, ma co-generata attraverso la negoziazione continua tra teoria e prassi, tra innovazione e tradizione, tra individuo e collettività. La trasmissione del sapere avveniva per osmosi partecipativa, incorporata nei gesti, nei disegni, nelle discussioni, nelle correzioni reciproche. In questo senso, l’intelligenza collettiva era situata, pratica e generativa: produceva, dall’interazione, nuove soluzioni, nuovi strumenti, nuovi linguaggi, rendendo la conoscenza attivabile nel contesto, ma anche trasferibile al di fuori di esso.
Questi dispositivi storici non devono essere compresi semplicemente come suggestioni culturali, ma come modelli euristici che rivelano una costante antropologica: l’informazione, per trasformarsi in sapere operativo, ha bisogno di essere abitata, relazionata, praticata, condivisa. La sola accumulazione di dati non produce intelligenza; senza spazi intenzionali di progettazione cognitiva – ambienti, fisici o virtuali, che facilitino l’accesso, la connessione e la rielaborazione condivisa delle informazioni – il sapere si disperde. È in questa tensione tra struttura e relazione che si gioca, oggi, la vera sostenibilità della conoscenza.
Oggi come nel passato, siamo chiamati a capire come fare della conoscenza non solo una riserva, ma una forza generativa. E per riuscirci, in questo specifico contesto socio-tecnologico, dobbiamo interrogarci con urgenza su come vogliamo ripensare il design dei nostri ambienti informativi, su come vogliamo potenziare le architetture cognitive delle nostre organizzazioni, su come, soprattutto, vogliamo usare il vero valore abilitante dell’AI.
Ai come tessuto connettivo dell’intelligenza collettiva
In questo scenario di complessità crescente, in cui la competizione geo-economica si gioca anche sul terreno della competitività cognitiva, il ruolo dell’intelligenza artificiale non può essere confinato alla mera automazione dei processi o alla gestione passiva delle informazioni. Se interpretata con lungimiranza, l’AI dovrebbe invece essere concepita e utilizzata come un agente abilitante, un vero catalizzatore di intelligenza collettiva, capace di migliorare l’infodisponibilità e di convertirla in conoscenza dinamica e operativa.
Le applicazioni più avanzate, oramai, sono in grado di andare ben oltre l’automazione tradizionale. Sistemi come Pol.is, ad esempio, aiutano in maniera dinamica a mappare il consenso e il dissenso all’interno di grandi gruppi, facilitando decisioni più informate e partecipate. Piattaforme come Kumu.io permettono di visualizzare reti complesse di relazioni e informazioni, rendendo evidenti pattern nascosti e connessioni latenti. Tecnologie di knowledge graph aziendali, come quelle sviluppate da Diffbot, permettono di creare vere e proprie mappe semantiche navigabili della conoscenza distribuita.
Tuttavia, come abbiamo detto ripetutamente, la vera sfida non è solamente tecnologica, ma progettuale, culturale, strategica. È necessario ripensare radicalmente l’approccio stesso al concetto di “AI-first company”. Non si tratta semplicemente di adottare strumenti più avanzati o di permettere un’accelerazione dei flussi informativi esistenti, ma di reimmaginare l’intera architettura cognitiva dell’organizzazione. In questa prospettiva si inserisce l’esperienza di DiDo, un sistema di generative AI progettato dall’italiana Symboolic, non per sostituire il pensiero umano, distribuito nei sistemi complessi delle organizzazioni, ma per orchestrarlo, permettendo di liberare l’intelligenza tacita e diffusa che troppo spesso rimane intrappolata nei silos aziendali, o nella viscosità dei processi gestionali.
Come sottolineato nella riflessione sull’AI-first organizzativa, il vero salto di paradigma non risiede nella capacità di automazione di ciò che già esiste, ma nella creazione di nuove modalità di attivazione del pensiero collettivo: un modello in cui l’AI agisca come un tessuto connettivo intelligente, capace di collegare persone, competenze, intuizioni e dati in tempo reale. DiDo sembra incarnare questa visione non come un oracolo onnisciente, ma come un orchestratore epistemico: un agente che facilita l’emergere di risposte nuove, attraverso il dialogo dinamico tra conoscenze diverse.
Questo approccio, certamente più maieutico che prescrittivo, apre la strada a una forma di collaborazione aumentata senza precedenti, in cui l’AI non impoverisce il pensiero umano, non lo sostituisce, ma lo amplifica, liberandolo dai vincoli della frammentazione e della dispersione. È una prospettiva radicale, che vede l’innovazione resa possibile dall’introduzione dell’intelligenza artificiale non come un fine autoreferenziale, ma come un’infrastruttura abilitante per l’evoluzione della conoscenza organizzativa.
In questo modo, l’AI non si limita a rendere più veloci i processi decisionali, ma li rende più profondi, più consapevoli, più inclusivi. Non sostituisce la capacità umana di giudizio, intuizione e creatività, ma la esalta, costruendo un ambiente in cui l’intelligenza distribuita possa finalmente fluire e generare valore collettivo. È proprio alla luce di questa visione che si gioca, forse, la sfida più alta e più appassionante del nostro tempo.
Verso un nuovo umanesimo cognitivo e organizzativo
Siamo arrivati a un bivio storico. Di fronte alla pervasiva trasformazione digitale, che caratterizza la nostra quotidianità in innumerevoli aspetti, ogni organizzazione è chiamata a scegliere: continuare a subire l’inondazione di dati con un atteggiamento passivo, sperando di riuscire a perfezionare i processi per garantire una maggiore infodisponibilità, oppure assumersi la responsabilità di elaborare una nuova, consapevole, architettura dinamica della propria intelligenza collettiva.
La quantità di informazioni a disposizione, come abbiamo visto, non rappresenta, di per sé, un vantaggio. Non acquisirà maggiore capacità di indirizzare il futuro chi saprà accumulare dati, ma chi saprà organizzare la conoscenza, coltivando il pensiero critico, liberando le connessioni nascoste tra persone, idee, esperienze, superando la fisiologica dispersione informativa all’interno delle organizzazioni.
Proprio alla luce di questo contesto e delle sfide che implica, essere un’organizzazione AI-first, in futuro, significherà non solo investire in tecnologia, ma ripensare radicalmente, con l’AI, il proprio modello cognitivo. Significherà costruire sistemi che sappiano navigare l’incertezza, valorizzare la conoscenza tacita, capitalizzare l’esperienza accumulata, coltivare l’intelligenza latente. Questa trasformazione, dunque, non riguarderà solo l’efficienza dei processi o il potenziamento operativo. Riguarderà, in maniera molto più ampia e rilevante, la capacità delle organizzazioni di evolvere come sistemi intelligenti, capaci di apprendere, di adattarsi e di generare valore in modo distribuito e sostenibile.
Questa visione implica una ridefinizione profonda del modo in cui progettiamo il lavoro, prendiamo decisioni, valorizziamo le competenze e costruiamo cultura, dentro e fuori le organizzazioni. Non si tratta più, solamente, di chiedersi se l’intelligenza artificiale possa velocizzare o automatizzare ciò che già facciamo: si tratta di chiederci chi possiamo diventare, se sapremo usarla, finalmente, per pensare insieme.

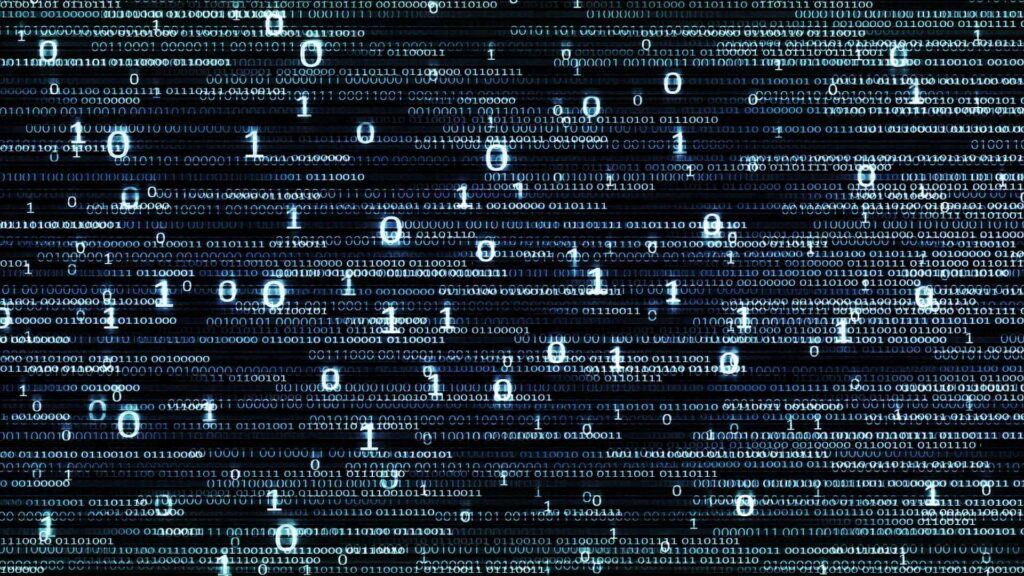

Commenti