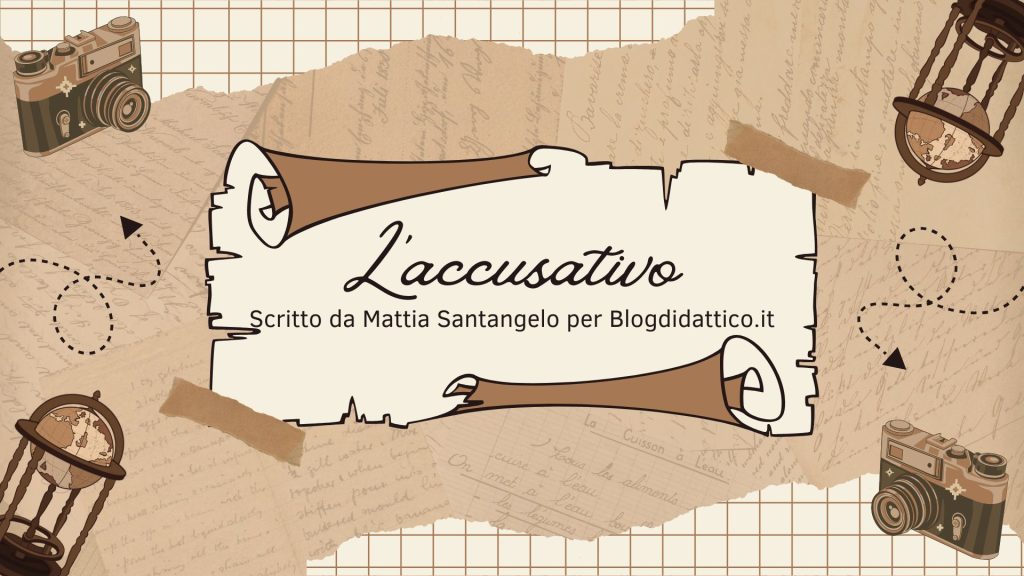Il dativo
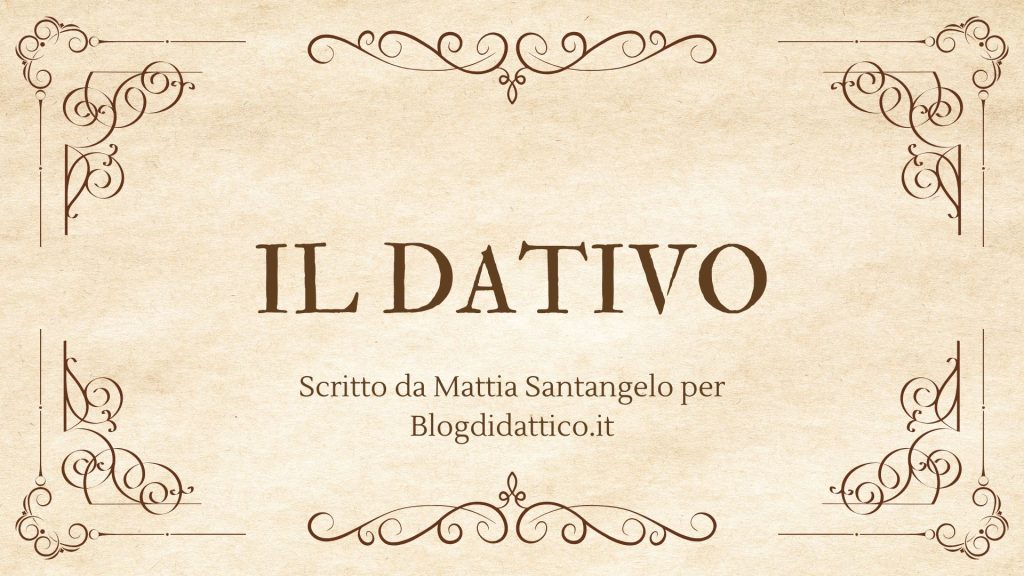
Tra i casi della grammatica greca, oltre a quelli precedentemente trattati nel nostro blog, va configurandosi anche il dativo, caso obliquo proprio come il genitivo, che presenta una notevole varietà di funzioni sintattiche e semantiche, tanto da costituire uno degli strumenti più duttili della lingua.
Il suo impiego spazia da contesti in cui rappresenta l’oggetto indiretto, fino a usi più specifici e stilistici, legati al significato del verbo, dell’aggettivo o dell’avverbio con cui si accompagna.
All’interno di quest’articolo analizzeremo in dettaglio il suo valore e le sue sfumature, avvalendoci delle preziose informazioni ricavate dal libro Greco Di Bijoy M. Trentin. Ti invitiamo anche a non perderti il prossimo articolo che, come da prassi, approfondirà il concetto dell’accusativo.
1. Dativo dell’oggetto secondo e oggetto indiretto
Il dativo è spesso impiegato per esprimere il cosiddetto oggetto secondo, ovvero il termine verso cui si orienta l’azione dopo aver coinvolto l’oggetto diretto. In assenza di quest’ultimo, il dativo assume la funzione dell’oggetto indiretto. Questa costruzione è frequente con espressioni che richiedono un destinatario dell’azione:
- κελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί – «Ordino di rivelarmi tutto» (Sofocle, Edipo re 226)
- τοι ἀμύνουσι θεοί – «Gli dèi ti proteggono» (Omero, Iliade XXI 215)
2. Dativo di interesse
Questa sfumatura indica il soggetto che trae beneficio o danno dall’azione, oppure che è psicologicamente coinvolto. Si articola in:
1. Dativo di vantaggio o svantaggio (o dativus commodi et incommodi)
Definizione: Indica per chi l’azione è compiuta o da chi è subita in senso pratico, se con vantaggio o svantaggio.
Domanda guida: Per chi? A favore di chi? A danno di chi?
Esempio:
- ὠφελητέα σοι ἡ πόλις ἐστί – “Tu devi soccorrere la (tua) città.”
→ sοι: a vantaggio tuo (la città è tua, il vantaggio è tuo).
Il verbo è impersonale, ma il dativo coinvolge il soggetto nella responsabilità e nel beneficio.
2. Dativo etico
Definizione: È una particolare variante del dativo di vantaggio/svantaggio. Non indica un vero vantaggio, ma un coinvolgimento affettivo o soggettivo, spesso enfatico o patetico, simile a un inciso personale (“per favore”, “ti prego”, “a me”).
Domanda guida: Chi è coinvolto emotivamente?
Esempio:
- μὴ θορυβήσητε μοι – “Non fate chiasso per me”
→ μοι: dativo etico → “Vi prego, non fatemi questo!”, “non mi interrompete!”
È molto usato nella lingua parlata o nel dialogo teatrale per creare coinvolgimento e patetismo.
3. Dativo del possessore
Definizione: Esprime il possessore di qualcosa in frasi con verbi essere (εἰμί) o simili. È un costrutto molto greco: anziché dire “qualcuno ha qualcosa”, si dice “qualcosa è a qualcuno”.
Domanda guida: A chi appartiene?
Esempio:
- οὗτις ἐμοί γ’ ὄνομα – “Il mio nome è Nessuno”
→ ἐμοί: a me → dativo del possessore.
Tipico nella frase ἐστι(ν) μοι + nome = “io ho…”
4. Dativo di relazione o limitazione
Definizione: Indica in quale aspetto o rispetto un’affermazione è vera. Risponde alla domanda “rispetto a cosa?”, “in quale ambito?”.
Domanda guida: In che senso? In quale aspetto?
Esempio:
- ἀναμνησθήτω… πεινῶντι – “Si ricordi quanto è dolce per chi ha fame mangiare”
→ πεινῶντι: dativo di relazione → è dolce in quanto ha fame, per lui.
Questo dativo è frequente con verbi impersonali, aggettivi, participi.
5. Dativo d’agente (in costruzioni passive)
Definizione: In alcune costruzioni passive impersonali o verbali (soprattutto con verbi gerundivi o impersonali), l’agente dell’azione non è introdotto da ὑπό (come nel greco classico normale), ma è espresso in dativo.
Domanda guida: Da parte di chi viene compiuta l’azione?
Esempio:
- ἡ πόλις ὠφελητέα σοι ἐστίν – “La città deve essere soccorsa da te”
→ σοι: dativo d’agente (equivalente a “ὑπό σοῦ”).
Tipico nei gerundivi + εἰμί → qualcosa deve essere fatto da qualcuno.
3. Dativo strumentale
Indica il mezzo attraverso il quale si realizza l’azione. Spesso questo valore si manifesta in forma etimologica, in quanto il dativo e il verbo condividono la radice:
- ἐπείρατο καθείρειν λούτροις – «Cercava di sbiancarlo con lavaggi» (Esopo)
- βάλλοιμι βέλεσιν – «Colpirei con giavellotti» (Odissea XVI)
Rientrano in questa categoria anche:
1. Dativo di materia (o di contenuto)
Definizione: Indica la sostanza o il contenuto di cui qualcosa è fatto o riempito. È simile al genitivo di materia ma più raro e più “pragmatico”, spesso legato a contesti concreti (come pienezza, saturazione).
Domanda guida: Di cosa è pieno? Di cosa è colmo?
Esempi:
- κρατὴρ οἴνῳ – “una coppa piena di vino”
→ οἴνῳ: dativo di materia (contenuto della coppa) - γέμει φωνῇ – “è pieno di rumore / voce”
→ φωνῇ: dativo di contenuto
Talvolta si può trovare doppio dativo: uno indica la cosa e uno la materia → es. “riempire un vaso (vaso = dativo) di vino (vino = dativo)”.
2. Dativo di prezzo
Definizione: Indica il prezzo a cui si compra o vende qualcosa. Può riguardare sia valori materiali (denaro, beni) sia valori morali o simbolici (onore, vergogna, libertà).
Domanda guida: A che prezzo? Per quanto?
Esempi:
- ὠνήσατο πολλοῖς – “Lo comprò per molto denaro”
→ πολλοῖς: dativo di prezzo - ἐπριάμην αἰσχύνῃ – “Lo pagai con la vergogna”
→ αἰσχύνῃ: dativo di prezzo simbolico → “al prezzo della vergogna” - ὤλετο τιμῇ – “Si rovinò per (a causa di) l’onore”
→ dativo di prezzo simbolico
Il dativo può anche riferirsi a valori morali, e allora si avvicina al dativo causale o strumentale, ma con l’idea di “pagamento” o “valore di scambio”.
3. Dativo di pena o castigo
Definizione: Esprime la pena subita da qualcuno o la misura della punizione ricevuta.
Domanda guida: Con quale pena? Di quanto è la condanna?
Esempi:
- ζημιωθῇ δέκα ταλάντοις – “Fu condannato a dieci talenti”
→ δέκα ταλάντοις: dativo di pena - θανάτῳ ζημιωθῇ – “Sia punito con la morte”
→ θανάτῳ: dativo di pena (la morte è la punizione) - κολάζεσθαι μεγάλαις ζημίαις – “Essere punito con gravi pene”
→ μεγάλαις ζημίαις: dativo della pena subita
È spesso legato a verbi come ζημιόομαι (essere punito), κολάζομαι (essere castigato) ecc.
4. Dativo comitativo o sociativo
Utilizzato per indicare l’accompagnamento di una persona o di una cosa, in un rapporto che può essere cooperativo o conflittuale:
- νέας… τοῖς ἀνδράσιν εἷλον – «Catturarono quattro navi insieme agli uomini» (Erodoto)
5. Dativo di identità o somiglianza
Espressioni che sottolineano l’uguaglianza o similitudine tra due elementi ricorrono al dativo:
- τῶν αὐτῶν τυγχάνειν τῷ βελτίστῳ – «Gode degli stessi diritti del migliore» (Lisia)
6. Dativo di causa
Quando il dativo accompagna verbi che esprimono stati d’animo o aggettivi affini, esso può esprimere la causa del sentimento:
- ἐχάρην ὕμνοις – «Gioisco per gli inni» (Aristofane)
7. Dativo prosecutivo
Raramente attestato, esprime l’estensione spaziale o temporale del movimento o dell’azione. È visibile in espressioni come:
- τῷ χρόνῳ – «col passare del tempo»
- διὰ ποίας ὁδοῦ; – «per quale via?»
8. Dativo di misura o valutazione
Serve a indicare la quantità o l’entità con cui si effettua una comparazione:
- ἔλαττον πρότερον – «Poco prima» (Platone)
9. Dativo di modo o maniera
Deriva da un uso figurato del dativo comitativo ed esprime il modo in cui avviene qualcosa. Spesso è accompagnato da preposizioni:
- βίᾳ – «con violenza»
- δημοσίᾳ – «pubblicamente»
10. Dativo illativo o locativo
Indica lo stato in luogo o il tempo determinato. Può trovarsi sia da solo sia con preposizioni come ἐν, ἐπὶ, ὑπό:
- ἐν νυκτί – «di notte» (Eschilo)