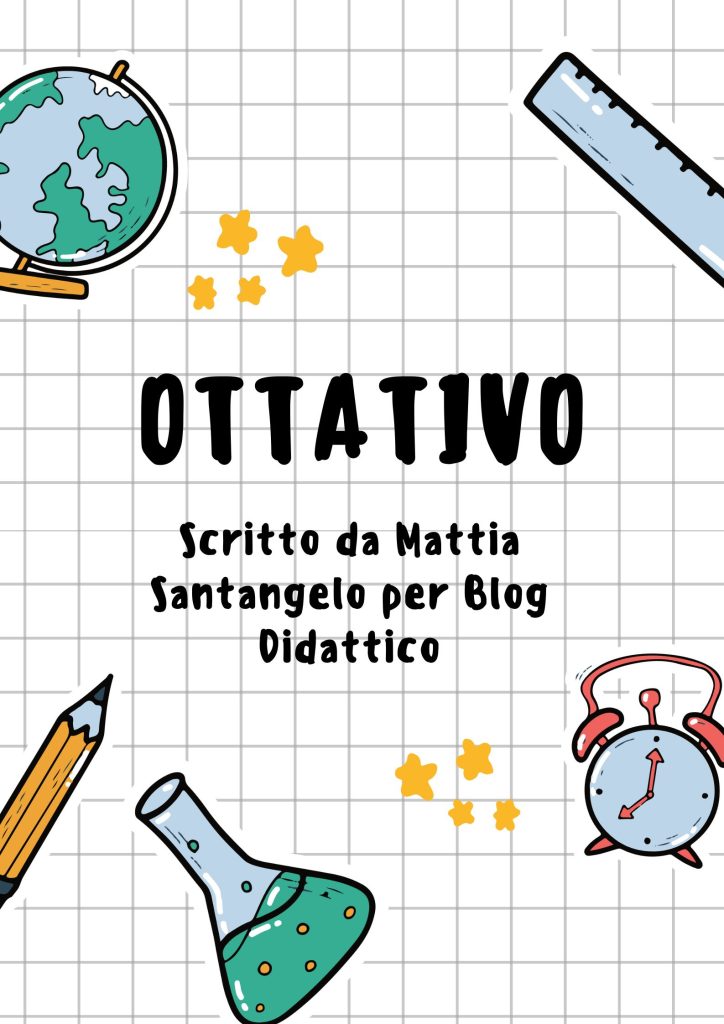L’aumento temporale

Lo studio delverbo greco antico rivela un sistema complesso e ricco di sfumature, in cui ogni elemento morfologico concorre a esprimere non soltanto il tempo dell’azione, ma anche il suo aspetto e la sua modalità. Tra questi elementi spicca l’aumento, un prefisso che appare nei tempi storici dell’indicativo e che, a prima vista, potrebbe sembrare un semplice segno grafico. In realtà, esso racchiude una lunga evoluzione storica e linguistica: nato come particella avverbiale con valore temporale, è divenuto nel greco classico un tratto distintivo del passato verbale.
La sua presenza è fondamentale per riconoscere e distinguere le forme verbali nei testi, e permette di cogliere immediatamente la collocazione temporale dell’azione. L’aumento non si limita, però, a un unico schema: la lingua greca ha elaborato diverse modalità di applicarlo, a seconda che il verbo inizi con consonante o vocale, con un sistema di regole preciso ma non privo di eccezioni.
Comprendere il funzionamento dell’aumento significa, quindi, entrare nel cuore della morfologia verbale greca, dove il passato non è soltanto un tempo cronologico, ma una categoria linguistica segnata da trasformazioni fonetiche e da un’elegante coerenza interna.
Definizione
Nel greco antico l’aumento è un prefisso che si aggiunge al tema del verbo nei tempi storici dell’indicativo (imperfetto, aoristo, piuccheperfetto).
Non si tratta dunque di una desinenza personale, ma di un elemento che funge da marcatore temporale, indicando che l’azione è avvenuta nel passato.
Questa caratteristica differenzia i tempi storici dagli altri (presente, futuro, perfetto), i quali non presentano aumento.
Origini storiche
L’aumento ha un’origine indoeuropea, ma la sua forma si è sviluppata soprattutto nel greco. In origine non era obbligatorio: veniva usato come particella avverbiale con valore di “già, allora”.
Con il tempo, nel greco classico, l’aumento è diventato obbligatorio nell’indicativo dei tempi storici, mentre non compare mai nel congiuntivo, ottativo, infinito e participio.
Tipi di aumento
| Somma | Risultato | Verbo originale | Verbo con l’aumento |
|---|---|---|---|
| ἐ- + α | η | ἄγω “condurre” | ἠγ- |
| ἐ- + αι o ἐ- + ἐ- ᾳ | ῃ | αἰσχύνω “screditare” | ᾐσχυν- |
| ἐ- + αυ | ηυ | αυξάνω “accrescere” | ηὐξαν- |
| ἐ- + ε | η o ει | ἐρίζω “litigare” ἔχω “avere” |
ἠριζ- εἰχ- |
| ἐ- + ει | ῃ ο ει | εἰκάζω “supporre” | ᾐκαζ- ο εἰκαζ- |
| ἐ- + ευ | ηυ ο ευ | εὑρίσκω “trovare” | ηὑρισκ- o εὑρισκ- |
| ἐ- + ο | ω | ὀρύσσω “scavare” | ὠρυσσ- |
| ἐ- + οι | ῳ | οἰμώζω “lamentarsi” | ᾠμωζ- |
| ἐ- ου | ου | οὐτάζω “ferire” | οὐταζ- |
| ἐ- ι | ι | ἰσχύω “essere forte” | ἰσχυ- |
| ἐ- υ | υ | ὑβρίζω “essere insolente” | ὑβριζ- |
Considerazioni
Come riporta il libro Il nuovo greco di Campanini:
- La fusione dell’aumento ἐ- con la vocale o il dittongo iniziale del tema produce esiti parzialmente diversi da quelli previsti dalle regole della contrazione, che sembra costruire un fenomeno più recente.
- Alcuni verbi inizianti per ε presentano l’allungamento in ει anziché in η. Tale fenomeno dipende dal fatto che questi verbi iniziavano originariamente per σ, Ϝ o σϜ, consonanti che in seguito all’aggiunta dell’aumento si sono venute a trovare in posizione intervocalica e sono cadute, provocando così la regolare contrazione tra l’ε dell’aumento e quella iniziale del nuovo tema. I verbi affetti da tale anomalia sono i seguenti:
- ἐαω (permettere) → σεϜα- → ἐ-σεϜα- → εἰα-;
- ἐθιζω (abituare) → σϜεθιζ- → ἐ-σϜεθιζ- → εἰθιζ-;
- ἑλίσσω (arrotolare) → Ϝελισσ- → ἐ-Ϝελισσ- → εἱλισσ-;
- ἕλκω (tirare) → σελκ- → ἐ-σελκ- → εἱλκ-;
- ἕπομαι (seguire)→ σεπ- → ἐ-σεπ- →εἱπ-;
- ἐργάζομαι (lavorare) → Ϝεργαζ → ἐ-Ϝεργαζ → εἰργαζ-;
- ἕρπω (strisciare) → σερπ- → ἐ-σερπ- → εἱπρ-;
- ἑστιάω (offrire un banchetto) → Ϝεστια- → ἐ-Ϝεστια- → εἱστια-;
- ἔχω (avere) → σεχ- → ἐ-σεχ- → εἰχ.
- I verbi inizianti per ει ed ευ, dal IV secolo a.C., non subirono alcuna modificazione a causa dell’aumento. Talvolta l’aumento temporale viene omesso anche con i dittonghi iniziali αυ ed οι.
- Le vocali lunghe iniziali rimangono immutate nei seguenti verbi:
- ἥκω (giungere) → tema + aumento ἡκ-;
- ὠφελέω (essere utile) → tema + aumento ὠφελε-.
- I verbi ὠθέω (spingere) e ὠνέομαι (comprare), originariamente inizianti per digamma, mantengono l’aumento ἐ- separato dalla vocale iniziale.
- Il verbo ὁράω (vedere) presenta un apparente doppio aumento, sillabico, trattato già nel precedente articolo che ti invito calorosamente a leggere qualora tu non l’avessi ancora fatto, e temporale: ἑωρα-. In realtà, questa forma si spiega a partire dall’etimologia del verbo, che originariamente cominciava per digamma. Postulando un aumento in ἠ-, analogo a quello di βούλομαι, δύναμαι, e μέλλω, si ottiene la forma ἠϜορα- e poi, per caduta del digamma e metatesi quantitativa, ἐωρα-. Analogamente si spiega l’apparente doppio aumento di (ἀν)οίγω (aprire): (ἀν)ηϜοιγ- → (ἀν)εϜῳγ- → (ἀν)εῳγ-.