Dalla mente al cuore: perché leggere a scuola trasforma studenti e insegnanti
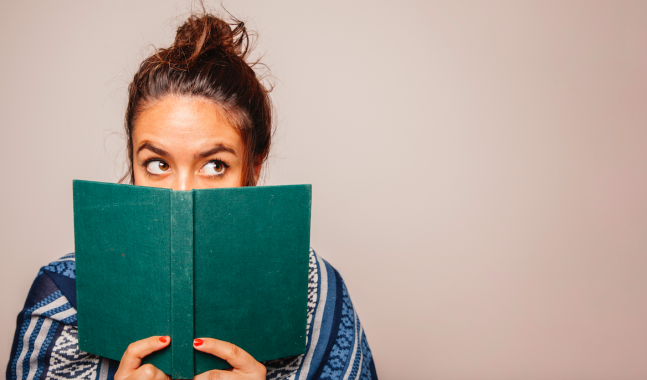
“Noi siamo ciò che abbiamo letto”: questa frase, tanto immediata quanto profonda, racchiude una verità universale sul ruolo della lettura nella formazione dell’individuo. La lettura non è solo un’attività intellettuale, ma un processo trasformativo che plasma il pensiero, l’identità e la visione del mondo. Quando leggiamo, il nostro cervello avvia un processo complesso: prima riconosce e decodifica i simboli, poi li confronta con oggetti mentali già consolidati per interpretarne il significato. Questa prima lettura è guidata da schemi cognitivi preesistenti che il cervello utilizza per organizzare le informazioni. Tuttavia, il processo non si ferma qui: la lettura stimola la creazione di nuovi schemi e connessioni sinaptiche, un fenomeno che neuroscienze e metacognizione evidenziano come cruciale per l’apprendimento. Riflettendo attivamente sul testo, monitoriamo la coerenza e adattiamo la nostra comprensione, sviluppando una consapevolezza maggiore del nostro stesso pensiero. Approfondendo i risvolti pedagogici, neuroscientifici e psicologici di

