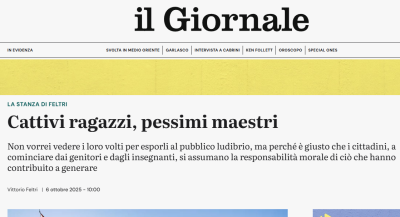I giovani e la responsabilità educativa: facile accusare la scuola, difficile capire la realtà. Quali e dove sono i cosiddetti cattivi maestri?
Sul quotidiano Il Giornale il direttore editoriale Vittorio Feltri è intervenuto sul caso degli studenti minorenni che hanno immaginato “la fine di Mussolini” per la premier e i vicepremier governativi in carica e hanno divulgato con un distico rimato su un cartello questa tanto lugubre quanto sciocca fantasia. Sebbene la legislazione vigente e la relativa giurisprudenza proibiscano la pubblicazione di immagini dei minori se non autorizzata o in casi speciali, il giornalista saggista, opinionista, politico si è rammaricato per non aver potuto vederle esposte, perché l’esibizione delle sembianze di tali “perfetti imbecilli” e “burattini” avrebbe potuto concorrere a evidenziare la corresponsabilità di genitori e insegnanti nella genesi di quell’aberrazione minorile. Secondo lui, responsabile dell’accaduto sarebbe soprattutto la scuola, ove “cattivi maestri” si dedicherebbero a inculcare odio negli alunni.
La visuale del giornalista saggista, opinionista, politico si palesa, a dir poco, alquanto limitata. Non vi si tiene conto, se non in minima parte, del contesto globale in cui le nuove generazioni si trovano a dover crescere moralmente. Scriveva il pedagogista Giuseppe Lisciani a proposito del “processo agli studenti” iniziato dopo la rivolta giovanile del 1968:
“Io credo che non sia possibile contestare la scuola senza, contemporaneamente, tuffarsi nel vivo della politica: quanto più violenta e calzante è l’accusa alla scuola, tanto più violenta e calzante è l’accusa alla politica che dirige le cose sociali”.
Il contesto politico in cui gli alunni sono chiamati a maturare una loro responsabilità è caratterizzato in ambito internazionale dalla violenza, dalla crudeltà, dalla ferocia scatenate dalla bramosia di conquiste territoriali.
Pur vivendo in un paese democratico ed esente dagli efferati massacri di guerre dissennate, essi sono esposti ai pessimi esempi di atteggiamenti e linguaggi a livello politico non di rado, per non dire sovente, privi di garbo, noncuranti del rispetto dell’avversario, indecorosi.
Si può sostenere con prove documentate che il nostro corpo docente entri in concorrenza con siffatti modi di essere e di fare, per conquistarsi la palma della scostumatezza, e che la presenza di eventuali “cattivi maestri” sia tollerata dai membri della comunità scolastica e dalle figure dirigenziali? A proposito dei ragazzi, sebbene i loro riprovevoli modi di essere e di fare, quando si manifestino, vadano certamente stigmatizzati, è da considerare produttivo sfogarsi con l’insulto e il disprezzo estesi anche alla scuola?
La questione giovanile è straordinariamente complessa e richiede di essere affrontata contrapponendo al manifestarsi dell’irresponsabilità una rinnovata responsabilità intellettuale, da manifestare anche nei confronti della scuola. Invece di esprimersi sbrigativamente con improperi, va studiata una vastissima letteratura multidisciplinare atta a corroborare ogni intento pedagogico e ciò con l’apporto delle scienze umane, in particolar modo della psicologia e della sociologia.
L’augurio di fare “la fine di Mussolini” è un modo di dire diffuso da tempo presso certi strati della popolazione. Nel rivolgerlo a esponenti politici ritenuti nostalgici del fascismo, i ragazzi dimostrano non tanto cattiveria di scalmanati quanto superficialità di orecchianti, cioè “di chi ha una conoscenza solo superficiale di un argomento, di una materia, di una disciplina, e ne parla o tratta dilettantescamente, senza averne una preparazione specifica o ripetendo ciò che ha sentito dire da altri.” Se un ragazzo è orecchiante, ne è responsabile la società intera, all’interno della quale la scuola è tenuta ad adoperarsi e si adopera per fargli approfondire le tematiche in cui le sue conoscenze si rivelino carenti.
Interrogando sull’argomento l’I.A. ho ottenuto risposte che ritengo sensate.
B.S. Accusare i “cattivi maestri” per le intemperanze giovanili non è un modo per screditare la scuola, come se essa fosse la prima responsabile del fenomeno?
I.A. È una domanda che tocca un nodo delicato del dibattito educativo. Accusare i “cattivi maestri” per le intemperanze giovanili può sembrare, a prima vista, un modo per attribuire alla scuola una responsabilità eccessiva, quasi totalizzante, nel comportamento dei giovani. Ma la questione è più complessa.
La scuola come ambiente formativo, non unico responsabile. La scuola ha certamente un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani, ma non è l’unico attore in gioco. Famiglia, società, media, ambiente socioeconomico: tutti concorrono a plasmare valori, atteggiamenti e comportamenti. Attribuire alla scuola — o ai suoi insegnanti — la responsabilità primaria delle intemperanze giovanili rischia di semplificare un fenomeno multifattoriale.
Il concetto di “cattivo maestro”. Il termine “cattivo maestro” è spesso usato in modo polemico o ideologico. Può indicare un insegnante che trasmette valori discutibili, che non sa gestire la classe, o che fallisce nel creare un rapporto educativo. Ma può anche essere una figura simbolica, usata per criticare un certo tipo di cultura o pensiero. In entrambi i casi, il rischio è quello di trasformare la critica in un attacco generalizzato alla scuola.
Responsabilità condivisa. Più che screditare la scuola, è utile interrogarsi su come essa possa migliorare il proprio ruolo educativo, in sinergia con le altre agenzie formative. La responsabilità delle intemperanze giovanili va distribuita, non scaricata su un solo fronte. E la critica ai “cattivi maestri” dovrebbe essere costruttiva, mirata a migliorare la qualità dell’insegnamento, non a delegittimare l’istituzione scolastica.
B.S. Alcuni ragazzi hanno augurato a nostri esponenti governativi di fare la fine di Mussolini. Sono stati i “cattivi maestri” a influenzarli a scuola o è l’intera società a partire dalla politica a farli deviare dalla correttezza?
I.A. L’episodio dello striscione contro il governo italiano è stato legato a una manifestazione politica, non a un’influenza scolastica diretta. Le cause di certi comportamenti giovanili sono complesse e coinvolgono scuola, famiglia, politica e società.
Lo striscione con la frase “Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini” è stato esposto a Bisceglie durante una manifestazione di solidarietà alla popolazione palestinese e agli attivisti della Global Sumud Flotilla. La frase ha suscitato forti polemiche, con esponenti politici come Tonia Spina (Fratelli d’Italia) che hanno condannato il gesto come un messaggio di odio e violenza, chiedendo al sindaco di prendere le distanze (ANSA).
Questo episodio non sembra legato direttamente alla scuola o ai cosiddetti “cattivi maestri”, ma piuttosto a un contesto politico e sociale più ampio. Ecco alcune riflessioni:
Influenze possibili sulla formazione dei giovani
Scuola e insegnanti: alcuni critici parlano di “cattivi maestri” quando ritengono che certi insegnanti trasmettano ideologie radicali o politicizzate. Tuttavia, non ci sono prove che colleghino direttamente questo episodio a un ambiente scolastico.
Famiglia e ambiente sociale: le opinioni dei giovani sono spesso influenzate dal contesto familiare, dai media e dai gruppi sociali. In ambienti polarizzati, è più facile che si sviluppino atteggiamenti estremi.
Politica e comunicazione pubblica: il linguaggio politico aggressivo, la polarizzazione e la demonizzazione dell’avversario possono legittimare espressioni violente anche tra i più giovani. Quando il dibattito pubblico si radicalizza, anche chi lo osserva tende a estremizzarsi.
Social media e attivismo: le piattaforme digitali amplificano messaggi forti e talvolta provocatori. I giovani, più esposti a questi canali, possono assorbire e replicare linguaggi estremi.
Libertà di espressione vs incitamento all’odio
È importante distinguere tra critica politica legittima e incitamento alla violenza. Lo striscione in questione richiama un episodio storico tragico — la morte di Mussolini — e può essere interpretato come una minaccia, non solo come una provocazione. In democrazia, la libertà di espressione è fondamentale, ma ha dei limiti quando sfocia nell’odio.
Conclusione
Non si può attribuire la responsabilità a un solo fattore. La scuola può avere un ruolo, ma è l’intera società — dalla politica ai media — a influenzare il modo in cui i giovani si esprimono. Educare al rispetto, al confronto civile e alla memoria storica è un compito condiviso.
Fondate su ricognizioni di materiale attinente alla questione reperito in rete, le risposte dell’I.A. avallano il convincimento che sia troppo sbrigativo inveire contro ragazzi ritenuti “burattini” di “cattivi maestri”. Di fronte a soggetti in una fase particolarmente delicata di formazione quale è quella dei minori, si rende necessario non etichettarli in partenza come “perfetti imbecilli”, ma contribuire all’attivazione di ogni risorsa educativa per recuperare le potenzialità positive in loro latenti. Scriveva uno psicologo della statura di Alfred Adler a proposito della tendenza a giudicare gli adolescenti in base a singole manifestazioni dei loro caratteri: “La cosa importante che bisogna tenere sempre presente è che una singola prestazione comportamentale non ha nessun significato se viene isolata dal contesto della personalità globalmente considerata e che saremo in grado di comprenderla solo studiandola in rapporto col resto dell’essere umano.”
E un sociologo della statura di Pierre Bourdieu si esprimeva in questi termini a proposito dei difficili rapporti degli adolescenti con la politica:“Essi non si riconoscono in un linguaggio politico che non parla di loro, che non parla a loro, e che non dà loro il senso di poter parlare. Prima di volere che partecipino, bisognerebbe restituire loro il senso della parola, la possibilità di sentirsi ascoltati.”