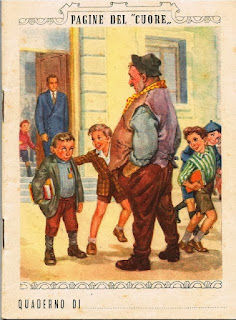E. Fiorentino, Sull’arco dell’aurora
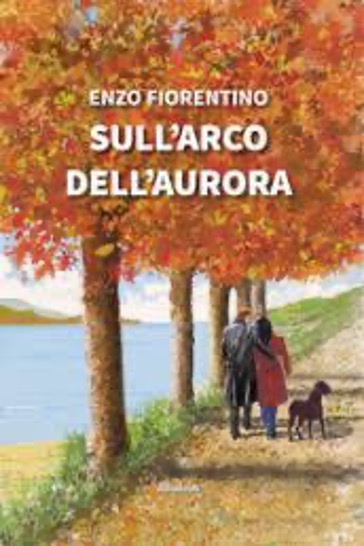
SULL’ARCO DELL’AURORA: APRIRSI PER UNIRE/UNIRSI NELLA NARRATIVA DI ENZO FIORENTINO
di CARLO DE NITTI
A due anni di distanza dalla sua prima fatica letteraria, Una breve stagione d’amore, Enzo Fiorentino ci conduce per mano, attraverso questo suo nuovo romanzo, Sull’arco dell’aurora, pubblicato sempre per i tipi della casa editrice romana Albatros: un romanzo avvincente, da leggere tutto d’un fiato, com’è occorso a chi sta scrivendo queste righe. Ancora una volta, per fortuna di noi lettori – verosimilmente in tanti – Enzo Fiorentino dismette, ma non del tutto, le vesti del saggista, del sociologo, del francesista, del sindacalista e del dirigente scolastico, per vestire quelle del narratore, dimensione in cui si trasfigurano tutte le altre della sua poliedrica personalità teste evocate.
Il romanzo si snoda attraverso sei capitoli: “L’amarezza”, “Il trasferimento”, “Amore e ricordi”, “Ripensamento e riesame”, “La felicità minacciata”, “L’alba s’indora”. Molto evocativo appare a chi scrive il titolo scelto, Sull’arco dell’aurora: un arco non può che indicare un’apertura, un ‘ponte’ per unire due persone, due luoghi, due mondi, due epoche, creando condivisione, come caratteristico di una città di frontiera come, da sempre, quella in cui il romanzo è ambientato, Trieste.
È in quella città che viene inviato, in qualità di direttore regionale di un imprecisato ministero, per una sorta di mobbing, Fulvio, ottimo dirigente ministeriale, di origine meridionale, le cui idee non sono sempre in linea con il ministro pro tempore: “Cerco un buon direttore in grado di svecchiare l’ufficio regionale del Friuli, volte a favorire ed assecondare il processo di trasformazione già in atto […] Mi piacerebbe conoscere le motivazioni vere che l’hanno spinto ad adottare una tale risoluzione. Mi sento perseguitato. Ritengo il provvedimento non già una promozione o, tanto meno, un gesto di fiducia, come lei sostiene, nei miei confronti” (p. 18). È, quindi, il capoluogo di regione, Trieste, il luogo in cui Fulvio incontra Edda, rectius, la signora Edda Martin, una competente e solerte funzionaria dell’ufficio, segretaria del direttore precedente, donna di elevata questa condizione sociale, con ascendenze caratteriali mitteleuropee, risalenti al tempo, nemmeno tanto lontano spiritualmente, degli Asburgo.
La storia d’amore che si sviluppa tra Edda e Fulvio non è né semplice né banale tanto per i caratteri entrambi quanto per i loro vissuti pregressi. Edda è sicuramente la donna che ha bisogno di un uomo molto empatico che le consenta di aprire il suo cuore al fine di rielaborare il suo passato (i rapporti familiari: simbiotico con il padre, algido con la madre, mutualistico con il fratello Renzo): Fulvio è certamente, fin dal primo momento, l’uomo per lei, la sua anima gemella, l’altra metà della mela, l’androgino che si ricongiunge, pur avendo scontato passato la presenza di una madre eccessivamente possessiva (cfr. pp. 193 – 194).
È proprio nell’ultimo capitolo del volume che emerge a tutto tondo il rapporto di Edda con il fratello Renzo, figlio dello stesso padre ma non della medesima madre, allontanato da questa dalla casa avita e divenuto un affermato neurochirurgo: egli è sempre affettivamente presente fisicamente vicino alla sorella Edda colpita da problemi di tipo oncologico e al suo compagno Fulvio:
“si trattennero fino a notte inoltrata. Parlarono di quanto era accaduto dopo la partenza di Renzo. Fulvio si intrometteva di tanto in tanto per conoscere meglio situazioni da lui non risapute […] Ascoltandolo, nell’inesplorato scopriva aspetti di una personalità che appariva i suoi occhi al di fuori dall’ordinario […] Tanto, a dispetto della fanciullezza, allorchè aveva conosciuto l’affetto necessario e, invano, cercato, per crescere e vivere in tutta serenità le relazioni familiari” (pp. 218 – 219 passim).
La loro relazione sentimentale si sviluppa contestualmente alle loro vicende professionali, in particolare, quelle di Fulvio, le cui idee in tema di leadership, forti ed innovative, sono dapprima osteggiate dal ministro, ma apprezzate al successivo cambiamento di Gabinetto: “Pensava alla formazione della squadra coinvolgendola e stimolandola verso il superamento di antiquate strutture risalenti a tempi trascorsi, contraddistinte dalla netta separazione tra i diversi settori dell’organizzazione, cui non premeva il successo, perché sorda al cambiamento. Propendeva per una struttura agile il cui capo non fosse avulso dall’assetto strutturale, immaginandolo come il protagonista che deve stare in prima linea, disseminando progetti e motivando i componenti della squadra, i quali avrebbero dovuto partecipare non da passivi esecutori, ma come attori votati al successo e al conseguimento degli obiettivi inizialmente condivisi. Era, a suo parere, la via obbligata affinchè al capo fosse riconosciuto il carisma di leader indiscusso” (pp. 68 – 69).
Nella produzione narrativa di Enzo Fiorentino, torna la specifica ambientazione in Friuli – Venezia Giulia, regione al confine orientale della nostra penisola, in cui ha vissuto le sue prime esperienze da preside di istituti di istruzione secondaria negli anni Ottanta del secolo scorso, ma senza dimenticare il paese di origine di Fulvio, che appare a chi scrive non molto dissimile da quello di Zeno, ben più presente nel romanzo precedente. Della storia novecentesca di Trieste e del Friuli – Venezia Giulia, in questo romanzo, si avverte l’eco attraverso i vissuti pregressi dei personaggi: un esempio calzante è quello del dott. Enrico Montignan, il vicario di Fulvio, “un galantuomo di tempi passati per sempre che, ahimè, non torneranno mai più” (p. 77). Egli è figlio della drammatica storia del ‘900: “Mi sento straniero in questa striscia di terra e, al tempo stesso, estraneo alla mia patria […] A questa mia prima condizione di straniero, si è aggiunta negli anni la situazione di profugo, figlio di infoibato, che insieme hanno contribuito a scaraventarmi nel pessimismo più cupo, portandomi a credere che tutta la vita è assurda” (pp. 144 – 145).
Il Fulvio di Sull’arco dell’aurora, ma anche lo Zeno di Una breve stagione d’amore, vivono esperienze indimenticabili e formative della loro personalità in luoghi diversi della regione Friuli Venezia Giulia. Sono due personaggi che hanno sicuramente molte affinità tra loro accanto alle innegabili differenze: la solida preparazione culturale, le idee assolutamente innovative sulla leadership tanto in un’azienda privata (Zeno) piuttosto che in un ufficio pubblico (Fulvio), la schiena diritta da ‘hombre vertical’. Non è difficile invenire in loro tratti caratteriali e professionali peculiari del loro creatore, indimenticabile ed indimenticato dirigente scolastico: essi, a chi scrive queste righe, appaiono i suoi eteronimi.
Anche le donne che i protagonisti incontrano in Friuli – Venezia Giulia, Nanà in Una breve stagione d’amore ed Edda in Sull’arco dell’aurora manifestano peculiarità caratteriali tipiche della loro terra ed esercitano entrambe un grande charme, sia pure i modi e forme molto diversi tra di loro. I problematici vissuti esistenziali pregressi di Edda e di Fulvio non solo non fanno velo all’immediata simpatia con Fulvio prima, evoluta rapidamente in passione ed amore poi ed infine nella condivisione di un progetto di vita, ma consentono lore di vivere il presente ed il futuro che insieme stanno costruendo: “Anche se di diverse estrazione familiare di opposta formazione culturale, frasi vittime Innocenti di comportamenti, che ci hanno costretti, il nostro malgrado, a vivere traversie tanto simili, che hanno finito per sconvolgere la nostra esistenza. Opprimenti le madri per differenti motivazioni fino all’asfissia, ci hanno obbligato a sottostare alla loro intransigente e volontà. Un comportamento, quello delle madri, che mal si conciliava con la colla dolcezza e la condiscendenza dei nostri padri […] Ci hanno negato l’imprescindibile serenità nella delicata stagione della pubertà quando maturavano i tratti distintivi delle età adulta“ (p.113).
Il romanzo di Enzo Fiorentino è impreziosito dalla splendida Prefazione del giornalista Duilio Paiano (pp. 7 – 11) che ben lumeggia il mondo, letterario e non, dell’autore e dei suoi personaggi, protagonisti e deuteragonisti (eccellente il cane Corso): “Sull’arco dell’aurora è, soprattutto ma non solo, un viaggio che scorre fluido, accattivante, dispensatore di conoscenze e approfondimenti che si imprimono nella mente del lettore in forma di piacevole e utile bagaglio […] al di là delle pagine del romanzo il sogno può continuare, alimentato dall’intreccio ampio respiro e di sicuro impatto emotivo” (pp. 7 – 11).
L’epilogo del romanzo, unico e sicuramente non immaginabile dal lettore prima di leggerla, è aperto e rende ragione delle personalità di Edda e Fulvio, i due protagonisti, che si legano, senza rinunciare, nessuno dei due, alle sue peculiarità, che li rendono così reciprocamente affascinanti. Creano, insieme, un unicum familiare in cui Edda e Fulvio accolgono anche Ahmed, un piccolo orfano conosciuto da Edda nel centro raccolta migranti: ”Un esito che l’avrebbe, finalmente, sottratta alla solitudine, delle cui deleterie spire era stata prigioniera. La serenità, che sarebbe scaturita dalla sua nuova condizione esistenziale, le avrebbe giovato, anche nella lotta da lei ingaggiata contro il male del secolo, che lui era solito bollare con il marchio di drago infame e malefico […] L’alba si stava indorando“ (pp. 247 – 249).
L’arco dell’aurora è quello spazio immateriale che consente ai due protagonisti, provenienti da realtà assolutamente irrelate, di aprirsi reciprocamente all’altro da sé per unirsi in una nuova dimensione – di coppia, familiare e professionale – sino ad allora inesperita, che supera le loro vite pregresse con adulta consapevolezza e con un carico di speranza verso il comune domani.

 Versione per la stampa
Versione per la stampa