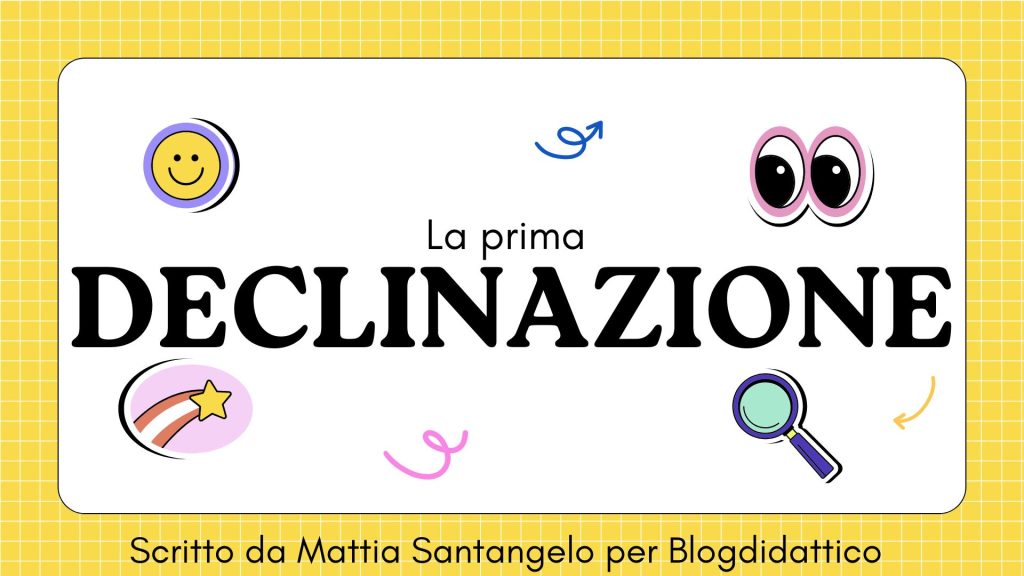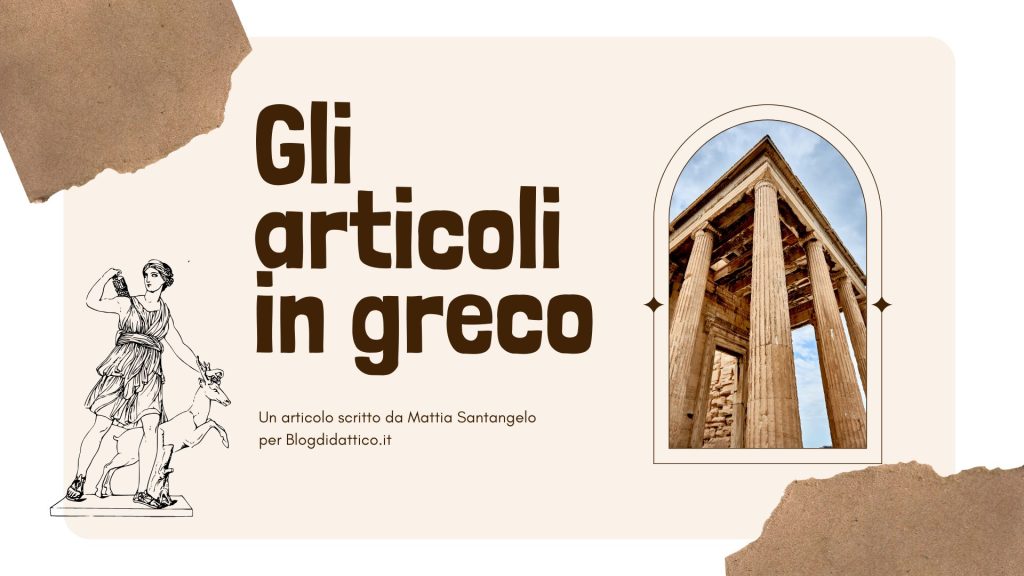All’interno della grammatica greca antica, di cui puoi trovare vari approfondimenti all’interno del nostro blog, l’articolo riveste un ruolo di primaria importanza. Ben più ricco e sfaccettato rispetto a quello italiano, esso non si limita a introdurre il nome, ma ne specifica il genere, il numero e il caso, contribuendo in maniera decisiva alla costruzione del significato all’interno della frase.
Lo studio dell’articolo è quindi fondamentale per chiunque si approcci alla lingua greca, poiché consente di cogliere sfumature sintattiche e stilistiche spesso decisive nella comprensione del testo. In questo contributo, si offrirà una panoramica completa sull’articolo greco, analizzandone le forme, le funzioni principali e gli usi più caratteristici nella lingua dei classici.
Definizioni articoli
Articolo determinativo
L’articolo determinativo del greco antico è una parte variabile del discorso che precede il nome per determinarlo e individuarlo in modo preciso. Esso si declina in genere, numero e caso, concordando sempre con il sostantivo a cui si riferisce.
Articolo indeterminativo
A differenza dell’italiano, la lingua greca conosce soltanto l’articolo determinativo; l’assenza dell’articolo o l’uso del pronome indefinito τις, τι assume la funzione di rendere l’indeterminatezza. Anche quest’”articolo” ha un ruolo fondamentale sia nella struttura sintattica della frase sia nella resa stilistica del testo.
Usi degli articoli
Per comprendere in che modo gli articoli vengano utilizzati, è necessario considerare alcune frasi italiane in cui l’articolo fa la differenza nel determinare il significato:1a. Il poeta scrive versi1b. Un poeta scrive versi2a. La donna entra nella casa2b. Una donna entra in una casa
Nei primi due esempi (1a e 2a), l’articolo determinativo (“il”, “la”) indica che si sta parlando di un soggetto già noto o specifico. Nei secondi (2a e 2b), invece, l’articolo indeterminativo (“un”, “una”) introduce un soggetto generico o non identificato.
Se traduciamo queste frasi in greco antico, notiamo subito una differenza sostanziale: la lingua greca dispone esclusivamente dell’articolo determinativo. L’idea di indeterminatezza non è resa da un articolo specifico, bensì dall’assenza dell’articolo stesso o, talvolta, dall’uso del pronome indefinito τις, τι (che può essere reso in italiano con “un certo”, “qualche”, “un tale”).
Vediamo alcuni esempi:1a. Ὁ ποιητής γράφει στίχους – Il poeta scrive versi1b1. Tις ποιητής γράφει στίχους – Un poeta scrive versi2a. Ἡ γυνὴ εἰσέρχεται εἰς τὴν οἰκίαν – La donna entra nella casa2b. Tις γυνὴ εἰσέρχεται εἰς οἰκίαν – Una donna entra in una casa
Come si può notare, come riporta il libro Instant greco antico di Roberta Meneghel, in greco l’articolo determinativo precede sempre il sostantivo e concorda con esso in genere, numero e caso. La sua corretta declinazione è dunque essenziale per comprendere la struttura della frase e il ruolo sintattico dei vari elementi.
Declinazione articoli determinativi
Singolare
CasoMaschileFemminileNeutroNominativoὁἡτόGenitivoτοῦτῆςτοῦDativoτῷτῇτῷAccusativoτόντήντόVocativo–––
Duale
CasoMaschile / Neutro/FemminileNomin./Acc.τώGen./Dat.τοῖν
Plurale
CasoMaschileFemminileNeutroNominativoοἱαἱτάGenitivoτῶντῶντῶνDativoτοῖςταῖςτοῖςAccusativoτούςτάςτάVocativo–––
Considerazioni specifiche
Dall’analisi della tabella, emergono alcune osservazioni interessanti che aiutano a comprendere meglio il funzionamento dell’articolo greco antico:
Le forme del nominativo singolare e plurale maschile e femminile (ὁ, ἡ, οἱ, αἱ) non portano accento e sono definite proclitiche: si appoggiano foneticamente alla parola successiva, formando con essa un’unica unità prosodica. Anche in italiano, del resto, è raro separare l’articolo dal nome con una pausa: difficilmente, ad esempio, pronunciamo “il … soldato” come due entità distinte.
Nel genere neutro, il nominativo e l’accusativo presentano forme identiche, sia al singolare che al plurale. Inoltre, nei casi obliqui (genitivo e dativo), le forme neutre coincidono perfettamente con quelle maschili.
Un altro elemento degno di nota riguarda l’accentazione: nei casi diretti (nominativo e accusativo), le forme che non sono proclitiche portano sempre l’accento acuto; nei casi obliqui (genitivo e dativo), invece, l’articolo è accentato con il circonflesso.
Infine, è importante precisare che il vocativo in greco non ha un proprio articolo. Nella tabella, la presenza della forma ὦ ha solo valore illustrativo: si tratta in realtà di un’interiezione usata per richiamare l’attenzione della persona interpellata, non di un articolo vero e proprio.
Declinazione articoli indeterminativi
Singolare
CasoMasch./Femm.NeutroNominativoτιςτιGenitivoτινος (του)τινοςDativoτινιτινιAccusativoτινατι
Duale (maschile/femminile/neutro: identiche per entrambi i generi)
CasoFormaNominativo/AccusativoτινεGenitivo/Dativoτοιν
Plurale
CasoMasch./Femm.NeutroNominativoτινεςτιναGenitivoτινωντινωνDativoτισι(ν)τισι(ν)Accusativoτιναςτινα
Considerazioni specifiche
Le forme duali sono poco usate con il pronome τις/τι, ma seguono regole analoghe agli aggettivi della terza declinazione.
Questo pronome è enclitico nelle forme semplici (τις, τι), cioè si appoggia alla parola precedente e può perdere l’accento. Va distinto dal pronome interrogativo τίς, τί? (con accento), che significa “chi?”, “che cosa?”.
Usi dell’articolo greco determinativo dell’antico greco
Uso con nomi comuni
L’articolo determinativo greco precede sempre il sostantivo a cui si riferisce, e concorda con esso in genere, numero e caso.
Esempi:
ἡ εἰρήνη → la pace (nominativo singolare femminile, soggetto)
τοῦ λόγου → del discorso (genitivo singolare maschile)
τῇ τέχνῃ → all’arte (dativo singolare femminile)
τῶν μαθητῶν → dei discepoli (genitivo plurale maschile)
τοῖς νόμοις → alle leggi (dativo plurale maschile)
τὰ βιβλία → i libri (nominativo/accusativo plurale neutro)
ὦ πάτερ → o padre (vocativo singolare maschile, senza articolo vero e proprio: si usa ὦ come interiezione)
Uso con nomi propri e geografici
A differenza dell’italiano, in greco l’articolo si usa spesso davanti ai nomi propri, soprattutto se si tratta di personaggi celebri o già noti nel discorso.
Esempi:
ὁ Πλάτων → (il) Platone
ἡ Ἀφροδίτη → (la) Afrodite
Anche i nomi geografici – comprese le città – richiedono l’articolo:
ἡ Ἑλλὰς → la Grecia
ἡ Θῆβαι → Tebe
τῆς Κορίνθου → di Corinto
Funzione sostantivante dell’articolo
In greco, l’articolo può precedere altre parti del discorso, trasformandole in sostantivi. Questo fenomeno si chiama sostantivazione e si ritrova anche in italiano (il bello, i buoni, il sapere…).
▸ Con aggettivi:
ὁ σοφὸς → il saggio
οἱ δυνατοί → i potenti
τὸ καλόν → il bello
▸ Con verbi (infinito o participio):
τὸ μαθεῖν → l’imparare
ὁ γράφων → colui che scrive / lo scrivente
▸ Con avverbi:
οἱ νῦν → quelli di adesso, i contemporanei
οἱ πάλαι → gli antichi
Funzione pronominale residua
Nel greco classico, l’articolo conserva in alcuni casi una funzione pronominale, ereditata dalla lingua omerica. Questo avviene in costruzioni con particelle correlative oppure in particolari espressioni fisse.
▸ Con μέν… δέ:
οἱ μὲν… οἱ δὲ → gli uni… gli altri
τοῦ μὲν… τοῦ δὲ → dell’uno… dell’altro
Esempio illustrativo (adattato):Un tale aveva due cavalli: l’uno lo addestrava alla guerra, l’altro lo utilizzava per le parate.
τις ἔχων δύο ἵππους, τὸν μὲν εἰς πόλεμον ἐπαίδευεν, τὸν δὲ εἰς ἐορτὴν ἐκόσμει.
▸ Con articolo a inizio frase (senza sostantivo espresso):
ὁ δὲ ἔλεγε… → Egli allora disse…
▸ Con avverbi e sintagmi preposizionali:
L’articolo può introdurre avverbi di tempo, luogo o intere espressioni preposizionali, trasformandoli in gruppi sostantivati.
οἱ ἄνω → coloro che stanno sopra (gli dei celesti)
οἱ κάτω → quelli che stanno sotto (i morti, gli inferi)
οἱ σύν ἐμοί → coloro che sono con me (i miei compagni)
οἱ ἐν τῇ ἀγορᾷ → quelli nella piazza (i cittadini, o chi frequenta il mercato)