Classificazione degli aggettivi
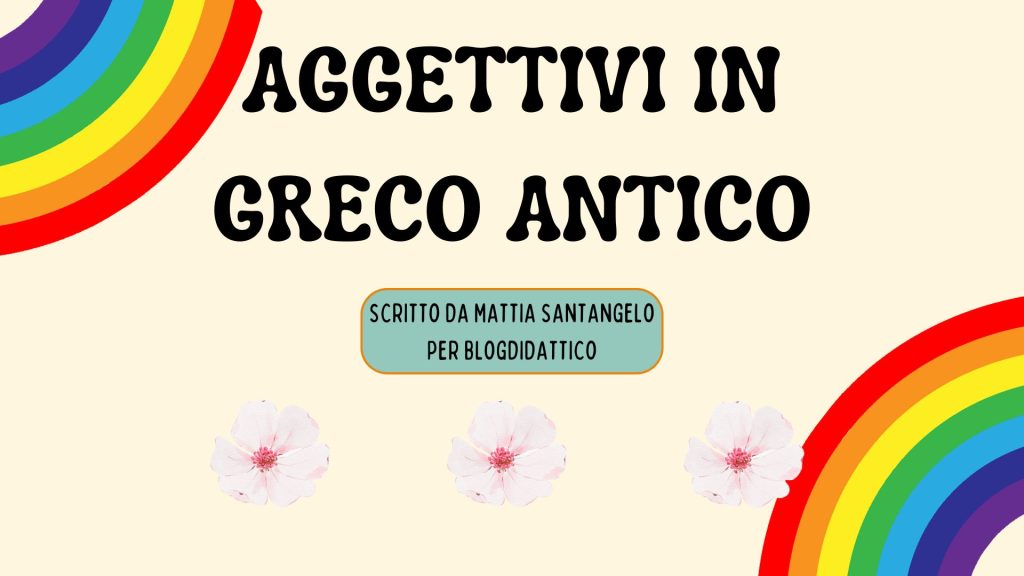
In linguistica, non solo in italiano, ma anche in greco, è frequente l’utilizzo degli aggettivi, parti integranti del discorso che servono a qualificarlo, specificarlo o determinarlo, aggiungendo informazioni che ne specificano l’identità.
Nell’italiano corrente gli aggettivi concordano con il soggetto a cui si riferiscono per genere e numero. Nella morfologia dell’antico greco, facendo parte di una lingua flessiva, predispone che l’aggettivo debba concordare con il soggetto corrispondente non solo in genere e numero, bensì anche nel caso.
Origine degli aggettivi
Gli aggettivi sono nati come risposta a una necessità comunicativa: non basta nominare un oggetto o una persona, spesso serve anche caratterizzarlo.
Ad esempio:
- Dire “uomo” (ἀνήρ) identifica solo una categoria generica.
- Dire “uomo saggio” (ἀνήρ σοφός) aggiunge un’informazione qualificante che orienta l’ascoltatore.
Storicamente, gli aggettivi derivano in gran parte:
- Da antichi participi verbali, usati in senso descrittivo (es. τρέχων = “corrente” → “che corre”).
- Da composti nominali che in origine erano frasi ridotte (es. φιλόσοφος = “amico della sapienza”).
- Da radici qualificative proprie, formate con suffissi specifici (-ος, -ής, -ύς, -ινός, ecc.).
Col tempo, queste forme si sono fissate come categoria autonoma, distinta dal verbo e dal nome, pur mantenendo stretti legami con entrambi:
- Con il nome condividono la funzione di designare qualcosa.
- Con il verbo condividono la possibilità di esprimere stati e proprietà.
Funzione nell’architettura linguistica greca
Nel greco antico, l’aggettivo svolge tre ruoli fondamentali:
- Distintivo → differenzia tra più entità (es. ὁ μικρὸς ναός vs ὁ μέγας ναός).
- Espressivo → carica emotivamente il discorso (epiteti omerici: πολύτροπος Ὀδυσσεύς).
- Sostitutivo → quando sostantivato, diventa esso stesso nome (οἱ σοφοί = “i saggi”).
Classificazione degli aggettivi nell’antico greco
1. Classificazione secondo la funzione
Dal punto di vista funzionale, gli aggettivi del greco antico si suddividono principalmente in:
1.1 Aggettivi qualificativi (ἐπίθετα ποιητικά)
- Funzione: esprimono una qualità o caratteristica del sostantivo.
- Esempi:
- καλός (kalós) = bello
- σοφός (sophós) = saggio
- Possono essere:
- Attributivi → accompagnano direttamente il sostantivo: ὁ καλὸς ἀνήρ (“il bell’uomo”).
- Predicativi → collegati al sostantivo tramite un verbo: ὁ ἀνὴρ καλός ἐστιν (“l’uomo è bello”).
1.2 Aggettivi determinativi (ἐπίθετα ὁριστικά)
Questa categoria include aggettivi che non indicano qualità intrinseche, ma limitano, precisano o determinano il sostantivo.
Comprende sottocategorie come:
- Dimostrativi → οὗτος (“questo”), ἐκεῖνος (“quello”)
- Possessivi → ἐμός (“mio”), σός (“tuo”)
- Interrogativi → τίς; (“chi?”), ποῖος; (“quale?”)
- Indefiniti → τις (“qualcuno”), ἄλλος (“altro”)
- Numerali:
- Cardinali: εἷς (“uno”), δύο (“due”)
- Ordinali: πρῶτος (“primo”), δεύτερος (“secondo”)
2. Classificazione secondo la formazione e la declinazione
Dal punto di vista morfologico, nel greco antico, gli aggettivi vengono suddivisi in due classi fondamentali:
2.1 Prima classe:
Comprende:
- aggettivi a tre uscite: seguono al maschile e al neutro la seconda declinazione, al femminile la prima;
- aggettivi a due uscite: presentano un’unica forma per il maschile e per il femminile, seguendo esclusivamente il modello della seconda declinazione;
- aggettivi della declinazione attica;
- aggettivi contratti a tre uscite;
- aggettivi contratti a due uscite.
2.2 Seconda classe:
Comprende aggettivi maschili, femminili e neutri vincolati da tutte le possibili sfaccettature della terza declinazione, che analizzeremo insieme negli articoli successivi.
Aspetti sintattici rilevanti
Gli aggettivi possono avere tre posizioni tipiche rispetto all’articolo e al sostantivo:
- Attributiva semplice:
ὁ καλὸς ἀνήρ = l’uomo bello - Attributiva articolata:
ὁ ἀνὴρ ὁ καλός = l’uomo bello (ma con enfasi) - Predicativa (senza articolo davanti all’aggettivo):
ὁ ἀνὴρ καλός = l’uomo è bello

