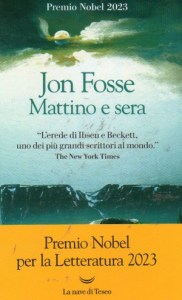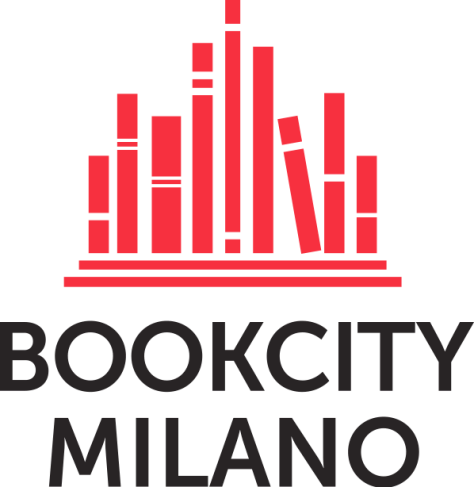BOOKCITY MILANO 2023
Dal 13 al 19 novembre la dodicesima edizione della manifestazione dedicata al libro e alla lettura
Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.Edgar Allan Poe
Milano, 24 ottobre 2023. Lunedì 13 novembre avrà inizio la dodicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, da AIE – Associazione Italiana Editori e dal Centro per il libro e la lettura.
BookCity Milano è sostenuto da Intesa Sanpaolo (main partner), da Esselunga (premium partner), con la collaborazione di Fondazione Cariplo e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Partecipano inoltre Eni, Recordati, Amplifon, Galleria Campari, TIM, Pirelli, Fondazione Fiera Milano, Gruppo San Donato, Burgo Group, BiM, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Enel, Federazione Carta e Grafica, Comieco, Messaggerie Libri SpA, Fondazione AEM; partner tecnico ATM. Sono media partner dell’edizione 2023 di BookCity Milano: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, Rai Radio2, Rai Radio3, Feltrinelli Librerie, Giornale della Libreria, ilLibraio.it.
Tempo del sogno
BookCity Milano 2023 sarà scandita dal Tempo del sogno, quell’istante effimero che nasce nel profondo del sonno e racchiude il potere di trasformare la veglia, ma “sogno” è una parola polisemica, capace di evocare associazioni di pensieri e desideri profondi, utopie e distopie, evasioni e battaglie, incubi e paure; è la parola che abita ogni speranza: sogni di gioventù, sogni a occhi aperti, sogni proibiti, sogni di gloria, sogni di un futuro migliore. Da Penelope a Giovanna d’Arco, da Freud a Pasolini, da Cenerentola a Hitchcock, da Luther King a Bergoglio, i sogni hanno popolato le opere della letteratura di tutti i tempi, influenzando anche filosofi e pensatori, artisti e figure di riferimento del mondo della cultura.
Dedicato al tema dell’anno, l’evento inaugurale di BookCity Milano 2023 si terrà mercoledì 15 novembre alle 20.00 al Teatro Dal Verme: la serata avrà come protagonista lo scrittore turco Orhan Pamuk, Premio Nobel per la Letteratura 2006, che per l’occasione riceverà il Sigillo della Città dal sindaco Giuseppe Sala. Le opere dello scrittore turco mettono in luce le diverse sfaccettature del rapporto tra Oriente e Occidente, restituendo narrazioni spesso complesse, in bilico tra realtà e immaginazione: uno sguardo autentico sulla vita umana e sulle sue emozioni. A intervenire sul tema dell’anno sarà Alessandra Kustermann, prima donna primario della Clinica Mangiagalli e fondatrice del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica, primo del suo genere in Italia. La serata, condotta dall’autrice Giovanna Zucconi, sarà anche l’occasione per rendere omaggio ad Achille Mauri, una delle anime di BookCity fin dal momento in cui è nata, scomparso all’inizio di quest’anno.
Se il tema di BookCity Milano 2023 è il Tempo del sogno, la manifestazione non può esimersi dal raccontarne la controparte oscura: Raccontare l’incubo. La cronaca nera da Buzzati ai podcast è l’incontro dedicato alla raccolta degli articoli scritti da Dino Buzzati nella sua carriera da cronista. Come si raccontano le vicende più efferate, i soggetti più malvagi? Come è cambiato il racconto della cronaca nera? Ne parleranno Stefano Nazzi, autore del pluripremiato podcast Indagini e lo scrittore Giacomo Papi, sabato 18 novembre alle 11.30 al Piccolo Teatro Grassi.
Di sogni e utopie tratta anche l’incontro dedicato al prossimo anniversario della nascita di Franco Basaglia (2024), figura rivoluzionaria nel campo della salute mentale e della medicina psichiatrica: BCM23 rende omaggio a un grande pensatore del XX secolo insieme alla figlia, Alberta Basaglia, e al conduttore radiofonico Massimo Cirri, protagonisti dell’incontro Il sogno di Basaglia, al Caffè Rouge del Teatro Franco Parenti, sabato 18 novembre alle 12.30.
Al tema dell’anno è ispirata anche la partecipazione a BCM23 di sette editori cattolici, coordinati dalla Diocesi di Milano, che si uniscono per la prima volta in un’iniziativa comune, proponendo una serie di incontri intitolati Artigiani di sogni – Due giorni, dieci incontri, una comunità; il progetto verrà presentato al Palazzo Arcivescovile, giovedì 16 novembre alle 18.30, con il giornalista Mario Calabresi e l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, moderati dalla giornalista Catia Caramelli.
Questi e molti altri eventi guideranno i lettori alla scoperta del tema portante di BookCity Milano 2023, come Il sogno del futuro, con Nicola Montano, Maria Rescigno, Francesco Stellacci, Roberto Vittori e Barbara Gallavotti nel ruolo di conduttrice, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che offre un taglio scientifico sull’argomento; Walter Veltroni ricorderà un simbolo della passione politica e civile che ha segnato la storia americana, Il sogno di un mondo migliore. Storia di John e Bob Kennedy; Maurizio Harari e José Enrique Ruiz-Domènec guideranno il pubblico alla scoperta di Il sogno di Ulisse. Storia umana del Mediterraneo dalla guerra di Troia all’emergenza degli sbarchi; Donatella Massimilla introdurrà il dialogo serrato e ironico tra Moni Ovadia e Danielle Sassoon, dal titolo Vietato calpestare i sogni. Anche la follia merita i suoi applausi – A Beirut non ci sono più cani; e ancora Arte, fantasia, sogni che attraversano il tempo: tra la Milano dei primi del Novecento e la Venezia contemporanea, la storia dell’arte, le bellezze della natura, dove i sogni, le coincidenze e alcuni capolavori artistici giocano un ruolo sorprendente, con Roberta Cordani, Luigi Mignaccio, Ferruccio de Bortoli e Giulio Silvano.
La riflessione sul Tempo del sogno si concluderà domenica 19 novembre, alle 20.00, con una serata al Teatro Franco Parenti intitolata I libri del sogno: Vittorio Lingiardi accompagnerà il pubblico nella biblioteca dei sogni, un labirinto in cui perdersi, accompagnati dalla voce di Federica Fracassi, in un viaggio che spazia dalle venti oche bianche di Penelope agli incubi di Elio Aristide, tra i versi di Ovidio e Cvetaeva, alla scoperta della differenza tra i sogni di Freud e di Jung, passando per il litigio neuroscientifico tra Hobson e Solms, con uno sguardo ai diari onirici di Kafka e Schnitzler, dando spazio alle immagini di Bergman e Lynch.
Le novità di BookCity Milano 2023
La dodicesima edizione di BookCity Milano porta con sé diverse novità, come l’inaugurazione della Casa della Voce, il nuovo spazio che l’Area Biblioteche del Comune di Milano dedica alle forme di cittadinanza attiva che operano in città nell’ambito della lettura, negli spazi dell’ex Fornace di via Gola (Alzaia Naviglio Pavese 16): l’inaugurazione si terrà giovedì 16 novembre alle 18.00 e prevede un intervento dell’attrice Anna Nogara che, per l’occasione, leggerà ad alta voce alcuni testi di Carlo Emilio Gadda, in occasione dei cinquant’anni dalla morte. A seguire tre giorni di letture ad alta voce.
Per permettere ai lettori di scoprire autori e autrici che hanno raccontato e fatto grande Milano, nel 2024 andrà online Let-Mi – Letteratura Esperienza Turistica a Milano, una piattaforma digitale open source che metterà a disposizione i capolavori ambientati in città; il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, è realizzato dal Comune di Milano (Città Creativa Unesco per la Letteratura dal 2017) in collaborazione con YesMilano. I contenuti della piattaforma sono realizzati grazie al coinvolgimento degli scrittori e delle scrittrici delle principali istituzioni culturali milanesi, per promuovere l’anima letteraria del capoluogo lombardo.
BCM23 sarà anche l’occasione per celebrare diversi anniversari della letteratura e del mondo della cultura: in occasione dei 140 anni dalla prima edizione in volume di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, la manifestazione ospita la lettura ad alta voce dell’opera, da parte del cantante, attore, compositore e sceneggiatore Peppe Servillo; la lettura, suddivisa in tre parti, si terrà nelle serate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre, alle 19.00 al Teatro Gerolamo.
In occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, la Fondazione Culturale San Fedele ospiterà diversi incontri dedicati allo scrittore, poeta, padre del romanzo italiano, tra i quali: mercoledì 15 novembre alle 17.30 La pietà di Manzoni, con Stefano Motta e Iuri Sandrin S.J.; giovedì 16 novembre alle 17.30 Il complicato rapporto dei Gesuiti con Manzoni con Giancarlo Pani; Fabiola Giancotti e Gualtiero Scola tratteranno invece di Francesco Hayez e gli altri. Il ritratto di Manzoni, sabato 18 novembre alle 11.00; ancora sabato 18, alle 16.00, Daniela Pizzagalli e Gianni Rizzoni saranno protagonisti dell’evento Alessandro Manzoni. L’uomo dietro l’icona; sabato 18 novembre alle 16.00 si terrà anche l’incontro Il Conte del Sagrato. Storie e racconti sull’Innominato con Carlo Arrigoni, Mattia Cattaneo e l’accompagnamento musicale di Viola Valsecchi al violoncello, a cura di Architetti delle Parole. Domenica 19 novembre, alle 11.00, con Matteo Bianchi e Silvia Stucchi sarà infine il momento di esplorare il Manzoni contemporaneo.
A cinquant’anni dalla morte dello scrittore milanese Carlo Emilio Gadda, BookCity Milano ospiterà l’incontro Come lavorava Gadda, la presentazione del libro I viaggi la morte con la curatrice del volume Mariarosa Bricchi e Claudio Vela, al Circolo Filologico Milanese, domenica 19 novembre alle 16.00. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare Il Gaddus, la nuova rivista di lettura e di studio dedicata a Carlo Emilio Gadda, sotto la direzione scientifica di Mariarosa Bricchi, Paola Italia, Giorgio Pinotti e Claudio Vela, in collaborazione con il Centro Studi Gadda (CSG) dell’Università di Pavia.
Nel centesimo anniversario della nascita della celebre soprano Maria Callas, la manifestazione ospiterà anche La vera Maria Callas, incontro con l’autrice Annarita Briganti e Isabella Fava, letture di Alessandra De Luca, domenica 19 novembre alle 16.00 al Teatro Franco Parenti.
Come ormai da tradizione, a BCM23 torna anche il progetto delle Città Creative UNESCO per la Letteratura: per l’occasione BookCity Milano ospiterà una delegazione da Angoulême, sede di uno dei più importanti festival di fumetti al mondo, per due appuntamenti dedicati: in Triennale una tavola rotonda con Silvia Ziche, Sergio Gerasi e Giulio “Il baffo” Mosca, che incontreranno i tre autori francesi Nathalie Ferlut, Giorgia Marras e Benoît Hamet per confrontarsi su cosa voglia dire fare fumetto in Italia e in Francia; al Castello Sforzesco un incontro tra Jacques De Loustal, considerato uno dei massimi illustratori contemporanei, e Tito Faraci, fumettista, scrittore, tastierista, paroliere, traduttore e curatore editoriale italiano, per rivolgere un omaggio corale, al mondo del fumetto.
Secondo un format già sperimentato durante l’edizione 2022, BCM23 ripropone i Percorsi d’autore, invitando scrittori, giornalisti e rappresentanti del mondo culturale italiano a curare cicli di incontri mirati a proporre dialoghi a più voci e di più lunga durata, per approfondire temi specifici. La giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Benedetta Tobagi propone il percorso intitolato La guerra ha volto di donna? Donne narratrici, combattenti, vittime dei conflitti, che prevede tre incontri: La guerra ha (anche) voce di donna. Alterità e ribaltamento di prospettive nelle narratrici (dialogo con la scrittrice Helena Janeczek), Donne combattenti: una (lunga) storia confinata nell’ombra e Stupri come arma di guerra, ieri e oggi. Il percorso, che approfondisce il ruolo delle figure femminili nei contesti bellici e nelle loro narrazioni, si terrà a Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, sabato 18 novembre, dalle 14.00 alle 17.00.
Giornalista, autrice e conduttrice di programmi culturali per radio e televisione, Giovanna Zucconi cura il percorso Io mi racconto: sembra che gli esseri umani non facciano altro che documentare ogni minuzia delle loro esistenze. Cosa accade, invece, quando sono poeti e narratori a dire “io”? A dialogare con la curatrice saranno Solvej Balle, Cristina Battocletti, Matteo B. Bianchi, Daniele Bresciani, Paolo Di Stefano, Nicola Gardini, Giovanna Granato, Vivian Lamarque, Matteo Lancini e Piergiorgio Paterlini. Il ciclo si terrà al Laboratorio Formentini per l’editoria, domenica 19 novembre, dalle 16.30 alle 19.30.
Colloqui a distanza tra ChatGPT e Italo Calvino è il percorso d’autore dedicato all’intelligenza artificiale, curato da Massimo Sideri, editorialista e inviato del Corriere della Sera sui temi di scienza e cultura dell’innovazione, che dialogherà con esperti e studiosi per approfondire: ChatGPT e la società, con Rita Cucchiara, Umberto Ambrosoli e Giuseppe Italiano; ChatGPT e la cultura, con Christian Greco, Derrick de Kerckhove e Maria Rosa Taddeo, da remoto; ChatGPT e l’etica, con Maria Chiara Carrozza, Giorgio Metta, Andrea Prencipe e Luciano Floridi, da remoto. Il percorso si terrà alla SIAM – Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, sabato 18 novembre, dalle 14.00 alle 17.00.
Già commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana, ex amministratore delegato della Scuola Holden di Torino e politico, Mauro Berruto è il curatore del percorso Sport e letteratura; introdotto dall’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, il ciclo prevede dialoghi tra il curatore e Paolo Quarenga, Alberto Galimberti, Davide Grassi, Francesco Rago e Bruno Barba e si terrà all’Arci Bellezza domenica 19 novembre, dalle 10.30 alle 13.30.
Giornalista e saggista, Eliana Liotta è la curatrice della seconda edizione del percorso Le parole della cura, per raccontare i valori e i progressi delle scienze della vita a partire da quattro macro concetti chiave: Visione, con Silvia Bencivelli e Giuseppe Remuzzi; Protezione, con Fabrizio Pregliasco, Paola Arosio ed Enzo Spisni; Microbiota, con Maria Rescigno, Silvio Danese e Marco Bianchi; Unicità, con Michela Matteoli e Carlo Selmi. Gli incontri si terranno domenica 19 novembre dalle 16.00 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Il percorso è realizzato con il contributo non condizionante di Recordati.
Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice dell’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ed Elisa Giunipero, direttrice dell’Istituto Confucio dell’Università Cattolica del Sacro cuore, sono le curatrici del Percorso d’autore che analizza il riemergere degli imperialismi, nelle loro varie dimensioni (politica, militare, economica, culturale), nella politica mondiale e l’impatto di questo fenomeno sugli equilibri internazionali. Intitolato Imperi vecchi e nuovi: il futuro dell’ordine mondiale, il percorso si articola in tre parti: Russia, con Eleonora Tafuro Ambrosetti, Giulia Maria Isabella Lami, Micol Flammini; Turchia, con Valeria Talbot, Federico Donelli, Lucia Goracci; Cina e USA, con Alberto Giovagnoli, Simone Pieranni, Filippo Fasulo, Elena Beccalli, Patrizia Toia. Il percorso si terrà sabato 18 novembre, dalle 15.00 alle 18.00, all’ISPI – Palazzo Clerici.
Infine, BookCity Milano 2023 prevede un Percorso d’autore dedicato al verde, intitolato Parole sul giardino, affidato alla curatela di Emanuela Rosa-Clot, direttrice del magazine Gardenia; il ciclo si terrà domenica 19 novembre dalle 15.00 alla Palazzina Appiani e prevede dialoghi con Pietro Bruni, Laura Cinzia Bassi, Antonio Perazzi, Benedetta Forni e Maria Lodovica Gullino.
BCM23 in Lombardia: Cremona e Lodi
Tradizionalmente diffusa e inclusiva, in occasione dell’edizione 2023, BookCity Milano raggiunge altre due città: Cremona e Lodi.
Nella città di Cremona propone un palinsesto di incontri e presentazioni, eventi musicali e dialoghi, da mercoledì 15 novembre a domenica 19 novembre, in collaborazione con il Porte Aperte Festival. L’edizione cremonese di BCM sarà l’occasione per dare spazio alla narrazione come strumento d’identità, voce polifonica che cerca di generare un’esperienza di condivisione e coesione sociale; a guidare questa riflessione sarà l’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, che esplorerà quali le pratiche e i progetti possibili per mantenere vivi e dinamici i contesti urbani. Il programma prevede, tra gli altri, un ciclo di incontri intitolato Cambiare, città. Abitare, abitudini, curato da Stefano Bartezzaghi, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza delle trasformazioni nel contesto urbano; il ciclo prevede tre incontri tra il curatore, semiologo e giornalista, e Cristina Bianchetti, ordinario di Urbanistica presso il Politecnico di Torino, Laura Pigozzi, psicoanalista lacaniana, e Sarah Gainsforth, ricercatrice e giornalista. Gli incontri di BookCity Milano a Cremona sono resi possibili grazie alla collaborazione con il Comune di Cremona.
BookCity Milano 2023 raggiunge anche Lodi, con un palinsesto ricco e variegato, in collaborazione con U.S. Organizzazione Eventi – Provincia di Lodi e Ufficio Cultura del Comune di Lodi. Tra gli ospiti in programma uno dei maggiori poeti del nostro tempo, Milo De Angelis, alla scoperta del De rerum natura di Lucrezio, insieme a Pietro Sarzana. Luca Doninelli incontrerà le ragazze e i ragazzi del Liceo Pietro Verri per parlare della sua rilettura del capolavoro manzoniano. Giancarlo Cerveri spiegherà invece come distinguere tra le convinzioni forti che aiutano a raggiungere una meta e le rigidità mentali e i fanatismi che invece possono annichilire, in dialogo con l’autore la giornalista Eliana Liotta. Nella Sala ex Chiesetta della Provincia di Lodi la fotografa Paola Mattioli presenterà il suo volume di ritratti fotografici in dialogo con Francesca Adamo, curatrice del libro e della collana che lo ospita. Questi e molti altri incontri animeranno l’edizione lodigiana di BCM23.
Tra gli ospiti di BCM23
Manifestazione inclusiva e partecipata per definizione, anche quest’anno BookCity Milano accoglierà molti ospiti italiani e stranieri nel suo ricco programma: scrittori, romanzieri e poeti, illustratori e fotografi, filosofi e giornalisti, ma anche molte altre professioni legate al mondo del libro, della cultura e ai tanti focus tematici proposti dal palinsesto.
Tra i tanti incontri, proiezioni, laboratori, letture si ricordano: il dialogo tra Michele Serra e Altan sulla satira; l’incontro tra Umberto Galimberti e Luigi Zoja; Carlo Ginzburg e Adriano Sofri, alle prese con “spie e altro”; alcune tra le più celebri scrittrici di romanzi storici degli ultimi anni, Stefania Auci, Francesca Giannone, Daniela Raimondi, Alessandra Selmi; le autrici del romance all’italiana, Erin Doom, A. J. Foster, Rokia, Carrie Leighton e Vanessa Arcadipane; non mancheranno alcuni dei maestri del noir italiano, come Gianni Biondillo, Gian Andrea Cerone, Luca Crovi e Andrea Fazioli. Lo scrittore Premio Campiello Marco Balzano, lo storico Alessandro Barbero, le scrittrici Susanna Tamaro e Viola Ardone, l’ex calciatore e allenatore Franco Baresi, la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra, il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Pierluigi Battista, il chimico, divulgatore scientifico e youtuber Dario Bressanini, il filosofo e saggista Massimo Cacciari, il medievalista e scrittore Franco Cardini, l’autore di thriller Donato Carrisi, la scrittrice di romanzi rosa Felicia Kingsley, lo scrittore fantasy Manlio Castagna, la scrittrice e sceneggiatrice Rita Charbonnier, lo scrittore Premio Strega Paolo Cognetti, lo scrittore triestino Mauro Covacich, il conduttore radiofonico, attore e scrittore Fabio Volo e molti altri. Ma anche gli illustratori e fumettisti Bruno Bozzetto, Sara Dealbera, Michael Rocchetti (Maicol&Mirco) e Zerocalcare.
Molto spazio anche alle autrici e agli autori stranieri, come lo scrittore e giornalista olandese Jan Brokken; il filosofo e psicoanalista argentino, naturalizzato francese, Miguel Benasayag; l’autore americano Claude Anshin Thomas, veterano della guerra in Vietnam; Haim Baharier, psicoanalista francese di origini polacche; la scrittrice britannica Joanne Harris; Greg Hoffmann, celebre direttore del marketing Nike. Senza dimenticare due figure di grandi fotografi, che saranno ospiti di BCM23: Steve McCurry e Guido Harari.
Tra gli ospiti anche lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, lo scrittore e sceneggiatore Piergiorgio Baccalario con Chiara Alessi, curatrice e saggista in materia di cultura materiale e design; i giornalisti Aldo Cazzullo e Mario Calabresi, che intervista Ersilia Vaudo Scarpetta per una puntata live del podcast Altre/Storie; il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri racconterà il nuovo volto della ‘ndrangheta, con Antonio Nicaso e Cesare Giuzzi.
Ci sarà anche il regista Sergio Iapino, in un incontro per ripercorrere la storia di Raffaella Carrà, l’imprenditore tecnologico Federico Marchetti, la giornalista e scrittrice Michela Marzano, il giornalista Maurizio Molinari, direttore di la Repubblica, lo scrittore Premio Strega Antonio Scurati, in dialogo con Ezio Mauro e David Bidussa, il critico d’arte e sottosegretario di Stato alla cultura Vittorio Sgarbi, il conduttore televisivo Bruno Vespa, le autrici di libri per l’infanzia Harry Whittaker e Katherine Rundell, la sociolinguista Vera Gheno, l’archeologo tedesco, naturalizzato italiano, Gabriel Zuchtriegel e molti altri ancora.
Non solo, BCM23 sarà anche l’occasione per incontrare il giornalista e scrittore Paolo Rumiz, il virologo, immunologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni, il musicista e cantautore Gino Paoli insieme a Ornella Vanoni e Daniele Bresciani, lo scrittore Mauro Corona con il cantautore Omar Pedrini, la scrittrice Melania Mazzucco, i giornalisti Matteo Bordone e Francesco Costa, celebre podcaster, lo scrittore e traduttore Paolo Nori.
Tornano anche gli incontri di Poetry and the City, come Emily Brontë: Il mio cuore ama il sorriso, che prevede una riflessione sulla scrittrice inglese e la lettura ad alta voce di alcune delle sue poesie, con Vivian Lamarque, Nicola Gardini e Vittorio Lingiardi; l’evento, introdotto da Giuseppina Manin e Cristina Battocletti, si terrà alla RSA Arzaga della Comunità Ebraica di Milano, domenica 19 novembre alle 11.00. Sempre domenica 19 novembre, alle 16.30 al Circolo PD Milano Centro “A. Aniasi”, si terrà l’incontro Giovanni Giudici. Il politico del poetico. La colpa è non commuoversi al momento giusto: introdotto da Giuseppina Manin, l’evento prevede interventi di Nicola Gardini, Michele Crisostomo, Vivian Lamarque, Teresa Franco e Luca Formenton. Domenica 19 novembre alle 10:00 Poetry and the city parteciperà anche all’evento Ode agli Alberi, una colazione en plein air con letture poetiche, occasione per celebrare la natura dopo i tanti alberi caduti in estate, tra gli aceri di BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano.
La storica emittente milanese Radio Popolare, che da sempre accompagna BCM, quest’anno partecipa con un palinsesto all’Auditorium Demetrio Stratos: il libro fotografico di Guido Harari su Enzo Jannacci, le partigiane raccontate da Serena D’Angelo e Stefano Catone, il gruppo di architetti milanesi e antifascisti narrati da Gianni Biondillo, il poeta Luigi Ballerini e la precisione del suo linguaggio, Cochi Ponzoni presentato da Gino e Michele, la storia della mitica R4 ricostruita da Piero Trellini, la legalità come sentimento dal punto di vista di Nando Dalla Chiesa e la vicenda di Mani Pulite, raccontate da Gherardo Colombo. Per finire, il passato e il futuro dello stadio e della zona di San Siro con Claudio Sanfilippo e Tiziano Marelli.
Per la dodicesima edizione di BookCity Milano, su Rai Radio2, Caterpillar realizzerà una puntata speciale, insieme al pubblico, in diretta dal Centro di Produzione Rai di corso Sempione, per dare vita a un grande gruppo radiofonico di lettura live: Caterpillar racconterà i gruppi di lettura e proverà a farne nascere uno, insieme a Simonetta Bitasi, che forma gruppi di lettura in tutta Italia, guida reti bibliotecarie e anima il Festival Letteratura di Mantova.
Inoltre, in occasione di BCM23, nel cortile d’Onore di Palazzo Reale sarà installata la scultura multimediale site-specific La Luce della Mente – un’insegna urbana, realizzata dall’artista Federica Marangoni, che sarà visibile dal 15 novembre al 10 dicembre. Nel portico dell’Elefante invece verrà esposta una mostra con le fotografie più belle del contest #lamiabellitalia, a cura di Bell’Italia, da giovedì 16 novembre a domenica 19 novembre.
Mestieri del libro e consumi culturali
Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno BookCity Milano sarà l’occasione per riflettere sul futuro del libro e dell’editoria, a partire dalla presentazione di un’indagine promossa da Intesa Sanpaolo e articolata in due parti: una mirata a comprendere che cosa rappresenta la cultura per i giovani, come e dove fruiscono dei contenuti e che rapporto hanno con i festival, a cura di BVA DOXA; l’altra curata da Giulia Cogoli e Guido Guerzoni, per indagare i “nuovi festival”, quelli con meno di 10 edizioni alle spalle, per una mappatura della nuova generazione di festival culturali. Fruizione culturale: i giovani tra festival e social media si terrà in Triennale, Saletta Lab, venerdì 17 novembre alle 10.30.
Sul tema anche l’indagine Lettura e consumi culturali a Milano, che verrà presentata in anteprima rispetto all’inizio della manifestazione: giovedì 9 novembre alle 10.00 a Palazzo Reale verranno mostrati i dati dell’Osservatorio a cura di AIE – Associazione Italiana Editori, ampliati grazie alla collaborazione con SIAE, che arricchisce la ricerca dei dati di effettiva fruizione di tutti i consumi culturali nel territorio del Comune di Milano e nell’area metropolitana, in un rapporto dinamico tra il 2020 e oggi. L’evento è a cura di AIE, Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e BookCity Milano.
Di abitudini di lettura tratta anche l’incontro Il futuro del leggere. Giovani e lettura, una storia contemporanea, promosso dal Centro per il libro e la lettura, che ha promosso un’indagine quantitativa e qualitativa tra i giovani per raccogliere dati e analizzare come l’avvento del digitale stia modificando la dimensione del leggere. A presentare i risultati di questa ricerca saranno Marco Gambaro, Lella Mazzoli e Marino Sinibaldi, sabato 18 novembre alle 14.00 al Laboratorio Formentini per l’editoria.
Sul tema anche l’incontro Cosa leggeremo l’anno prossimo?, presentazione del Rapporto 2023 dell’Osservatorio sul Futuro dell’Editoria, con Massimiliano Tarantino, Alessandra Carra, Carlo Antonelli, Lorenzo Gigotti e Valentina Tanni che ripercorreranno le tappe del ciclo di Page not Found, cui è ispirata la prima sezione del Rapporto, che guarda alle pratiche sperimentali di scrittura e alle nuove forme di lettura immersiva, integrando anche l’intelligenza artificiale nella riflessione sugli scenari futuri dell’editoria, per poi riflettere sui trend attuali. L’evento si terrà alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, venerdì 17 novembre alle 18.30.
E molti altri ancora saranno gli eventi dedicati al focus tematico I Mestieri del libro: tra questi, al Laboratorio Formentini per l’editoria Pietro Biancardi, Cristina Gerosa, Massimo Lafronza e Elisa Richemi presenteranno Archivio del presente, il nuovo progetto della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori per esplorare le trasformazioni dell’editoria; mentre Antonella Agnoli, Paola Dubini e Oliviero Ponte di Pino prenderanno parte a un dialogo sui nuovi spazi della cultura, intitolato L’energia culturale: libri, biblioteche, librerie, città, sempre al Laboratorio Formentini per l’editoria.
Venerdì 17 novembre alle 17.00 alla Libreria UBIK Il sogno di esordire: la premiazione del torneo letterario IoScrittore sarà un’occasione per riflettere sui cambiamenti nel mondo dell’editoria, su come arrivare alla pubblicazione, tra scouting tradizionale e opportunità delle piattaforme digitali. Con Francesca Giannone, autrice di La portalettere, Rokia, autrice di The Truth Untold. La verità nascosta, Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica del festival Taobuk, Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, Tiberio Sarti, amministratore delegato delle Librerie Ubik, Edoardo Scioscia, presidente del Libraccio, Eugenio Trombetta Panigadi, consigliere delegato di Ibs. Moderano Silvia Cannarsa e Antonio Prudenzano, rispettivamente redattrice e responsabile editoriale de ilLibraio.it. Ed è rivolto alle scuole il progetto di Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri che si propone di avvicinare gli studenti e le studentesse delle secondarie superiori alla professione del libraio.
La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno
Nei giorni di BCM23 si terrà anche la terza edizione di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale ideato e promosso insieme a Fondazione Cariplo, che si pone in continuità con il precedente programma La Lettura Intorno, ampliandone il raggio d’azione a tutti i nove Municipi di Milano, coinvolgendo l’intero territorio cittadino per costruire un sistema che si ponga l’obiettivo di sostenere la lettura e il libro, soprattutto tra bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Saranno moltissimi gli incontri rivolti ai più giovani, tra presentazioni di libri e laboratori, spettacoli e azioni partecipate: sabato 18 novembre alle 15.00 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ospiterà l’incontro con Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi e Marta Meli, intitolato Due donne, due scienziate, un universo, rivolto a ragazzi dai dodici anni in su; Lissander Brasca, Simona Scuri e Roberta Sottile saranno protagonisti dell’incontro Pimpa in viaggio in Lombardia! che si terrà da Wow Spazio Fumetto domenica 19 novembre alle 15.30; sabato 18 novembre alle 11.00 alla Centrale dell’Acqua, Valentina Gottardi e Maciej Michno terranno il Workshop Ronzante, rivolto ai bambini dai sei anni in su; domenica 19 novembre alle 11.00 la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi ospiterà l’incontro Una tana tutta per me!, con Loredana Baldinucci, rivolto a bambini dai quattro anni; Paola Cosmacini e Maria Eugenia D’Aquino saranno protagoniste dell’incontro La ragazza con il compasso d’oro. La straordinaria vita della scienziata Émilie du Châtelet, sabato 18 novembre alle 17.30 da PACTA . dei TEATRI, Salone via Dini; domenica 19 novembre alle 15.00 il Teatro Bruno Munari ospiterà Maria Cappello, Francesca Galafassi e Piroddi Angela, per l’incontro Le emozioni sono come i palloncini, per bambini dai tre anni in su; Scoprire Milano dal finestrino di un tram (6-10 anni), con Lorenzo Biffi ed Elia Radico, si terrà da mosso sabato 18 novembre alle 15.00; Marcello Duranti, Sandro Frera e Rita Pugliese saranno protagonisti dell’incontro Da grande voglio fare lo scrittore, domenica 19 novembre alle 12.30 alla Biblioteca Sormani; molto spazio anche ai temi legati ai social, come nel caso di Big Nate. La scuola nell’era di TikTok: sopravvivere all’ansia da prestazione con autoironia e fiducia in se stessi, con Valentina Brioschi e Federica Solca, domenica 19 novembre alle 10.30 alla Biblioteca Sormani.
La rete di BookCity Milano 2023
Manifestazione da sempre gratuita e inclusiva, BookCity Milano ha potuto crescere negli anni grazie al sostegno di aziende e imprese, che le permettono di portare avanti il suo palinsesto.
Lunedì 13 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 alla Biblioteca Sormani, l’incontro Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa del Centro per il libro e la lettura nata da un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Cultura. L’edizione di quest’anno è intitolata Se leggi ti lib(e)ri ed è dedicata alla letteratura fantastica: in occasione dei 50 anni dalla traduzione italiana del romanzo Lo Hobbit e i 50 anni dalla scomparsa dell’autore, J. R. R. Tolkien, il Centro per il libro e la lettura del MiC promuove un convegno indirizzato a studiosi e insegnanti, lunedì 13 novembre dalle 9.00 alle 12.30, alla Biblioteca Sormani; parteciperanno: Oronzo Cilli, Giuseppe Pezzini, Piero Boitani, Carlo Pagetti, Maria Elena Ruggerini, Roberta Capelli e Oriana Palusci, con i saluti del Sottosegretario di Stato al Ministero del Merito e dell’Istruzione Paola Frassinetti; il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà collegato da remoto.
Mercoledì 15 novembre alle 11.00, all’Auditorium “Guido Martinotti”, si terrà l’evento La costruzione della nuova Repubblica da sogno a realtà. Rileggere i lavori dell’Assemblea Costituente a 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, presentazione di un progetto di digitalizzazione e ripubblicazione dei lavori dell’Assemblea Costituente curato da Giuseppe Valditara ed Elisabetta Lamarque, sviluppato da Giappichelli Editore con il sostegno di Intesa Sanpaolo.
Giovedì 16 novembre alle 20.30 al Teatro Studio Melato il reading – spettacolo musicale Passione, di e con Maurizio de Giovanni, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore, celebre soprattutto per i suoi gialli; la serata teatrale prevede un viaggio nella storia della canzone napoletana, attraverso autori, storie, sentimenti, poetica e musica, quella stessa musica che tanto spesso fa capolino nei romanzi dell’autore. Una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency.
Sabato 18 novembre alle 10.30 alla Società Umanitaria un incontro dedicato ai giovani e all’orientamento, per parlare di futuro, aspettative, sogni: Incontri possibili: dialogo per disegnare il domani, con lo scrittore Federico Taddia e la partecipazione della giornalista Silvia Nucini, host del podcast Voce ai Libri. Evento promosso da Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’iniziativa di orientamento ‘Disegnare il Domani’.
Sabato 18 novembre alle 16.00 alla Fondazione Corriere della Sera verrà proiettato il documentario Otro Renacimiento. Da Napoli a Madrid, dal Prado a Capodimonte, un viaggio tra Italia e Spagna che, nello svelare straordinari capolavori del Rinascimento, si immerge nel tessuto delle città contemporanee, da Napoli a Madrid, da Barcellona a Granada, fino ai paesaggi dell’Aragona e al lascito artistico di Milano, Firenze e Roma. Evento promosso da Intesa Sanpaolo.
A BookCity Milano 2023 torna anche la lettura ad alta voce nei Bar Atlantic, gli esclusivi bar di Esselunga che nel celebrare vent’anni dalla loro prima apertura, ospitano il Menù della poesia: attori professionisti nei panni di eleganti camerieri reciteranno su richiesta le poesie scelte dal pubblico da un vero e proprio menù poetico, per portare la cultura anche in luoghi inaspettati, permettendo al pubblico di assaggiare una poesia. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre, in nove negozi su tutto il territorio cittadino.
Sabato 18 novembre alle 15.30 all’ADI – Design Museum si parlerà di trasformazioni urbane e di Vivere e abitare le città di oggi – rigenerazione urbana, gentrificazione e sostenibilità: un momento di discussione e confronto su argomenti quanto mai attuali, in particolar modo a Milano. A dispetto della sua complessità, Milano offre un ricco ventaglio di risorse e opportunità di intervento, sempre più necessarie per promuovere il protagonismo delle comunità locali, la coesione sociale, lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Evento promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Dalla pubblicazione della sceneggiatura, mai girata, del docu-film scritto da Franco Solinas e Jean-Paul Sartre, conservato nell’archivio storico Eni, nasce l’incontro “Un Dio nero, un diavolo bianco”: l’Italia, l’Africa ed il cinema: la guerra d’indipendenza algerina, il cinema industriale, il ruolo degli intellettuali, l’anticolonialismo e il terzomondismo in Italia sono protagonisti di un film (e di un libro) che saranno spunto per parlare del complesso clima politico e culturale di un’epoca. Giovedì 16 novembre alle 17.00 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Evento promosso da Eni.
Martedì 14 novembre, alle 10.30, Amplifon organizza un appuntamento dedicato all’inclusione sociale delle persone anziane. L’evento, Let’s dream – riflessioni sul sogno tra generazioni, porterà letture ad alta voce nella Casa di Riposo RSA di via Pindaro 44, offrendo ai residenti e alle loro famiglie la possibilità di ascoltare brani tratti da Le avventure di Pinocchio. Tra i lettori ci saranno anche i volontari dell’azienda. L’iniziativa è collegata a “Ciao!”, il più importante progetto di Fondazione Amplifon, partito da Milano nel 2021 e che oggi coinvolge oltre 200 residenze sanitarie assistenziali non profit in tutta Italia.
Martedì 14 novembre alle 18.00 alla Galleria Campari (Sesto San Giovanni) si terrà l’incontro Storie di libri, parlarne al bar: i caffè di un tempo rappresentavano un luogo di ritrovo per artisti e intellettuali, uno spazio dove gli scrittori potevano confrontarsi sulle proprie poetiche e le ultime tendenze letterarie. Oggi i bar sono luoghi di ritrovo ma anche di lavoro, scambio di idee, condivisione, dove le persone si trovano a leggere, scrivere e presentare libri. Spazio conviviale per eccellenza, quali storie ospitano i bar? Una chiacchierata insieme a Marco Ardemagni, Petunia Ollister e Antonio Prudenzano. Evento a cura di Galleria Campari.
Passeggiate urbane. Dalla Campionaria, a Citylife, a… è l’evento proposto da Fondazione Fiera in collaborazione con BCM, un percorso a tappe con Andrea Cerchi alla scoperta degli spazi della città in grado di portare alla luce il racconto di una memoria urbana che ci permette di conoscere il passato, comprendere meglio il presente e immaginare il futuro. La passeggiata per le scuole secondarie sarà condotta da Gino Cervi.
Attento al valore della lettura anche il Gruppo San Donato Foundation, che ospiterà in alcuni reparti dei suoi ospedali letture ad alta voce. Inoltre, giovedì 16 novembre, nell’Aula Magna del Policlinico San Donato, si terrà l’incontro Scrittura e fotografia terapeutica, per esplorare il potere taumaturgico di scrittura e fotografia con Barbara Pasquariello, Alessia Spina, e Alessandro Pini e la conduzione di Sonia Scarpante; seguirà un mini-laboratorio di scrittura e fotografia terapeutica. L’evento è promosso da Gruppo San Donato Foundation.
Domenica 19 novembre alle 16.00 nel Salone d’Onore della Triennale si terrà l’incontro Cartaceo #05 – Fare Castelli di Carta: attraverso le parole di Valerio Lundini e le immagini di Carlo Stanga, il pubblico potrà addentrarsi in un surreale elogio dei progetti più spericolati. L’evento è in collaborazione con Burgo Group.
Lettura su carta e scrittura a mano. L’azione politica e sociale per la loro valorizzazione: Andrea Cangini (Fondazione Luigi Einaudi), Federico Mollicone (Commissione Cultura Scienza e Istruzione) e Simona Malpezzi (Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza) discuteranno di come la politica possa salvaguardare la lettura su carta e la scrittura a mano. L’evento si terrà alla Fondazione Corriere della Sera giovedì 16 novembre alle 11.00 ed è promosso da Federazione Carta e Grafica e Comieco.
Tra i luoghi di BCM23 anche BiM – dove Bicocca incontra Milano, il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Bicocca, con una serata dedicata alla presentazione del primo libro di The Milaneser, con la rivista C41 e gli artisti di Specific.
BCM23 nelle Scuole, nelle Università e negli spazi del Sociale
Come da tradizione, il programma della manifestazione prevede tanti incontri anche per le tre sezioni BookCity per le Scuole, BookCity Università e BookCity per il Sociale.
Nel palinsesto BCM per le Scuole torna BCZeta. Istruzioni per l’autogestione delle manifestazioni culturali: quanto è difficile progettare un palinsesto culturale? Quali temi approfondire oggi? A rispondere a queste domande saranno 20 studenti e studentesse di due licei milanesi, che hanno accolto l’invito di BCM e del Sistema Bibliotecario di Milano a progettare e curare insieme il palinsesto della Biblioteca Oglio. Gli studenti si sono occupati di organizzare gli appuntamenti della sede, dalla scelta degli argomenti alla definizione del format, fino all’individuazione degli ospiti. Tra i temi scelti: politica e sicurezza, il successo del true crime, l’esplosione del romance, e poi musica, fotografia e intelligenza artificiale, con ospiti come Stefano Nazzi, Stefania Carini, Luca Marconi, Francesca Ponchielli, Edith Joyce, Francesca Cianfrocca, Patrizia Violi, Giuseppe Paternò Raddusa, Francesco Zendri di Rap Italiano Game Over. L’appuntamento è per le giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre, alla Biblioteca Oglio.
Torna anche BookCity Università nelle accademie milanesi, che hanno raccolto l’invito di BookCity a riflettere insieme alle loro comunità e alla città sul tema dell’anno, il Tempo del sogno, declinandolo secondo le competenze specifiche e le materie d’indirizzo: la NABA si sofferma sulla relazione fra libri e film; in Università Luigi Bocconi, a partire dalla lettura del presente, verrà dato spazio alle scienze sociali. L’Università Cattolica propone riflessioni sul sogno di autoaffermazione femminile e sul potere della poesia, della cultura e dei libri di ingaggiare il lettore; il Politecnico di Milano anima i suoi spazi off campus con incontri che guardano al sogno in una prospettiva di trasformazione, delle persone e degli spazi; il palinsesto di Bicocca propone diverse parole chiave in associazione al tema dell’anno: memoria e futuro, reale e immaginato, aspirazioni individuali e delle comunità scientifiche, con riflessioni sui diritti e sul legame fra sogno e incubo. IULM concentra i suoi incontri sul rapporto fra analogico e virtuale, dal mondo del lavoro a quello della comunicazione, fino alla didattica. L’Università Statale indaga le aspirazioni a un futuro sostenibile, sia sul piano sociale sia su quello ambientale, proponendo inoltre un incontro multidipartimentale dedicato a Saffo e al sogno di una rosa. Questi e molti altri ancora sono gli spunti emersi dal palinsesto BookCity Università, che lavora tutto l’anno per coinvolgere gli studenti e realizzare iniziative anche al di fuori del palinsesto novembrino.
Moltissime anche le realtà che partecipano a BookCity per il Sociale, che coinvolge le carceri di San Vittore, di Opera, Bollate, Minorile Beccaria e ICAM, l’ospedale di Niguarda, il Gruppo San Donato e il San Carlo Borromeo, Casa Jannacci, Fondazione Casa della Carità, Centro Ronda, Fondazione Culturale San Fedele, Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline Onlus, con diversi incontri sul tema dell’anno, spettacoli teatrali e musicali, presentazioni e dialoghi, raggiungendo anche gli spazi dell’associazionismo sul territorio, come le Case delle Associazioni e del Volontariato, le Biblioteche di Condominio e gli spazi WeMi.
I dati di BCM23
Come da tradizione, BCM si rivolge al pubblico con un palinsesto ricco e variegato, che coinvolge l’intera filiera del libro, dagli scrittori ai fumettisti, editori grandi e piccoli ma anche saggisti e illustratori, blogger e librai, traduttori e bibliotecari, senza dimenticare studenti, insegnanti, lettori forti e occasionali. Sono 3.100 gli autori e le autrici ospiti della manifestazione, con più di 1.500 eventi e oltre 500 editori coinvolti; saranno oltre 390 i volontari nelle 300 sedi diffuse su tutto il territorio cittadino, tra cui 43 librerie e 27 biblioteche. BCM23 ospita inoltre 190 progetti dedicati alle classi di Milano e della Città Metropolitana all’interno di BookCity per le Scuole, 13 tra università e accademie milanesi nel palinsesto di BookCity Università, senza dimenticare i progetti di BookCity per il Sociale, che raggiunge carceri, ospedali, luoghi della carità e biblioteche di condominio.
Il programma, in costante aggiornamento, ed eventuali indicazioni per accedere agli appuntamenti, sono disponibili sul sito della manifestazione all’indirizzo www.bookcitymilano.it.
L’Associazione BOOKCITY MILANO è presieduta da Piergaetano Marchetti e diretta da un Comitato d’indirizzo di cui fanno parte Carlo Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Stefano Mauri. La coordinazione dell’edizione 2023 è stata affidata a Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il supporto di Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri. Ai lavori dell’Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e, per l’Associazione Italiana Editori, il suo Presidente Ignazio Cipolletta.
#BCM23www.bookcitymilano.itFB: BookCity Milano | IG: @bookcitymilano | X: @BOOKCITYMILANO | TikTok: @bookcitymilano
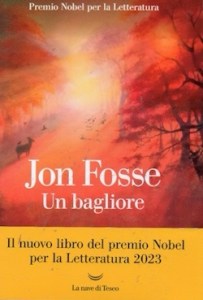

 Versione per la stampa
Versione per la stampa