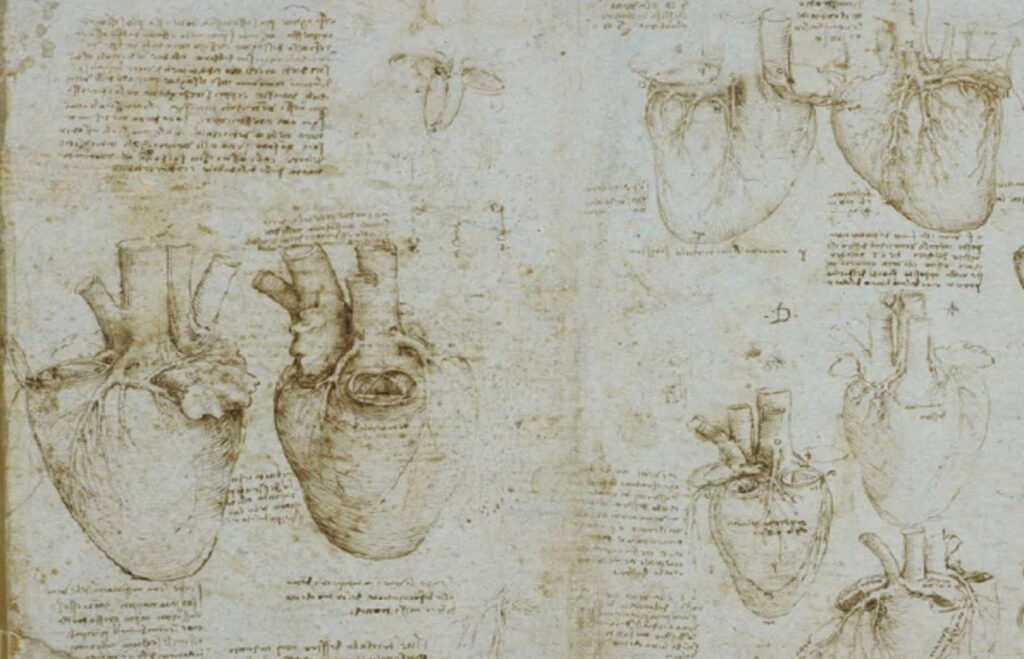I generi musicali Musica per bambini di Scuola Primaria
La musica accompagna il cammino degli uomini ed è per questo che è molto importante e significativa, perché anche solo una parola può essere l’inizio di una dolce melodia.
I generi musicali – Musica per bambini di Scuola Primaria
Ci sono vari tipi di musica: la musica strumentale, cioè quel tipo di musica dove gli unici protagonisti sono gli strumenti, e la musica vocale.
I generi musicali principali sono 8:
MUSICA CLASSICA
Descrizione: è la musica colta (cioè scritta da musicisti professionisti per un pubblico di grande cultura). Spesso è solo strumentale.
Storia della Musica classica: dall’undicesimo secolo (cioè dall’anno 1000) fino agli inizi del 1900. Ancora oggi ci sono compositori che scrivono brani definiti, per comodità, di “musica classica contemporanea”.
La musica classica, come ogni altro genere, è stata composta ed è stata ascoltata per divertirsi, per provare emozioni, per rilassarsi, proprio come facciamo noi oggi con la musica moderna. In molte occasioni i brani di musica classica venivano scritti appositamente come musiche per accompagnare i balletti.
Geografia della Musica classica: la musica classica è nata in Europa. È ascoltata ancora oggi, praticamente in tutto il mondo.
Strumenti utilizzati nella Musica classica: qualsiasi strumento da orchestra (fiati, archi, percussioni, strumenti a corda).
Autori celebri nella Musica classica: Vivaldi, Beethoven, Mozart, Bach, Chopin, Tchaikovsky e tantissimi altri.
Brani di Musica classica più famosi:
– Antonio Vivaldi, La Primavera
– Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 5
– Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 40
– Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Il lago dei cigni
2. MUSICA LIRICA
Descrizione: apparterrebbe al genere della musica classica, con una caratteristica in più: non si tratta solo di musica strumentale, ma anche cantata. Non bisogna pensare però a una semplice canzone: la musica lirica prevede che un’intera storia venga trasformata in uno spettacolo musicale che si chiama opera.
Storia della Musica lirica: dal sedicesimo secolo (1500) fino ai giorni nostri. Ancora oggi vengono composte opere liriche, che vengono definite “contemporanee”.
Geografia della Musica lirica: la musica lirica, come quella classica, è nata in Europa.
Strumenti utilizzati nella Musica lirica: l’accompagnamento musicale di un’opera lirica avviene, come per la musica classica, con qualsiasi strumento da orchestra.
Autori celebri nella Musica lirica: Verdi, Wagner, Bizet, Rossini, Puccini e tantissimi altri.
Brani di Musica lirica più famosi:
– Giuseppe Verdi, Nabucco (Va’ Pensiero)
– Gioacchino Rossini, Il barbiere di Siviglia (Largo al factotum)
– Giacomo Puccini, Turandot (Nessun dorma)
– George Bizet, Carmen (L’amour est un oiseau rebelle)
3. MUSICA FOLK
Descrizione: in ogni territorio, in ogni tempo, per qualsiasi popolazione, la musica ha sempre avuto una grandissima importanza. La musica folk è la musica tradizionale di un popolo o di una zona specifica. Spesso non coincide con i confini geografici di una nazione e altrettanto di frequente si possono trovare incredibili somiglianze nelle sonorità, negli strumenti usati, perfino nelle danze che accompagnano certe musiche, anche se si considerano paesi lontanissimi e con una storia molto diversa.
Storia della Musica folk: dalle origini del mondo ai giorni nostri.
Geografia della Musica folk: in qualsiasi territorio abitato da persone.
Strumenti utilizzati nella Musica folk: dai più semplici (tamburi, flauti ricavati da legni cavi) ai più complicati e raffinati, come la fisarmonica.
Autori celebri nella Musica folk: la musica folk appartiene alle tradizioni di un popolo. Per questo molto spesso è impossibile stabilire chi abbia scritto un brano. I canti e le musiche restano vivi perché continuano a essere suonati e cantati anche a distanza di secoli.
Brani di Musica folk più famosi:
– Italia, Pizzica salentina
– Africa, Danza tradizionale Sudafricana
– Irlanda, Reel tradizionale
– Nuova Zelanda, Haka Mate
– Balcani, Odessa Bulgarish
– USA, Cotton Eyed Joe
4. MUSICA JAZZ
Descrizione: è un genere musicale di origine statunitense, nato nelle comunità afroamericane (cioè delle persone di colore) del sud degli Stati Uniti. In quel periodo la popolazione nera era la parte più povera e discriminata della popolazione americana, spesso ancora in condizioni di semi-schiavitù. Per questo motivo il jazz riflette spesso la sofferenza di queste popolazioni e per molto tempo è stato giudicato un genere musicale senza alcun valore. Il jazz mescola le tradizioni musicali africane, quelle europee e la musica popolare e fa grande uso dell’improvvisazione.
Storia della Musica Jazz: dai primi anni del ventesimo secolo (cioè dal 1900) fino ai giorni nostri. La musica jazz è scritta, suonata e cantata ancora oggi.
Geografia della Musica Jazz: la musica Jazz nasce, si diffonde e diventa famosissima negli Stati Uniti d’America. Oggi compositori, musicisti e cantanti Jazz sono presenti in tutto il mondo.
Strumenti utilizzati nella Musica Jazz: pianoforte, contrabbasso, ottoni (come tromba, saxofono, trombone, ecc.), batteria, chitarra e molti altri.
Autori celebri nella Musica Jazz: Duke Ellington, Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Billie Holiday, Louis Armstrong, e tantissimi altri.
Brani di Musica Jazz più famosi:
– Duke Ellington, Take the A train
– Billie Holiday, Strange fruit
– Thelonious Monk, Round midnight
– Round midnight (versione cantata, Ella Fitzgerald)
– Louis Armstrong, What a wonderful world
5. MUSICA BLUES
Descrizione: è un genere musicale di origine statunitense, strettamente collegato al jazz e contemporaneo. Il nome deriva dall’espressione “to have the blue devils” (letteralmente: avere i diavoli blu) col significato di “essere triste, malinconico”. Per lo stesso motivo era nche chiamata “musica del diavolo”
Il blues nasce dai canti degli schiavi di origine africana che lavoravano nelle piantagioni degli Stati Uniti d’America, ed è collegato alle musiche africane grazie all’uso dell’antifona (chiamata e risposta) e delle blue note (un insieme di note dissonanti e che hanno dato al blues il soprannome di musica stonata). Molti degli stili della musica popolare moderna derivano o sono stati fortemente influenzati dal blues che, come anche il jazz, si è fuso con molti altri generi musicali, creando stili sempre nuovi e differenti.
Storia della Musica blues: non c’è una data di nascita precisa. Tuttavia un anno fondamentale fu il 1865, anno dell’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d’America: numerosi ex schiavi-musicisti iniziarono a portare la loro musica fuori dalle piantagioni e, nel giro di qualche decennio, questo genere si diffuse enormemente. La musica blues è scritta, suonata e cantata ancora oggi.
Geografia della Musica blues: la musica blues nasce, si diffonde e diventa famosissima negli Stati Uniti d’America. Oggi compositori, musicisti e cantanti Jazz sono presenti in tutto il mondo.
Strumenti utilizzati nella Musica blues: principalmente strumenti a corda (chitarra, basso, contrabbasso), percussioni e batteria, ma anche pianoforte, fiati, eccetera.
Autori celebri nella Musica blues: Robert Johnson, Jelly Roll Morton, Ray Charles, Muddy Waters, John Lee Hooker, The Blues Brothers, Eric Clapton, Robben Ford, Etta James, B.B. King, John Mayall, Gary Moore e tantissimi altri.
Brani di Musica blues più famosi:
– C. Khan, E. James, G. Night, Ain’t Nobody’s Business
– Albert King, Kansas City
– Willie Mae “Big Mama” Thornton, Hound dog
– Elvis Presley, Hound Dog
– The Blues Brothers, Sweet Home Chicago
– Robert Johnson, Sweet Home Chicago
– Robert Johnson, Come on in my kitchen
– Cassandra Wilson, Come on in my kitchen
6. MUSICA Rock
Descrizione: è un genere musicale, nato nel corso degli anni cinquanta e sessanta nel Regno Unito (UK) e negli Stati Uniti (USA). Ha le sue origini nella musica dei decenni precedenti, in particolare il blues, il country e la musica folk.
Tra la metà degli anni sessanta ed i primi anni settanta, la musica rock ha sviluppato diversi sottogeneri: folk rock, blues-rock, rock elettronico, heavy metal, progressive rock, punk rock, alternative rock, grunge e tantissimi altri sottogeneri.
Storia della Musica rock: a partire dagli anni 50-60 del 1900 e fino a oggi.
Geografia della Musica rock: è diffusa in tutto il mondo, anche se le “culle” della musica rock sono gli Stati Uniti d’America (USA) e il Regno Unito (UK).
Strumenti utilizzati utilizzati nella Musica rock: qualsiasi strumento, in particolar modo chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, fiati, archi.
Autori celebri celebri nella Musica rock: Elvis Presley, Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Nirvana, Bruce Springsteen, Who, Pink Floyd e tantissimi altri.
Brani di Musica rock più famosi:
– Doors, Light my fire
– Elvis Presley, A little less conversation
– A little less conversation remix
– Rolling Stones, Jumpin Jack Flash
– Led Zeppelin, Black dog
– Deep Purple, Smoke on the water
– Queen, We will rock you
– Pink Floyd, The Wall
– Cure, The kiss
– Nirvana, Smells like teen spirit
– Tori Amos, Smells like teen spirit
– Negrita, Cambio
– Green Day, Holiday
7. MUSICA POP
Descrizione: come dice il nome stesso (pop deriva da popular, cioè popolare) è la musica più comune, più diffusa. Spesso è stata accusata di essere superficiale, priva di contenuti, senza vere qualità musicali e interpretative. In Italia la musica pop si chiama anche musica leggera.
La realtà è che sotto la definizione di musica pop si trovano decine di sottogeneri, artisti, caratteristiche che sono impossibili da riassumere in poche righe. Ci troviamo canzoni che durano una stagione, classici ancora ascoltati dopo molti anni, brani di cantautori, brani di denuncia, impegnati, realizzati per beneficienza e così via.
Storia della Musica POP: a partire dagli anni 50 del 1900 e fino a oggi (la maggior parte della musica che ascoltiamo quotidianamente va sotto il nome di musica pop).
Geografia della Musica POP: è diffusa letteralmente in ogni angolo del mondo, anche se le “culle” della musica pop sono gli Stati Uniti d’America (USA) e il Regno Unito (UK).
Strumenti utilizzati nella Musica POP: qualsiasi strumento musicale, dalle chitarre alle batteria, dai fiati alle percussioni, dal pianoforte ai sintetizzatori computerizzati.
Autori celebri nella Musica POP: Beatles, Madonna, Michael Jackson, David Bowie, Elton John e migliaia di altri artisti.
Brani di Musica POP più famosi:
– Beatles, Ticket to ride
– David Bowie, Ziggy Stardust
– Police, Message In A Bottle
– U2, Sunday Bloody Sunday
– Michael Jackson, Thriller
– Madonna, Material Girl
– R.E.M., Turn You Inside-Out
– Lunapop, Vespa 50 Special
– Madonna, Jump
– Robbie Williams, Candy
8. MUSICA RAP/HIP-HOP
Descrizione: il nome di questo genere deriva dall’espressione Rhythm And Poetry (ritmo e poesia). Il rap consiste essenzialmente nel “parlare” seguendo un certo ritmo.
Rappresenta un vero e proprio stile di vita, nato negli Stati Uniti d’America verso la fine degli anni sessanta e diventato parte di spicco della cultura moderna.
Il rap di fatto è l’espressione musicale della cultura hip hop, nata presso la comunità afroamericana e latinoamericana di New York nei primi anni settanta. A seguito di numerose fusioni con altri generi musicali, anche il rap si è suddiviso in una moltitudine di sottogeneri.
Storia della Musica RAP/HIP-HOP: a partire dagli anni 60 del 1900 e fino a oggi.
Geografia della Musica RAP/HIP-HOP: il rap nasce negli Stati Uniti d’America, ma si è diffuso in tutto il mondo.
Strumenti utilizzati utilizzati nella Musica RAP/HIP-HOP: batteria, chitarre, basso, ma soprattutto sintetizzatori computerizzati.
Autori celebri celebri nella Musica RAP/HIP-HOP: Run.DMC, Public Enemy, LL Cool J, Eminem, Lauryn Hill, MC Hammer, Ice-T e tantissimi altri.
Brani di Musica RAP/HIP-HOP più famosi:
– RUN-DMC ft. Aerosmith, Walk This Way
– Public Enemy, Fight The Power
– Frankie Hi Nrg MC, Faccio la mia cosa
– Eminem, Lose Yourself
I generi musicali per Scuola Primaria – Musica per bambini di Scuola Primaria
Maestra di Sostegno – Scuola Primaria
Articoli Simili