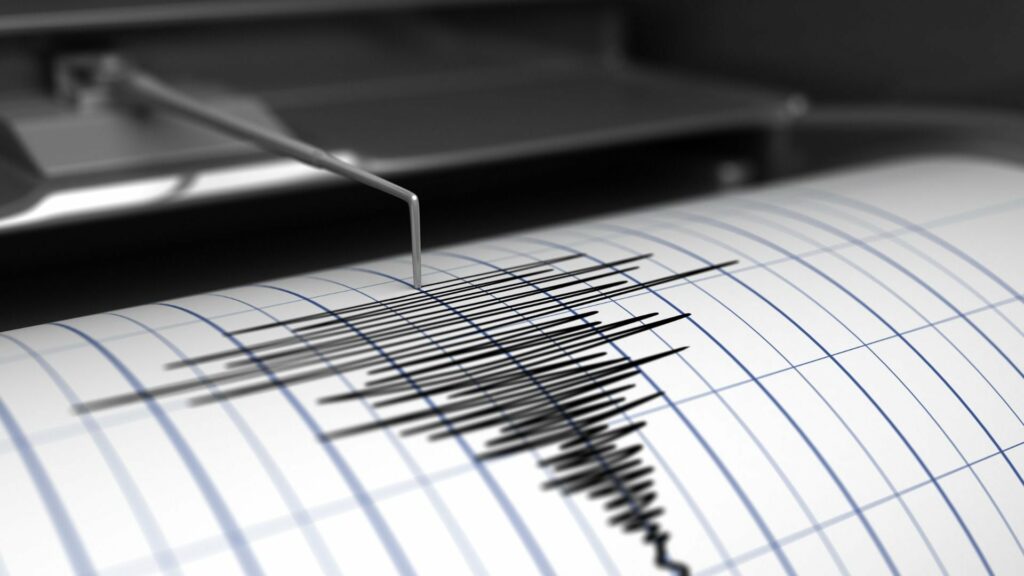Il 3 aprile 2024 Taiwan è stato colpito da un terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi 25 anni. Le vittime (dato aggiornato al 4 aprile 2024) sono 9, mentre i feriti hanno superato quota 1.000. La contea di Hualien è stata l’epicentro del sisma, e l’economia taiwanese ha subito una temporanea interruzione per permettere ai soccorsi di entrare in azione. Alcune persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, e le autorità stanno facendo il possibile per salvarle.
Considerando l’intensità del sisma (che è stato seguito da 96 scosse di assestamento), i danni sono stati abbastanza contenuti, soprattutto se paragonati a quelli provocati nel recente passato da terremoti che hanno colpito la Siria o la Turchia. Gran parte del merito è da attribuire agli edifici antisismici e alla preparazione della popolazione per affrontare questo tipo di eventi, che hanno aiutato a limitare le perdite di vite umane.
Piegati, non spezzati. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di edifici inclinati su se stessi, ma rimasti pressoché integri, costruiti applicando i più recenti accorgimenti nel campo dell’ingegneria antisismica, adottati a Taiwan soprattutto dopo il terremoto del 1999 che provocò oltre 2 mila morti e 50mila case danneggiate.
Le principali soluzioni attualmente a disposizione si basano su isolamento e dissipazione. Le tecniche di isolamento sismico si ottengono posizionando sotto le fondazioni della struttura dispositivi in grado di ridurre la violenza delle sollecitazioni indotte dai terremoti. Mentre l’altra strategia prevede la dissipazione dell’energia elastica trasmessa dal sisma all’edificio, e si può ottenere mediante particolari dispositivi inseriti nella struttura. Si può anche pensare all’aggiunta di masse accordate oscillanti, chiamate anche mass damper, che hanno lo scopo di assorbire le vibrazioni indotte da un sisma, entrando in risonanza in modo da lasciare in quiete il resto dell’edificio. Un esempio è quello inserito nel Taipei 101, il celeberrimo grattacielo di Taipei, a Taiwan: è una “palla” di acciaio che oscillando è in grado di compensare le vibrazioni indotte da un terremoto o dal vento.
Nella torre Taipei 101 (a Taipei, Taiwan), alta oltre 500 metri, c’è il più grande damper, smorzatore a massa risonante, del mondo: una sfera di 5,5 metri di diametro (nel tondo) smorza le oscillazioni dovute a venti e terremoti.
© Shutterstock
Perché i terremoti in Siria e Turchia hanno provocato molti più danni?
Anche il terremoto in Giappone dello scorso capodanno 2024 ha avuto conseguenze, ma meno catastrofiche rispetto al suo potenziale distruttivo. Il primo gennaio infatti la penisola di Noto, affacciata sul braccio di mare che separa le isole nipponiche dalla Corea, è stata scossa da un violento sisma, di 7,6 gradi della scala Mmw (cioè di magnitudo del momento sismico). Le immagini impressionanti hanno fatto subito il giro del mondo: case e pali della luce che ondeggiavano come fuscelli, scaffali dei supermercati da cui la merce cadeva a valanga, l’asfalto delle strade fratturato da ampie voragini.
Terreno sollevato di 4 metri. I giapponesi sono attrezzati pure loro a eventi del genere, e anche più distruttivi, ma l’impressione è stata profonda. Secondo i sismologi dell’Università del Tohoku di Sendai, una delle più antiche del Paese, quel sisma è stato generato dai movimenti di un insieme di faglie dormienti da almeno 3.000 o 4.000 anni. Come conseguenza, in alcuni punti il terreno si è alzato di quasi 4 m e la costa è avanzata di circa 240 m. I porti si sono sollevati e le barche sono rimaste in secca. Due settimane dopo l’evento, il conto delle vittime era di 232 morti e 20 dispersi. Le case considerate inagibili dopo una prima rapida ispezione erano quasi 1.800, anche se il numero totale di quelle danneggiate, secondo gli esperti, toccava alcune decine di migliaia. Eppure molti in Italia sono rimasti impressionati anche in questo caso dalla qualità delle case. Abituati a immagini come quelle del terremoto in Turchia e Siria del febbraio 2023, comparabile per magnitudo a quello giapponese e di Taiwan, in molti si sono chiesti quale sia il segreto per costruire edifici così resistenti ai terremoti.UN LABORATORIO UNICO. «In realtà non esiste un segreto in particolare», ci spiega però Ivan Roselli, ricercatore dell’Enea (l’agenzia nazionale che si occupa di energia, ambiente e nuove tecnologie) specializzato in ingegneria sismica e delle vibrazioni. «Le soluzioni strutturali per resistere ai terremoti vanno sempre scelte e valutate in base alla pericolosità sismica e ai possibili effetti “di sito”, cioè del luogo specifico dove sono costruite le strutture. Una soluzione valida in un determinato luogo in Giappone potrebbe non essere altrettanto efficace in un paesino montano del nostro Appennino». Roselli fa parte del team che lavora nel laboratorio delle tavole vibranti, un luogo della ricerca che ha pochi uguali in Europa e nel mondo, perché dotato di speciali tavole, mobili su sei gradi di libertà e quindi in grado di riprodurre nel modo più realistico possibile i movimenti dei terremoti. Uno dei suoi punti di forza sono le dimensioni. La tavola più grande ha una base di 4×4 m e permette di studiare il comportamento delle strutture anche a dimensioni reali e non in scale troppo ridotte.
[embedded content]
La situazione in Italia è molto diversa che in Giappone o a Taiwan
«La situazione del Giappone», continua Roselli, «è molto diversa dalla nostra, perché costituita in prevalenza da grandi città dove le costruzioni sono in gran maggioranza recenti».
Nel Paese sono state introdotte stringenti norme di edilizia antisismica nel 1981, aggiornate nel 2000, e quindi la maggioranza degli edifici per abitazione è in grado di comportarsi molto bene in caso di scossa.IL PROBLEMA È NEL PASSATO. «Da noi», osserva Roselli, «le cose sono molto diverse. In Italia la normativa di riferimento per la progettazione antisismica è l’Eurocodice 8, approvato dalla Commissione Europea nel 2003 e recepito nelle nostre norme tecniche nel 2008. Oltre il 90% del nostro parco abitazioni è precedente a quella data. Quindi in Italia il problema non riguarda tanto le nuove costruzioni, che se realizzate a norma sono estremamente sicure, ma tutto quanto è stato edificato in passato, in particolare nel periodo del boom edilizio, negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, o ancora prima». La nostra tradizione architettonica e ingegneristica privilegia le strutture in cemento armato e in muratura, «che possono essere estremamente sicure anche nel caso di terremoti ad alta magnitudo, se progettate seguendo le norme. La sicurezza antisismica, in effetti, non è tanto un fatto di materiali quanto di corretta progettazione», aggiunge l’esperto.SERVE UNA MAPPATURA GEOLOGICA. In ogni caso, il primo ingrediente per costruire a prova di terremoto o per mettere in sicurezza l’esistente è condurre un corretto esame geologico, che tenga conto sia della mappatura accurata della pericolosità sismica dell’area geografica dove si costruisce», spiega Roselli, «sia della “microzonazione” basata sullo studio degli effetti di sito, cioè su un’analisi del sottosuolo nel punto esatto dove si intende costruire per verificare la possibilità di effetti locali indotti da un sisma. Anche in zone a non elevata pericolosità sismica possono innescarsi fenomeni locali distruttivi, come avvenne nel terremoto dell’Emilia del 2012, in cui in alcune aree si verificò un imprevisto fenomeno di liquefazione del terreno».Sulla base delle mappe di pericolosità sismica e della microzonazione, aggiunge l’esperto, «diventa quindi possibile individuare un “terremoto di progetto” per simulare, tramite calcoli, le azioni dinamiche a cui può essere sottoposto un edificio in caso di sisma. Sulla base di questa simulazione il progettista può determinare gli accorgimenti da adottare per rendere sicura la struttura».
Per resistere ai terremoti le nuove costruzioni sfruttano isolamento e dissipazione
Le principali soluzioni, si diceva, consistono in tecniche di isolamento sismico e di dissipazione dell’energia elastica. L’Italia è all’avanguardia nella ricerca su queste soluzioni. Oltre all’Enea sono numerose le realtà con particolari competenze nel settore, come le università La Sapienza e Roma Tre di Roma, la Federico II di Napoli, quelle di Genova, Padova, Perugia, l’Università della Basilicata, l’Università Kore di Enna o i Politecnici di Milano e di Torino, solo per citarne alcune.
Senza dimenticare il contributo della Fondazione Eucentre di Pavia, del Cnr e dell’Ingv, del Dipartimento di Protezione Civile e anche di diverse aziende specializzate nella progettazione degli interventi e nella produzione di dispositivi antisismici.Lo facevano anche i greci e i romani. I dispositivi di isolamento sismico possono ridurre di oltre l’80% l’azione dei terremoti «e si possono applicare», spiega Paolo Clemente, ingegnere strutturista con una lunga esperienza di ricerca all’Enea, «su edifici sia nuovi sia esistenti». In collaborazione con il Politecnico di Torino, Enea ha brevettato un innovativo sistema di questo tipo, pensato in particolare per gli edifici di valore storico-artistico e ispirato, tra l’altro, a tecniche costruttive che già venivano adottate millenni fa nella Magna Grecia o dai Romani. Testimonianze documentali e archeologiche hanno mostrato infatti che alcuni templi all’epoca furono costruiti interponendo sottili strati a base di argilla o di sabbia tra il suolo e la fondazione, con lo scopo di assorbire meglio i movimenti orizzontali impressi dai terremoti.
«Le tecniche di isolamento e dissipazione sismica», aggiunge Ivan Roselli, «sono particolarmente costose se applicate a costruzioni già esistenti per le quali, di conseguenza, si tendono a prediligere soluzioni di rinforzo delle strutture, che possono essere di diverso tipo: oltre che con le classiche catene metalliche, si può rinforzare la muratura tramite iniezioni o con sistemi di fasce metalliche che ingabbiano la struttura o, ancora, applicando materiali compositi costituiti da malte su reti di acciaio o su fasce in fibra di vetro, di carbonio, di basalto o polimeriche». Moltissimi edifici in Italia, soprattutto quelli dell’edilizia povera di tanti centri appenninici situati nelle zone più a rischio, furono realizzati senza una progettazione ingegneristica, utilizzando la cosiddetta “muratura storica”, realizzata, spiega Roselli, «con una vasta gamma di tecniche e materiali.
Occorre studiare i singoli casi. Di fronte a edifici costruiti in questo modo occorre studiare i singoli casi e poi utilizzare le tecniche e gli interventi ritenuti più idonei dai progettisti per migliorarne la resistenza sismica. A volte anche approcci molto semplici possono rivelarsi risolutivi, come il rifacimento del tetto e l’applicazione di barre o fasce d’acciaio per irrobustire la muratura».Enea ha partecipato di recente a un progetto specifico, chiamato Ripara, in cui queste tecniche sono state migliorate per ridurne l’impatto visivo. Al rinforzo è stato anche integrato un monitoraggio con fibra ottica per una manutenzione tempestiva e mirata.
Una tecnica validata anche da sperimentazioni su tavola vibrante.
Nota: questo articolo contiene diversi brani estratti dall’articolo “A prova di terremoti” di Riccardo Oldani pubblicato sul numero 377 di Focus.