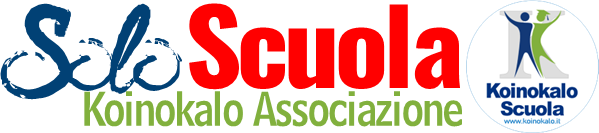Amily Whitehead oggi sembra una sedicenne qualunque, ma ha scritto la storia della medicina. Nel 2012 aveva sette anni, da due lottava contro una leucemia linfoblastica acuta contro cui nulla sembrava funzionare. Arrivò al Children’s Hospital di Philadelphia il giorno dopo l’approvazione all’uso delle cellule Car-T in uno studio clinico umano: è stata la prima paziente a riceverle e il 10 maggio scorso ha festeggiato dieci anni liberi dal cancro.
«Emily ebbe una forte reazione alla terapia, tememmo di perderla. Se fosse successo, lo studio sarebbe stato interrotto e le Car-T sarebbero rimaste un’utopia ancora a lungo», ha detto a inizio maggio Carl June, il direttore del Centro di immunoterapia della Pennsylvania University, che ha curato la bimba, ricordando quei giorni. Non è successo, Emily è guarita. E oggi le Car-T sono più che una speranza per tantissimi malati.
Il concetto di fondo è semplice: il sistema immunitario vigila continuamente sull’organismo ed elimina anche cellule alterate come quelle tumorali. Se i linfociti T, i nostri “guerrieri sul campo”, sono modificati geneticamente per riconoscere e attaccare un tumore, le cellule malate potrebbero essere spacciate. Una Car-T è proprio questo: un linfocita addestrato dall’esterno.
Cellule modificate. I linfociti T geneticamente modificati stanno rendendo sempre più efficaci e personalizzate le terapie contro i tumori. Le Car-T si ottengono in laboratorio a partire da linfociti T del paziente, estratti con un prelievo e modificati geneticamente. La modifica, attuata tramite un vettore virale, inserisce in questi linfociti il gene del recettore Car (Chimeric Antigen Receptor), una proteina in grado di riconoscere specifiche strutture presenti sulla superficie del tumore. Le cellule modificate, ottenute in questo modo, vengono quindi fatte moltiplicare in vitro e reinfuse nel paziente, pronte ad attaccare e a eliminare il tumore
L’idea di reindirizzare i linfociti T verso un preciso bersaglio tumorale risale a una trentina di anni fa, quando Zelig Eshhar, un immunologo del Weizmann Institute of Science israeliano, per primo realizzò una Car-T: lo studio apripista risale al 1993 ma come spiega Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di oncoematologia e terapia cellulare, terapie geniche e trapianto emopoietico dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma: «Quelle Car-T di prima generazione non funzionavano. La svolta è arrivata con la seconda generazione di linfociti modificati, capaci di riconoscere la proteina del tumore e allo stesso tempo di attivarsi, uccidendo la cellula bersaglio».
Terapia genica. Non è successo in uno schiocco di dita, sono serviti vent’anni per mettere a punto Car-T da poter usare nell’uomo. Poi nel 2012 il successo su Emily, salutato come uno dei più grossi avanzamenti dell’immunologia e della cura del cancro, ha spianato la strada a questa terapia genica che ha acceso tante speranze. Emily fu perfino ricevuta dall’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, come testimonial della medicina personalizzata del futuro.
Le terapie con Car-T hanno dimostrato sul campo di essere efficaci anche in pazienti senza altre possibilità di cura, registrando il 30-40 per cento di remissioni complete nei casi più complessi. Sono terapie iperpersonalizzate, perché il principio attivo si costruisce di volta in volta con le cellule del malato. Dal punto di vista dell’approvazione, sono gestite come i farmaci: nel 2019 la prima Car-T ha ricevuto il via libera in Italia e oggi le terapie rimborsate dal Servizio sanitario nazionale sono tre, per specifiche tipologie di leucemia linfoblastica acuta e linfoma e per pazienti in cui i trattamenti standard, come chemioterapia o trapianto, abbiano fallito.
Il potenziale delle Car-T. I centri autorizzati a somministrarle sono una trentina e devono garantire precisi requisiti, perché la terapia con Car-T non si può improvvisare e come sottolinea Benedetto Bruno, direttore della Divisione di ematologia universitaria al Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell’Università di Torino «non è una strada per tutti. I linfociti T del paziente, per esempio, potrebbero essere poco efficienti o in numero non adeguato. Inoltre fra la raccolta delle cellule T e la loro reinfusione passano tre, quattro settimane: per alcuni la progressione della malattia può essere così rapida da non consentire una simile attesa. In una buona percentuale di casi il tumore viene eradicato, ma in almeno metà dei pazienti la risposta può essere solo transitoria: il potenziale delle Car-T è grande, però non bisogna credere che siano una panacea».
Anche perché occorre considerare i possibili effetti collaterali, soprattutto la tossicità neurologica associata all’infusione di cellule immunitarie e la sindrome da rilascio citochinico, una reazione generalizzata dovuta a una tempesta di molecole infiammatorie, che può essere molto grave ed è quella che aveva messo in serio pericolo la vita della piccola Emily. Si tratta di problemi ormai noti e, come osserva Locatelli, «oggi conosciamo meglio gli elementi che predicono una risposta positiva alla cura.
Contro i linfomi. Per esempio, sappiamo che nei pazienti con linfomi e livelli elevati dell’enzima lattato deidrogenasi, la probabilità di una buona risposta alla chemioterapia è bassa, mentre non viene influenzata la possibilità di rispondere a una terapia con Car-T: questo può aiutare a selezionare pazienti da avviare più precocemente alla cura con linfociti modificati. Il Bambino Gesù, per esempio, partecipa a uno studio europeo che sta verificando se l’efficacia delle Car-T possa essere più alta trattando bimbi che sono alla prima ricaduta o hanno caratteristiche tumorali negative che predicono una scarsa risposta alle altre terapie».
Così, mentre in Italia vengono già trattati circa 500 pazienti all’anno, sono in corso tantissimi studi per perfezionare le conoscenze sulle Car-T, realizzarne di nuove, ampliarne l’impiego su altri tumori (sono in arrivo, per esempio, per il mieloma multiplo): «In questo momento ci sono circa ottocento sperimentazioni cliniche solo negli Stati Uniti e in Cina», informa Bruno. La ricerca galoppa, insomma, per avere Car-T sempre più mirate e potenti.
Linfoma non-Hodgkin. «Si stanno per esempio testando linfociti T modificati non con geni derivati dal topo, come quelli attuali, ma con Dna umano: sembrano più efficaci», racconta Locatelli. «Un altro approccio è equipaggiare le cellule T con due recettori anziché uno: la terapia spesso fallisce perché le cellule tumorali bersaglio smettono di esprimere la proteina che viene riconosciuta e attaccata dalle Car-T. Se i recettori sono due, la probabilità di fuga del tumore si riduce. Si potrebbero poi usare anche cellule immunitarie diverse dai linfociti T, come i linfociti natural killer (Nk), che hanno le potenzialità per ridurre gli effetti collaterali e si potrebbero recuperare da un donatore esterno».
Non è fantascienza: Katy Rezvani, dell’Anderson Cancer Center dell’Università del Texas, ha dimostrato che è possibile creare delle Car-Nk prendendo linfociti dal cordone ombelicale e riprogrammandoli. Rezvani ha testato le Car-Nk su undici pazienti con linfoma non-Hodgkin o leucemia linfatica cronica senza osservare gli effetti collaterali usuali delle Car-T; in otto casi c’è stata una risposta, in sette una remissione completa.
Costi eccessivi. Mentre si pensa al futuro, però, c’è da affrontare il macigno dei costi: per un trattamento con Car-T si possono spendere anche 300.000 euro. «Va precisato che, se la terapia ha successo e la malattia è eradicata, si risparmia l’uso di altri farmaci che, per i tumori per cui sono approvate le Car-T, sono anch’essi molto costosi», dice Bruno. «Non è facile insomma valutare il reale rapporto costo-beneficio e tutto dipende dal momento in cui si applica la cura e quindi da quali altre terapie si evitano: continuare a studiare le Car-T per ottenerne il massimo, somministrandole in ogni paziente quando è più opportuno, è una strada per renderle sempre più sostenibili».
L’altra è imparare a produrle “in casa”: oggi i linfociti T vanno congelati e spediti altrove, spesso negli Stati Uniti, per essere modificati in laboratori certificati. Ma si stanno studiando vie alternative che prevedano l’uso di linfociti T freschi, trattati sul posto. Al Bambino Gesù lo si sta facendo presso l’Officina farmaceutica dell’ospedale e nella sperimentazione clinica di fase I/II in corso sono stati già coinvolti undici bimbi. «Evitare il congelamento dei linfociti è un fattore positivo, inoltre la procedura è più rapida e per alcuni pazienti il tempo può essere un fattore decisivo. I risultati a oggi sono confortanti: in tutti i piccoli c’è stata una risposta», conclude Locatelli.