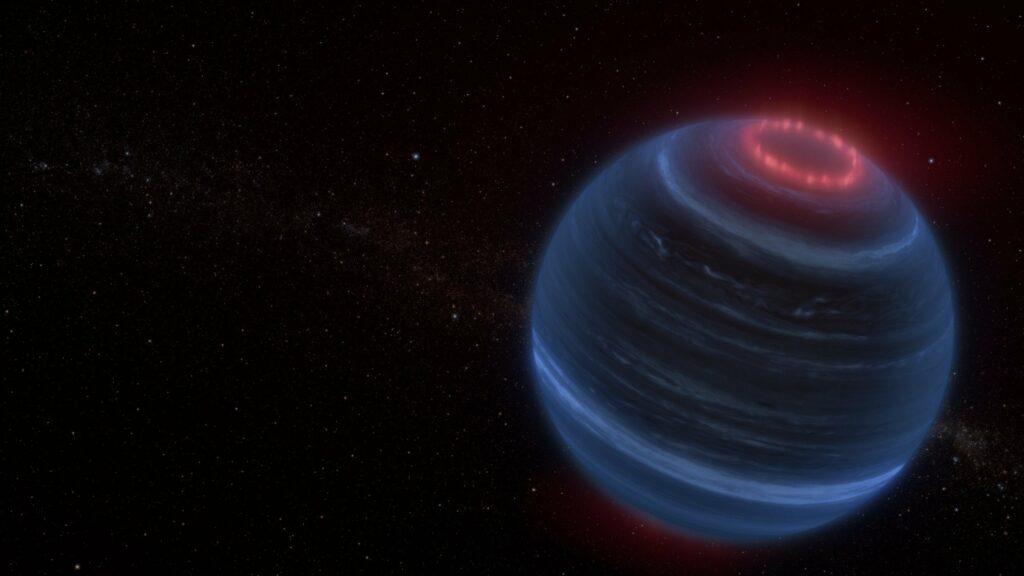Tempeste solari nelle profondità oceaniche

La recente tempesta solare che ha ci ha permesso di ammirare scintillanti aurore polari, dai Poli all’Europa centrale fino all’Africa meridionale, è stata così intensa che i suoi effetti si sono fatti sentire anche nelle profondità degli oceani.
Picco solare. Le bussole magnetiche utilizzate da Ocean Networks Canada (ONC) per monitorare l’oceano al largo delle coste canadesi hanno registrato un’intensa distorsione nel campo magnetico terrestre mentre veniva colpito da un enorme flusso di particelle espulse dal Sole.
«È un dato che rivela la potenza di queste tempeste e fornisce un’idea di come viene colpita la Terra quando si verifica questo fenomeno», ha spiegato Justin Albert dell’Università di Victoria in Canada, «Nei prossimi due anni avremo il picco del ciclo solare di 11 anni e dunque, dopo un decennio di relativa inattività, gli eventi di aurore come quelle di inizio maggio 2024 diventeranno più frequenti, anche se è impossibile fare previsioni precise».
Ricadute sulla Terra. Le tempeste solari, note anche come tempeste geomagnetiche, sono i fenomeni solari che hanno il maggiore impatto sulla Terra. Si verificano quando un’eruzione sulla superficie del Sole espelle ad alta velocità nel Sistema Solare miliardi di tonnellate di particelle aggrovigliate con campi magnetici. Quando queste espulsioni di massa coronale, o CME, arrivano sulla Terra, le particelle si scontrano con il nostro campo magnetico: un gran numero rimane impigliata, poi accelerata dal campo magneticoe infine scaricata nella nostra atmosfera.
Non solo aurore. A questo punto, le interazioni con altre particelle causano le aurore luminose. Ma questo non è l’unico effetto sulla Terra. Le interazioni generano correnti elettriche che possono causare sovratensioni e interrompere la rete elettrica. Possono causare blackout nella navigazione, nella comunicazione e nella diffusione delle onde radio. E anche altri oggetti che gravitano nello spazio, vicino alla Terra, come aerei e satelliti, vengono influenzati.
Anomalie. L’ONC dispone di osservatori sottomarini al largo delle coste orientali e occidentali del Canada, a profondità fino a 2,7 chilometri dalla superficie. Le bussole vengono utilizzate principalmente per monitorare le correnti oceaniche e i loro cambiamenti nel tempo. I dati registrati quotidianamente hanno consentito di seguire l’influenza che le tempeste solari hanno avuto sott’acqua.
Bussole in tilt. Alex Slonimer dell’ONC ha notato qualcosa di strano nei dati rilevati dalle bussole già a partire da marzo 2024, durante le prime tempeste geomagnetiche.
«Inizialmente pensavo fossero gli effetti di un terremoto, ma i cambiamenti nei dati duravano troppo a lungo e contemporaneamente in luoghi diversi», spiega Slonimer.
«Poi, esaminando i dati provenienti dai satelliti che tengono sotto controllo il Sole ho visto che quanto registrato si correlava con un brillamento solare. Quando è emersa una potente attività solare intorno al 10 maggio, i valori sono andati ancora una volta in tilt. L’effetto più pronunciato è stato rilevato su una bussola a 25 metri sotto il livello del mare, al largo della costa dell’isola di Vancouver, nel Passaggio Folger. Lì l’ago si è inclinato fino a +30 e -30 gradi».
Intensità elevata. Un evidente dato dell’influenza che può avere una CME sul nostro Pianeta. «La portata di questi dati registrati anche a centinaia di metri sotto la superficie dell’oceano», afferma la presidente dell’ONC, Kate Moran «evidenzia l’entità dei brillamenti solari di inizio maggio e suggerisce che i dati potrebbero essere utili per comprendere meglio l’estensione geografica delle ricadute e l’intensità di questi brillamenti solari».
Continua la lettura su: https://www.focus.it/scienza/spazio/le-ultime-tempeste-solari-sono-state-cosi-intense-da-essere-avvertite-negli-oceani Autore del post: Focus Rivista Fonte: http://www.focus.it