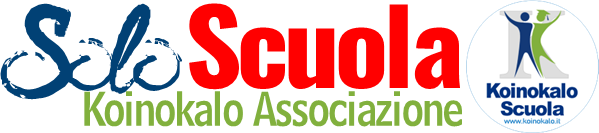Chi sparò i colpi fatali? Una ricostruzione dei fatti attraverso l’articolo “Chi ha ucciso Mussolini?” di Maria Leonarda Leone, tratta dagli archivi di Focus Storia.
La cronaca. Arrivarono in tre, nel pomeriggio, a prelevarli dalla cascina dei De Maria, nella frazione di Bonzanigo (Como), dove avevano passato la prima notte di prigionia. Li fecero salire su un’auto e, dopo pochi, lenti, chilometri in discesa, uno di loro diede l’alt. Li fecero scendere in una stradina tranquilla e li misero in piedi tra il muro e il pilastro del cancello di un’elegante residenza. Poi, imbracciando il mitra, uno di loro sentenziò: “Per ordine del Comando generale del Corpo volontario della libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano”. Claretta Petacci, appoggiandosi al suo uomo gridò: “Mussolini non deve morire!”. “Togliti di lì, se non vuoi morire anche tu”, le intimò il partigiano con i gradi da colonnello. Ma la sua arma si inceppò. Gli passarono una pistola: anche quella non sparava. Il terzo tornò indietro di corsa, dal fondo della strada, con il suo Mas e fece partire una raffica. Un occhio del duce però si muoveva, roteava verso l’alto: due colpi di beretta e fu finita.
La fine del fascismo. Intorno alle 16:10 di quel 28 aprile 1945, un uomo di mezza età e la sua amante esalarono il loro ultimo respiro davanti al cancello di Villa Belmonte, a Giulino di Mezzegra, una ventina di chilometri da Dongo, la cittadina sul lago di Como dove, il giorno prima, erano stati catturati dai partigiani della 52a brigata Garibaldi. “La fucilazione di Mussolini e complici”, si legge nel comunicato con cui, il giorno seguente, i vertici del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia rivendicarono l’ordine di uccidere il duce, “[…] è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro Paese ancora coperto di macerie materiali e morali, è la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la Patria la premessa della rinascita e della ricostruzione”.
Chi lo uccise? Era la fine simbolica del fascismo, ma l’inizio di un rincorrersi di ricostruzioni e interrogativi: chi erano quei tre uomini? Chi sparò i colpi fatali? E i fatti si svolsero davvero così come li abbiamo raccontati? In realtà quella che avete letto è solo una delle oltre trenta ipotesi al riguardo. E altre se ne aggiungono ogni volta che un nuovo particolare o un nuovo studio scompiglia le mille carte già sulla tavola.
«Il problema è che i responsabili dell’uccisione di Mussolini non furono immediatamente chiari su come andarono le cose: questo ha dato modo, soprattutto a negazionisti ed ex fascisti, di creare miti e contraddizioni sulla morte del duce, per difendere la sua immagine e il retaggio storico del fascismo», nota Amedeo Osti Guerrazzi, storico del fascismo, saggista e docente all’Università di Padova. «Ma la verità è che a uccidere Mussolini fu il “colonnello Valerio”, l’uomo inviato da Milano a prelevare Mussolini e la Petacci per fucilarli».
Chi era il “colonnello”? Per due anni, a partire dall’ultimo rimbombo degli spari nella stradina davanti a Villa Belmonte, il suo vero nome non lo seppe nessuno. Se non, forse, i diretti interessati. «Dopo la guerra, il Partito comunista nascose l’identità dell’uomo che aveva materialmente ucciso Mussolini, per paura di rappresaglie, vendette e ritorsioni», prosegue Osti. «Non dimentichiamo che stiamo parlando della fine di aprile del 1945: la guerra in Italia terminò il 2 maggio, ma c’erano ancora molti fascisti armati, in giro, e le violenze continuarono per mesi». Poi, nel 1947, durante una manifestazione del partito a Roma, gli italiani conobbero Walter Audisio. Eccolo il “colonnello Valerio”, il giustiziere di Mussolini: un ragioniere di Alessandria, ufficiale addetto al comando generale del Corpo volontari della libertà.
Crime story. Fu lui a raccontare, in una serie di cinque articoli apparsi su l’Unità, la dinamica dell’uccisione del prigioniero di Predappio, durante una missione cui avevano preso parte anche i partigiani Michele Moretti, detto “Pietro”, commissario politico della 52a brigata Garibaldi, e Aldo Lampredi, nome di battaglia “Guido”, uomo di fiducia del futuro segretario del Partito comunista italiano Luigi Longo.
LA VULGATA. Ma la versione di Audisio, che lo storico Renzo De Felice ribattezzò in senso spregiativo “la vulgata” del Partito comunista, non convinse tutti e da allora non smise di modificarsi. Un consiglio? Preparate i popcorn, perché negli anni successivi, come in una complicata serie crime, la morte di Mussolini si arricchì di particolari, nuove testimonianze e veri o presunti misteri, di ritrattazioni, di protagonisti, di diversi “colonnello Valerio” e di altri papabili uccisori del duce.
LA PISTA RUSSA. Il mistero. Mutò persino, a seconda dei racconti, l’atteggiamento del condannato di fronte alla morte, con quell’arrogante “Viva l’Italia!” della versione di Moretti o lo stoico “Mirate al cuore” ricordato da Lampredi, che mal si accordano con l’immagine dell’uomo atterrito e “docile come un canetto” descritto da Audisio.
«Non conosceremo mai le ultime parole di Mussolini, così come molti altri particolari della sua morte: se da una parte c’era la necessità dei fascisti di esaltare il loro capo, dall’altra c’era, infatti, quella dei comunisti di sminuire la sua figura», nota Osti. «È certo, però, che a forza di ripeterle, certe storie vennero tramandate e diventarono realtà».
Colpo accidentale? Torniamo per un attimo davanti al muretto di Villa Belmonte e guardiamo di nuovo la scena, stavolta seguendo, tra i tanti, il racconto dell’ex partigiano Luigi Carissimi Priori, che, dopo la Liberazione, come commissario capo dell’ufficio politico della Questura di Como, venne incaricato di indagare sui fatti del 28 aprile: “Walter Audisio, Michele Moretti e Aldo Lampredi. Tutti e tre hanno usato le armi. […] Era evidente che avevano agito in concorso tra di loro. Forse ci fu un diverbio, nell’attimo in cui avvenne il passaggio delle armi da Moretti ad Audisio […] L’ipotesi più probabile è che il primo colpo sia partito accidentalmente dal mitra di Moretti, esploso da quest’ultimo mentre l’arma gli veniva strappata di mano con violenza da Audisio”. Che a Moretti spettassero oneri e onori della morte del duce lo confermerebbe un documento, pubblicato nel 2016 ma datato 15 maggio 1945, firmato dal comandante della piazza di Como, Oreste Gementi: “Secondo gli accordi presi con la Missione militare russa, che in questi giorni ha preso contatto con il nostro CLN”, si legge, “consegnamo [sic] alla stessa, per il Museo Militare di Mosca, l’arma con la quale il partigiano “Pietro” delle formazioni garibaldine del Lario ha giustiziato Mussolini”.
Contraddizioni. Peccato che in Russia nulla si sappia di quel famoso mitra francese, un Mas modello 38, che sarebbe esposto, invece, nel Museo nazionale di Tirana dal 1957, quando Audisio lo avrebbe consegnato all’ambasciatore albanese a Roma. Che dire, allora, delle confidenze di Palmiro Togliatti, pubblicate nel 1997 dal giornalista Massimo Caprara, all’epoca segretario personale del leader del partito comunista? Togliatti, confermò Celeste Negarville, primo direttore dell’Unità, “si premurò d’una cosa soprattutto: proteggere il funzionario kominternista che è Lampredi. Non solo sottraendolo alla curiosità della gente, ma salvandolo da un’autoesaltazione che avrebbe potuto travolgerlo: sentirsi all’improvviso il vendicatore-eroe, dopo una vita grigia e ingrata. Lui ha sparato a Mussolini”.
SERVIZI SEGRETI. Nel gioco del toto-nomi si inseriscono i due rapporti di Valerian Lada-Mocarski, l’agente 441 dell’ufficio dei servizi strategici americani (Oss): dopo un mese di indagini, stabilì che al noto terzetto si sarebbe aggiunto all’ultimo anche il “Capitano Neri”, alias il partigiano Luigi Canali.
Sarebbe stato lui a finire il duce con due colpi di pistola, dopo che il “capitano Valerio” con un revolver e Moretti con il mitra lo avevano atterrato.
Criminali di guerra. Ma perché l’antenata della Cia avrebbe dovuto interessarsi alla ricostruzione della morte del duce? La risposta è semplice: indagare era un obbligo, dopo che si erano visti soffiare l’ambita preda. «Le clausole dell’Armistizio prevedevano la consegna agli Alleati dei maggiori criminali di guerra e del dittatore stesso, ma i vertici della Resistenza decisero di cogliere le opportunità del momento», spiega Osti. «Un processo di fronte a un tribunale straniero avrebbe permesso a Mussolini di parlare e di difendersi davanti al mondo, diventando un martire. Così, per evitare che sfuggisse alla pena di morte, optarono per un gesto rivoluzionario: chiudere i conti col fascismo una volta per tutte, uccidendo il suo capo, senza permettergli di pronunciare frasi storiche o altri discorsi alla nazione».
Versione ufficiosa. Esiste però una teoria alternativa, piuttosto accreditata, secondo cui gli inviati del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia furono preceduti di alcune ore nella loro missione. Da chi? Dal partigiano “Giacomo”, nome di battaglia di Bruno Giovanni Lonati. Negli anni Novanta, dopo mezzo secolo di silenzio, l’uomo raccontò di avere ucciso Mussolini la mattina del 28 aprile, davanti alla cascina dei De Maria, prima dell’arrivo del colonnello Valerio, in una missione segreta diretta dal “capitano John”, agente dei servizi segreti d’Oltremanica. Lo scopo: recuperare un compromettente carteggio segreto (mai rinvenuto) tra il primo ministro britannico Winston Churchill e Mussolini e chiudere la bocca al duce prima che, in un eventuale processo, potesse rivelare le loro presunte intese in chiave antisovietica. A questo punto, secondo Lonati, quella del pomeriggio sarebbe stata una “finta fucilazione”, organizzata per accreditare una presunta “versione ufficiale”, dal “vero” colonnello Valerio: Luigi Longo.
UN INCIDENTE. Ma doppia fucilazione, doppi problemi. Un altro memoriale, datato 2002, attribuisce la morte del duce al partigiano toscano “Riccardo”, alias Alfredo Mordini, capo del plotone che quel giorno fucilò i gerarchi a Dongo. In questo caso, la seconda esecuzione sarebbe servita a “riparare l’imprevisto” di quei colpi partiti dalla pistola di Mordini durante una colluttazione col prigioniero. «Che la sparatoria a Villa Belmonte sia stata solo una messinscena è, fra tutte, l’ipotesi meno credibile», nota Osti. «Non c’è alcun tipo di prova, a confermarla, solo testimonianze raccolte 50 anni dopo i fatti e alcuni aspetti dell’autopsia del duce che sono stati chiariti, più di recente, da analisi scientifiche».
Autopsia. Nello specifico, si tratta del riesame dell’autopsia del 1945, condotto 60 anni dopo da Pierluigi Baima Bollone, docente di Medicina legale all’Università di Torino. L’anatomopatologo smentì la presunta rigidità dei cadaveri, usata per anticipare la morte dei prigionieri alle 5:30 del mattino. E spiegò che la mancanza di cibo nello stomaco di Mussolini non significava che fosse stato ucciso prima di mangiare latte, polenta, pane e salame servitigli dalla signora De Maria a mezzogiorno. Semmai che si era limitato a fare un pasto molto leggero a causa della sua ulcera. Una spiegazione banale e poco eroica, come banali e poco eroiche possono essere, a volte, la Storia e la verità.
VAI ALLA GALLERY
Fotogallery
25 aprile 1945: le foto della Liberazione