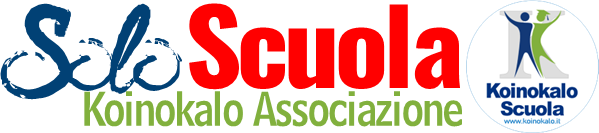L’ospite oscuro che si annida al centro della Via Lattea e che inseguiamo da quasi un secolo non ha più soltanto un nome decorato da un asterisco: ora il buco nero Sagittarius A* ha anche un volto, rivelato al mondo nella nuova immagine catturata dall’Event Horizon Telescope (EHT). L’immagine fornisce la prova visiva inconfutabile del fatto che l’oggetto è per davvero un buco nero e aggiunge indizi su come funzionano questi giganti che si trovano al centro della maggior parte delle galassie.
La rete di 8 radiotelescopi (nel frattempo diventati 11) situati in ogni angolo del Pianeta che solo tre anni fa aveva realizzato la prima immagine diretta del materiale attorno al buco nero al centro della galassia lontana M87 – in quella che fu definita la “foto del secolo” – ha raggiunto il suo obiettivo primario: catturare l’immagine del più piccolo ed elusivo buco nero al centro della Galassia, nascosto tra nubi di gas ionizzati e polveri che interferiscono con le rilevazioni dei radiotelescopi, dunque più difficile da osservare.
Giganti a confronto. Sagittarius A* che si trova a circa 27.000 anni luce dalla Terra ha una massa di 4,1 milioni di Soli concentrata in un corpo sorgente dal raggio di 60 milioni di km: più o meno la distanza media di Mercurio dal Sole, o la metà della distanza tra il Sole e la Terra.
Trovi un lungo e approfondito dossier dedicato ai buchi neri sul numero di Focus in edicola ora. Per capire meglio la notizia che stai leggendo.
© Focus
Rispetto al buco nero ritratto nel 2019 il “nostro” buco nero è un granellino di ghiaia nel cortile di casa: M87*, con le sue con 6,5 miliardi di masse solari, appartiene invece alla categoria dei “pesi massimi” dei buchi neri.
Essendo molto più grande e ingordo (divora in continuazione la materia che lo circonda generando uno dei getti di materiale più violenti mai visti) è anche molto più facile da fotografare, nonostante si trovi a circa 53 milioni di anni luce. Ecco perché era finito nel mirino dell’EHT prima del nostro vicino spaziale.
Di contro Sagittarius A* è meno attivo di M87*, cioè inghiotte meno materia, e per di più – essendo più piccolo – il suo “pasto” avviene più rapidamente. Quindi è più difficile coglierlo sul fatto.
Il confronto delle dimensioni dei due buchi neri ripresi dall’Event Horizon Telescope (EHT): M87* e Sagittarius A* (Sgr A*), al centro della Via Lattea. L’immagine mostra la scala di Sgr A* rispetto sia a M87* che ad altri elementi del Sistema Solare come le orbite di Plutone e Mercurio. Viene visualizzato anche il diametro del Sole e la posizione attuale della sonda spaziale Voyager 1, la navicella spaziale più lontana dalla Terra. M87*, che si trova a 55 milioni di anni luce di distanza, è uno dei più grandi buchi neri conosciuti. Mentre Sgr A*, a 27 000 anni luce di distanza, ha una massa di circa quattro milioni di volte quella del Sole, M87* è più di 1000 volte più massiccio. A causa delle loro distanze relative dalla Terra, entrambi i buchi neri appaiono della stessa dimensione nel cielo.
© Collaborazione EHT (H/T: Lia Medeiros, xkcd )
Nonostante le differenze i due buchi neri appaiono straordinariamente simili.
La prima foto del buco nero al centro della Via Lattea spiegata bene
[embedded content]
come leggere la foto. Insomma anche se Sagittarius A* è «mille volte più piccolo» di M87 è anche «mille volte più vicino», quindi «dovrebbe avere un aspetto molto simile a M87 nel cielo» aveva pronosticato nel 2019 a Inverse Geoffrey Bower, scienziato dell’EHT.
In effetti questa fotografia, così come quella di allora, mostra in realtà quel che vi è attorno al buco nero in prossimità dell’orizzonte degli eventi, un confine dal quale non si può più tornare indietro a causa dell’immensa forza di gravità del buco nero. Il buco nero in sé non è fotografabile perché nulla può uscire da esso – neppure qualunque forma di radiazione, luce compresa.
«Quello che vediamo nell’immagine è un disco oscuro circondato da una struttura ad anello che delinea il percorso della luce emessa dal materiale che va in orbita attorno al buco nero» spiega a Focus.it Ciriaco Goddi, docente all’Università di Cagliari, astrofisico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e membro dell’Event Horizon Telescope «questo percorso viene distorto dal forte campo gravitazionale esercitato dal buco nero stesso. La parte scura che vediamo al centro è quella che chiamiamo ombra del buco nero: è esattamente la parte che ci eravamo prefissi di osservare perché segnala la presenza dell’orizzonte degli eventi, la frontiera di non ritorno che è la caratteristica che definisce un buco nero».
Rincorsa al buco nero. Ottenere una foto di Sgr A* è stato assai più complesso rispetto alla sfida con M87*, nonostante il primo si trovi nella nostra galassia. Poiché Sgr A* è situato a circa 27.000 anni luce da noi, occupa una porzione di cielo di 52 microarcosecondi: ha all’incirca le dimensioni di una ciambella sulla Luna vista dalla Terra.
I 300 scienziati coinvolti nel consorzio EHT hanno osservato Sgr A* per più notti nel 2017 raccogliendo dati da molte ore di osservazioni di fila – come quando si usa una fotocamera a lunga esposizione. È stato però necessario sviluppare nuovi strumenti molto sofisticati per tener conto del movimento di gas attorno al buco nero. Il gas che si trova nelle vicinanze dei buchi neri Sgr A* e M87* si muove alla medesima velocità (prossima a quella della luce), ma impiega settimane a orbitare attorno a M87*, che è molto più grande, mentre completa un’orbita attorno al più piccolo Sgr A* in pochi minuti.
Ciò significa che la brillantezza e il percorso del gas attorno a Sgr A* cambiavano molto rapidamente proprio mentre gli scienziati di EHT cercavano di osservarlo. Un po’ come cercare di fotografare un gatto che rincorre rapidamente la sua coda, o un bambino che corre. L’immagine di Sgr A* che vediamo è una media delle diverse immagini che il team di scienziati ha estratto.
Una nuova conferma per la teoria di Einstein. «Abbiamo due galassie completamente diverse e due buchi neri di masse molto diverse, eppure, vicino al loro confine, questi buchi neri sono incredibilmente simili» spiega Sera Markoff, co-direttrice del comitato scientifico di EHT e professoressa di astrofisica teorica all’Università di Amsterdam. «Questo ci dice che la Relatività Generale governa questi oggetti da vicino e che ogni ulteriore differenza che vediamo deve essere dovuta alle differenze del materiale che li circonda».
Questa simulazione è utile per mettere in evidenza la nostra posizione nella Galassia. Ci troviamo a circa 25mila anni luce dal centro, dove c’è Sagittarius A*.
© Nick Risinger/Nasa
L’EHT. L’immagine è insomma la prova schiacciante del fatto che quello al centro della Via Lattea è proprio un buco nero, un’ipotesi che ha decenni di anzianità e che trova finalmente conferma. Per ottenerla si è ricorsi, come per M87*, all’EHT o “telescopio per l’orizzonte degli eventi”, l’unico strumento esistente in grado di fotografare i buchi neri supermassicci.
Si tratta di un network di più radiotelescopi in cinque continenti collegati mediante la tecnica di Interferometria a Base Molto Ampia (VLBI) che consente di ottenere una risoluzione angolare in grado di osservare l’orizzonte degli eventi del buco nero e sincronizzare i dati provenienti dalle singole stazioni riceventi così da ottenere un’unica fotografia di grande dettaglio.
Così facendo è come se si lavorasse con un radiotelescopio grande come tutta la Terra in grado di osservare una ciambella sulla Luna. Anche in questo caso, così come per M87, l’immagine è importante perché essa è in grado di fornire una misura molto precisa della massa, del diametro e della rotazione del buco nero con una precisione mai ottenuta prima.
Fare rete. Per provare a fotografare i buchi neri si utilizzano radiotelescopi e non telescopi ottici, perché i primi riescono a catturare le radiazioni nonostante la presenza di polveri che circondano il buco nero che impediscono la fuoriuscita della luce visibile o di altre radiazioni. Le prime osservazioni dal centro della galassia furono compiute agli inizi degli Anni Trenta del secolo scorso dal padre della radioastronomia Karl Janky, ma i primi veri radiotelescopi furono costruiti soltanto dopo la Seconda guerra mondiale, sfruttando le tecniche radar sviluppate durante il conflitto.
L’idea di collegare telescopi lontani e distribuiti in varie parti del mondo, come per formare un unico grande telescopio con un’antenna del diametro virtuale di migliaia di chilometri, risale però agli anni ’70. Nel 1974, per la prima volta Bruce Balick e Robert Brown collegarono tra loro quattro radiotelescopi nel West Virginia (Usa), e riuscirono a osservare Sagittarius A* con una risoluzione inferiore a un secondo d’arco (come guardare un cd da 40 km di distanza).
Il passo successivo fu separare i radiotelescopi non più di decine ma di centinaia o migliaia di km (la a Very-Long Baseline Interferometry, Vlbi). Nel 1995 grazie a due telescopi posti a 1000 km di distanza, uno nelle Alpi francesi e uno in Sierra Nevada, si arrivò a stimare per la prima volta le dimensioni di Sagittarius A*. Misurazioni più accurate avvennero nel 2007 con il lavoro sincronizzato di 3 antenne americane (Hawaii, California, Arizona). Il resto è la storia più recente di cui abbiamo scritto.
VAI ALLA GALLERY
Fotogallery
La storia delle immagini dei buchi neri
[embedded content]
Ha collaborato Luigi Bignami